Le avventure di Holmes sono diventate presto un mito, una fiction ripetuta, appropriata e memorizzata e che, alla fine, è diventata una parte integrante dell’eredità culturale europea e americana fino a divenire un fenomeno mondiale
Domani arriva sul grande schermo italiano Sherlock. The Abominable Bride, che anticipa la quarta stagione della fortunatissima serie prodotta dalla BBC. Dopo 129 anni dall’uscita di Uno studio in rosso, Sherlock Holmes continua ad attirare l’attenzione di tutti e ad essere rimaneggiato in vari modi. Solo quest’estate, per esempio, è uscito Mr Holmes, adattamento cinematografico del romanzo A Slight trick of the mind di Mitch Cullin che ci mette davanti ad uno vecchio detective ormai in pensione, con tutti i problemi della vecchiaia. Fra tutti la perdita di memoria: Holmes, interpretato da Ian McKellen, è logorato dallo sforzo di ricordare i motivi (collegati al suo ultimo caso) che lo hanno portato a lasciare Londra e smettere di essere un detective.
Di adattamenti fedeli o meno fedeli, rielaborazioni, omaggi (si pensi a Guglielmo di Baskerville, protagonista de Il nome della rosa) e corruzioni è pieno il mondo: dai film (meno fedeli) di Guy Ritchie, alle serie come Elementary, ai romanzi come Mycroft Holmes di Kareem Abdul-Jabbar e Anna Waterhouse. A ben vedere anche dietro il Dr. House della serie omonima possiamo trovarci un po’ di Sherlock Holmes; e lo dice bene Aldo Grasso sul corriere: «Si può dire che l’adattamento televisivo più riuscito della figura di Sherlock Holmes sia quello del dottor House? Ormai, quando vediamo in azione un investigatore geniale ma misantropo, tanto brillante nella risoluzione dei casi quanto incapace di gestire le più basilari relazioni umane, è impossibile non pensare al medico più talentuoso della storia della tv. È quello che succede con Sherlock, nuova miniserie inglese». E che dire di Dr. Who? Forse i richiami sono meno lampanti, ma per qualcuno ci sono eccome al punto da sperare in un cross-over.
Philip Weller, nel suo Life & Times of Sherlock Holmes, scrive addirittura: «Sono stati fatti più film su Sherlock Holmes che su ogni altro personaggio della letteratura mondiale». Possiamo allora, senza troppi problemi, parlare di mito-Holmes: «le avventure di Holmes diventarono presto un mito, una fiction ripetuta, appropriata e memorizzata e che, alla fine, è diventata una parte integrante dell’eredità culturale europea e americana fino a divenire un fenomeno mondiale. […] Come figura letteraria, Sherlock Holmes è stato nutrito da scritture precedenti ed è diventato, quasi contemporaneamente alla sua apparizione, una figura mitica, modellata dalle sue rappresentazione in letteratura, illustrazioni, teatro e successivamente al cinema e in tv. Per questo il mito holmesiano non è qualcosa creato solamente dal racconto di Arthur Conan Doyle ma è la somma di tutte le sue variazioni su ogni tipo di media» (Natacha Levet, Sherlock Holmes: De Baker Street au grand écran, Flammarion, 2012).
Una testimonianza di quanto il mito-Holmes abbia avuto risonanza può essere l’emblematico caso delle migliaia di lettere che riceveva il suo autore da persone che chiedevano aiuto a Sherlock Holmes; oppure all’ondata di lettere di protesta seguite alla morte di Holmes in The final problem (sembra quasi di essere in Misery di Stephen King, eppure non era così inusuale: Charles Dickens ricevette molte lettere dai suoi lettori che lo imploravano di non uccidere Little Nell, eroina di The Old Curiosity Shop) . Nella sua autobiografia Conan Doyle racconta di una di queste lettere che iniziava con “You Brute”. Persino sua madre si oppose scrivendogli: “You won’t! You can’t! You mustn’t!”
In anni più recenti questa pratica si è trasformata in quella della fan fiction (o Fan Friction, come è stata chiamata sul New Yorker in un articolo su Sherlock e il suo pubblico di Emily Nussbaum): in un sondaggio del 2011 riportato su Sherlock and Trasmedia fandom sono state censite 4305 fan fiction solamente sul sito (e su una storyline basata sulla serie tv della BBC) fanfiction.net e il numero oggi si è più che decuplicato.
Si possono allora applicare anche a Sherlock Holmes alcuni dei ragionamenti che Gianluca De Sanctis su doppiozero fa su Star Wars e la cultura convergente: il mito-holmes, come il Jedismo, «è un prodotto di quella che Henry Jenkins ha chiamato «cultura convergente», che nasce e prospera attraverso il web, dove i fan si uniscono, mettono insieme le loro passioni, discutono, insomma, “convergono” sull’oggetto del loro desiderio, esercitando su di esso il proprio potere creativo. Ogni anno la saga viene celebrata in tutto il mondo da migliaia di fan che organizzano convention, raduni, vere e proprie parate in costume (l’equivalente moderno di un rito antico?). Non si tratta di cerimonie religiose nel senso proprio del termine, ma il confine tra il fan e il devoto può essere molto labile».
La BBC, cavalcando l’onda e confondendo un po’ realtà e finzione, ha anche aperto il blog ufficiale di John Watson, ovvero quel blog in cui nella serie il dottore racconta le avventure di Sherlock Holmes. Con una strategia molto simile a quella di Dawson’s Desktop: un sito web che riproduceva i file nel computer del personaggio principale di Dawson’s Creek (1998), grazie al quale i visitatori potevano leggere i suoi messaggi di posta elettronica, sbirciare nel suo diario, etc.
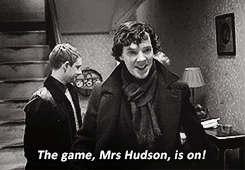
Ma da dove nasce il mito-Holmes?
La gestazione del personaggio Sherlock Holmes nasce dalla fusione di alcuni modelli letterari molto forti e la trasfigurazione del dr. Joseph Bell che insegnò a Conan Doyle il metodo deduttivo mentre studiava medicina a Edimburgo. Questo stesso metodo è quello che poi fu reso famoso dal detective di Becker Street. Stando alle descrizioni dell’autobiografia di Doyle anche la figura fisica di Holmes è stata modellata su quella di Bell.
Per quanto riguarda invece le reminiscenze letterarie, invece, sicuramente Doyle guardava ai modelli in terra inglese: il detective Dupin, nato dalla penna di E. A. Poe, e i lavori di Wilkie Collins, considerato l’inventore della detective story in Inghilterra. Meno noto è invece un fondamentale modello francese: Èmile Gaboriau, considerato negli anni 80 dell’Ottocento, il vero inventore del giallo. Il suo detective, Monsieur Lecoq, mostra lo stesso genio analitico e la stessa logica deduttiva di Holmes.
Il successo della saga di Sherlock Holmes, dopo la prima apparizione nel 1887 sulla Strand Magazine di Uno studio in rosso, fu esponenziale ed immediato. Le ragioni sono facilmente individuabili nel contesto sociale della fine dell’Ottocento. L’Inghilterra di quel periodo era una nazione che viveva una intensa industrializzazione con il conseguente esasperato inurbamento: Londra diventò nel giro di pochi anni una città sovraffollata, dove il tasso di povertà era molto alto e le cattive condizioni in cui viveva la maggior parte della popolazione portava ad un altissimo tasso di criminalità che spesso veniva anche romanzata ed accentuata dalla stampa del tempo (si pensi, emblematicamente, alla storia di Jack lo squartatore). A questo si aggiungeva la sfiducia nella polizia (a nulla era servita la creazione della Metropolitan Police nel 1929) fra cui regnava ubriachezza e corruzione.
Non si deve poi sottovalutare la grande ansia che produceva l’immediato e sempre continuo cambiamento negli stili di vita delle persone prodotto dalle nuove tecnologie che provocavano un certo timore nelle persone.
Tutti questi elementi possono essere facilmente trovati nei libri di Conan Doyle: Sherlock Holmes è un uomo che riesce a portare alla vittoria della razionalità, a sconfiggere il crimine, a mostrare che nulla di irrazionale è possibile (e questo è un fattore molto importante se si considera che nell’Inghilterra di fine ottocento l’horror fiction era un genere molto diffuso), e che le nuove tecnologie possono essere una risorsa per l’uomo che sa come utilizzarle. Sherlock Holmes insomma era una sorta di incarnazione del positivismo: rappresenta il credo vittoriano secondo il quale da una stanza a Londra, un gentiluomo inglese può controllare con stile ed efficienza tutto quanto accade nel mondo. Addirittura la morte: con il poliziesco l’elaborazione letteraria del lutto offusca il connotato di compianto tipico della narrativa larmoyante ottocentesca e si orienta a mettere sotto accusa la morte, colpevolizzandola, per farla poi oggetto di castigo postumo. L’evento ferale perde le sue risonanze metafisiche e non è più un mistero insondabile, ma un enigma che le risorse dell’intelletto sono chiamate a risolvere.
Altra caratteristica fondamentale per il successo di Sherlock Holmes è infatti proprio il suo essere un gentleman e Conan Doyle sottolinea molto questo aspetto nei suoi romanzi: ha una perfetta conoscenza di Londra, è a suo modo patriottico, viene da una famiglia dabbene, conosce le lingue e la musica (suona il violino), conosce Shakespeare e lo cita in modo quasi spropositato, è colto (nonostante la descrizione che ne dà il Dr. Watson nelle prime pagine di Uno studio in rosso notando come la sua conoscenza sia assolutamente settoriale: non sa nulla di letteratura, filosofia, politica, non conosce nemmeno il sistema copernicano. Nel corso del tempo Holmes, però, dimostra di non entrare perfettamente in questa descrizione: dimostra di allargare lo spettro della sua conoscenza, e non si capisce se sia l’influsso dell’amicizia con Watson, o il tentativo del suo autore di renderlo meno “strano” agli occhi dei suoi lettori).
Anche in Italia la recezione fu insolitamente immediata: le prime traduzioni risalgono al 1895 nella “Biblioteca Azzurra”, collana di narrativa della Casa Editrice Verri, che raccoglieva i romanzi della prima fase (quelli fino alla morte temporanea del protagonista). Il successo e la grande diffusione iniziarono però solamente quattro anni più tardi quando la Domenica del corriere iniziò a pubblicare a puntate le avventure di Sherlock Holmes.
Il successo è tale che diventa comune l’espressione “essere uno Sherlock”, ad indicare il possesso e l’estrinsecazione di capacità analitiche o genericamente raziocinanti. Si esalta più che il poliziotto, il gentiluomo e il dilettante. È questo un fatto da tenere in considerazione: uno dei segreti del successo del mito-Holmes è il fatto che il suo metodo deduttivo è virtualmente alla portata di tutti (elementare, Watson): pensiamo per esempio allo Sherlock di Elementary (2012, CBS) che cerca di insegnare tutti i trucchi del mestiere al suo Watson (qui in versione femminile; e non è l’unico personaggio a subire metamorfosi o fondersi con altri, anche il setting cambia, non più l’Inghilterra, ma la Grande mela).
A testimoniare la fortuna del detective Holmes sta anche il fatto che fu subito trasformato in un soggetto teatrale, per poi finire in radio e, successivamente, in televisione. Ognuna di queste trasposizione ha contribuito in parte alla formazione del mito-Holmes: lo stereotipo che noi tutti abbiamo in mente, infatti, non nasce solamente dalla penna di Conan Doyle. Il famoso cappello stile deerstalker e il tipico cappotto sono entrati infatti nell’immaginario comune grazie alle illustrazioni di Sidney Paget sulla rivista The Strand a partire dal 1891. Riprendendo l’iconografia di Paget, Frederic Dorr Steel, illustrando le short stories apparse sul giornale americano Collier’s Magazine dal 1903, inserì un altro elemento destinato a far storia: la pipa calabash

Tutti questi elementi furono resi famosi ed entrarono ufficialmente nel mito-Holmes grazie agli spettacoli teatrali di William Gillette, che interpretò Sherlock in circa mille performance fra il 1899 e il 1935. Insieme al cappello, al cappotto e la pipa, Gillette sdoganò un altro elemento che farà storia: la vestaglia da notte che il detective indossa abitualmente in casa.
Gillette divenne così popolare nei panni di Holmes che la catena si invertì e gli illustratori iniziarono a prendere spunto da lui per disegnare il detective di Backer Street. Persino Orson Welles riconobbe nel ’39 che gli spettacoli di Gillette facevano parte a tutti gli effetti del canone holmesiano. Fu con l’ultimo radiodramma di Gillette che nacque uno degli intercalari più tipici del mito-Holmes, la frase, mai presente nei libri, “Elementare, Watson!”.
Il primo volto cinematografico fu quello di Basil Rathbone, protagonista di quattordici film realizzati fra il 1939 e il 1946. Mentre i primi due della serie erano molto fedeli al setting vittoriano, per i successivi (a budget e qualità inferiori) si decise di ambientare le storie nell’Inghilterra contemporanea, quindi durante la seconda guerra mondiale e troviamo Sherlock Holmes e il Dr. Watson anche a dare il loro aiuto contro i nazisti. L’elemento iconico introdotto da Rathbone fu la lente di ingrandimento, che mai prima era stata associata la personaggio di Holmes.
Il successo fu molto grande e sicuramente per gli stessi motivi della saga originale. L’interpretazione di Rathbone comunque divenne emblematica del personaggio tanto che Eve Titus nel 1958 realizzò proprio ispirandosi a Basil Rathbone il protagonista del suo libro per bambini Basil of Baker Street (poi divenuto un lungometraggio animato nell’86 grazia alla Disney e distribuiti in Italia con il titolo Basil l’investigatopo).
Sul piccolo schermo, invece, Sherlock Holmes è arrivato con il viso di Jeremy Brett che, a differenza di Gillette e Rathbone, ha deciso di ridare nuovo spesso psicologico al personaggio di Holmes sottolineando il suo lato bohémien, con tendenze maniaco depressive. Il fatto che Sherlock facesse uso di droghe era stato ignorato nelle rappresentazioni precedenti. La linea seguita da Brett sarà poi anche quella dei più recenti adattamenti televisivi (Sherlock e Elementary). L’uso di droghe per Holmes (come per quasi tutti i personaggi dei romanzi fin de siecle) è un rimedio alla noia della vita quotidiana. Ma, come spiega Sherlock stesso, ne Il segno dei quattro, lui non è un drogato, è dipendente invece dal risolvere misteri, la cocaina rappresenta solamente un palliativo a questa dipendenza.
Brett recepì meglio di altri la complessità del personaggio e riuscì ad interpretarlo a tutto tondo, affiancando i lati più sociopatici e nevrotici a quelli umoristici e galanti.
Passando invece alle versioni animate non possiamo non ricordare quella giapponese con una co-produzione italiana realizzata, in parte, da Miyazaki fra il 1984 e il 1985, chiamata Sherlock Hound (Il fiuto di Sherlock Holmes in Italia, in onda su Rai 1) perché i personaggi sono diventati di fattezze animali.
Sembra che il fascino e la fortuna del mito-Holmes allora non vengano meno nel tempo, e anzi non faccia altro che rinnovarsi, da romanzi a videogame a fumetti, le riscritture e trasposizioni sono davvero infinite. E qui torniamo da dove siamo partiti: uno dei prodotti migliori degli ultimi anni è sicuramente Sherlock prodotto dalla BBC nel 2010. Ad ora sono state prodotte tre stagioni da tre puntate ognuna e uno speciale di natale andato in onda in UK il primo gennaio e, straordinariamente, da noi sarà al cinema il 12 e il 13 gennaio.
Come i film di Ruthbone anche Sherlock si attualizza, è infatti ambientato nella Londra contemporanea. Nella caratterizzazione dei personaggi segue però il modello di Brett. A venire enfatizzato è soprattutto il rapporto di amicizia fra Holmes e Watson fino a diventare uno dei punti principali della narrazione (lo testimoniano le numerose battute dei personaggi su una loro (im)probabile relazione omosessuale e le numerosissime fan fiction in questo senso).
Pur aggiornando l’ambientazione la serie Tv inglese rimane molto fedele (molto più di altre) alla saga di Conan Doyle: anche qui Sherlock usa tutte le più nuove tecnologie, ha letteralmente una mappa di Londra in testa (che viene visualizzata sullo schermo), ma il punto di forza resta lo scavo psicologico del personaggio – magistralmente interpretato da Benedict Cumberatch – che, per quando fedele alla mitologia holmesiana, non è un puro stereotipo. Contribuisce a ciò anche una inedita consapevolezza metafinzionale: gli autori di Sherlock spesso giocano con il mito-Holmes e l’immaginario ad esso legato ironizzandoci su (come, per esempio, quando Watson costringe Sherlock ad indossare il famoso cappellino per poter essere riconosciuto dai fan, oppure, nell’ultimo episodio dice di essersi fatto crescere i baffi per somigliare alle illustrazioni che accompagnavano i suoi racconti, o, infine, Mrs Hudson che si lamenta di essere solamente un “plot device”).
Fedeltà al modello, dicevo, ma non pedissequamente: nell’aggiornare il setting, anche i casi si adeguano di conseguenza. Una delle forze di Conan Doyle era di giocare con le paure dei suoi contemporanei e per far ciò attingeva a vere storie di cronaca nera per ispirare i suoi racconti. Sherlock modifica quelle paure con quelle di noi uomini del terzomillennio, giocando con l’iconografia del terrorismo, con allarmi bomba (con un chiarissimo riferimento all’attentato nella metropolitana di Londra), ostaggi e gruppi criminali.
Sherlock, insomma, è solamente uno dei tanti e rappresentativi casi che mostrano come quello di Sherlock Holmes sia a tutti gli effetti un fenomeno crossmediale, un mito, più vivo che mai, che continua a stimolare la fantasia di autori e pubblico (ammesso che sia ancora lecito, in casi come questo, operare questa distinzione).
1 Comment
Comments are closed.