Ce ne potevamo scordare? Sia mai! Puntuale come tutti i riti che si rispettino: la lista dei consigli da regalare per Natale. L’autobiografia illustre e l’ultima novità, la curiosità antropologica e il classico, la scrittura perturbante e il perfetto racconto in tema: libri, naturalmente. Belli – anche per tenerli per sé
Paolo Zardi, La meccanica dei corpi (Neo Edizioni)
“Erano in gioco l’innocenza e il peccato originale, argomenti che tenevano banco da tre millenni”
In cinque movimenti, ognuno caratterizzato da misura e ineluttabilità, Paolo Zardi affronta il tema della perdita: così è per Lucia, che decide, da giornalista brutalizzata dallo sfruttamento e dalla competizione, di osare il salto di specie, e sacrifica il mondo da cui proviene, dandone in pasto (tanto ai lettori quanto alla redazione) una versione orrenda e perfetta. Così è per Silvia, che paga di sponda l’altruismo del suo Andrea: rimasto per giorni in un altrove di morte e quasi per miracolo tornato indietro, ma ormai tragicamente non-più-suo. Così è per il rampante manager dall’esistenza cui il successo arride – perfetto, talmente perfetto che il suo presente finisce per risultargli vacuo, finché non decide di volgere la sua volontà di potere a sperimentare la proibizione della vita con una amante.

C’è, nel meccanismo messo in piedi da Zardi, una precisione di intenti e di dinamica cosicché, in ognuna delle storie narrate, il libero arbitrio umano non finisce solo per definire il confine del possibile, ma ogni scelta, alla luce delle inevitabili conseguenze, costringe anche a una rivalutazione del concetto di “giusto”.
Che sia decidere di non voler rischiare di attraversare il tempo (dunque di infrangere l’ultimo dei misteri), o di utilizzare le risorse estreme per andare a guardare in faccia un figlio perduto, i personaggi di Zardi percorrono il loro destino calcando le tracce di altre narrazioni: dalla Lotteria di Shirley Jackson, a Buzzati, al Flaubert di Madame Bovary. C’è, in questo continuo riverbero, una avvincente densità.
“Leggere, pensai, era pensare con le parole di qualcun altro, ed era impossibile che, dopo quella immersione, non rimanesse qualcosa addosso”.
Antonia Arslan, Il destino di Aghavnì (Ares edizioni)
“Il morbido tappeto perduto, coi suoi rossi colori e la sua intricata trama di disegni e di simboli, rappresentava la perdita di tutto il mondo che l’aveva cullata – e allevata per un futuro che si era rivelato illusorio e pieno di inganni”
Di nuovo, la voce di Antonia Arslan è forte e incantatoria in questo breve romanzo perfettamente natalizio: una sorta di prequel a quello che è stato il libro (La masseria delle allodole) che l’ha rivelata al grande pubblico. Compaiono, infatti, anche se di sfuggita, Sempad, Yerwant e la bella Sushanig, a cornice della storia della giovane Aghavnì: un nome predittivo e parlante che prefigura la vicenda di una vita innocente e precocemente sacrificata (una “colombella”, appunto, come vuole la lingua armena).
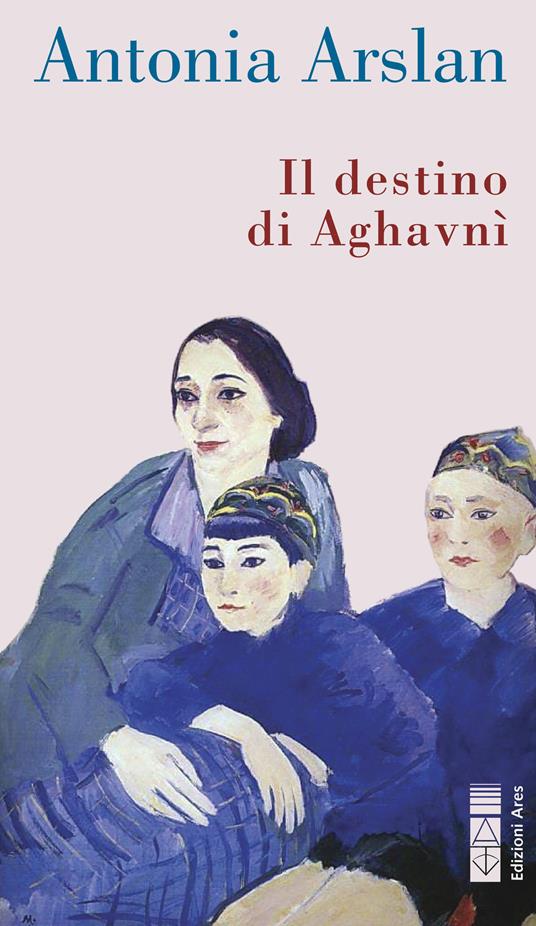
Un po’ presagio rispetto al genocidio che travolgerà l’intera comunità, un po’ parabola sull’ignavia umana, il racconto della scomparsa inspiegabile della ragazza, del marito e dei due figli in una piccola città al centro dell’Anatolia diventa il terreno dove trovano luogo i grandi temi della letteratura di Arslan. La necessità di dare un senso agli accadimenti più atroci, la forza dell’alleanza (interpretata dalla piccolissima Zabel), la facoltà (misteriosa e potente) del rito per restituirci a noi stessi: un perfetto gioiello sulla necessità di ricordare, per non perdere la propria umanità.
Lucia Galasso, Storia e civiltà del pane (Espress edizioni)
C’era una volta il pane più antico di sempre: una galletta di trentamila anni, ottenuta dalla tifa, una pianta lacustre (la cui macinazione, chissà, è anche capace di tornare di moda, prima o poi…). Quello che è certo è che, per un sacco di tempo, i nostri antenati consumarono pani secchi, cucinati sulle pareti dei forni: la galletta era provvidenziale, alimento facile soprattutto da trasportare e conservare – ed era cosa non di poco conto, per le logiche di una umanità necessariamente in cammino.
Come si arrivò, poi, alla lievitazione, è uno di quei passaggi che archeologi e antropologi alimentari (tale è Lucia Galasso, che a questa ricerca ha dedicato una ventina d’anni di documentazione) individuano nel fatale errore generativo.
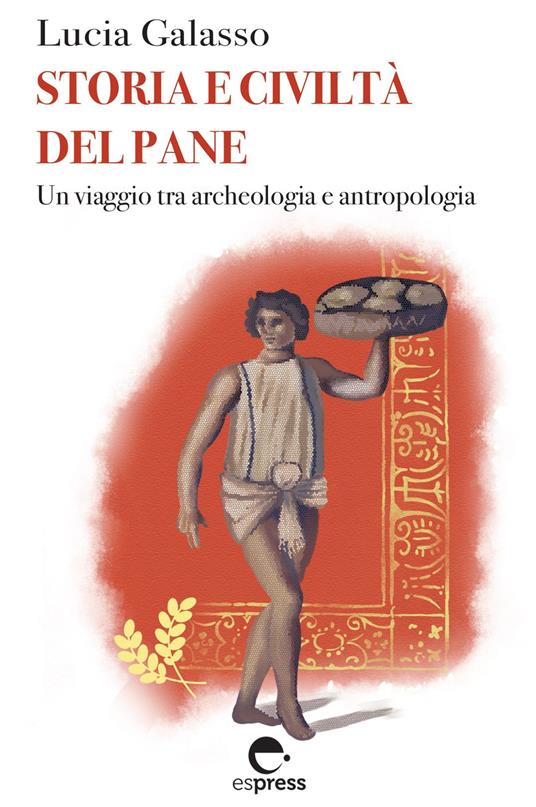
Dovette accadere, in quella mezzaluna fertile che aveva già scoperto il processo di fermentazione, che qualcuno si dimenticasse l’impasto da cuocere dentro un recipiente usato in precedenza proprio per lavorare la massa molle della birra, ritrovandosi (chissà: un bel mattino?) la sorpresa dell’aumento di volume: così il pane lievitato, per la gioia dei denti più ammaccati, entrò nella consumazione alimentare; le rive del Nilo ne diventarono una palestra di pratica, anche se fu l’Grecia ad accaparrarsi la palma di campionessa olimpica di lievitazione.
Il resto è un salto di percezione, perché il pane diventa simbolo, strumento, rito. Così si incontrano pani pasquali, pani funebri, pani matrimoniali, riti dei quattro cantoni d’Italia – e, con gran cognizione, una mappatura dei legami che questo cibo ha istituito con la nostra vita. Tant’è che (prima del tempo dei preparati) era noto che ad ogni età si attagliava il proprio pane.
Del resto, afferma l’autrice, a cos’è che ci siamo rivolti in massa nel tempo più buio della nostra epoca? Ricordare gli scaffali del lievito sistematicamente svuotati nei mesi pandemici non è che una restituzione di senso a un atto (l’impastare) antropologicamente significativo: ancora una volta, il pane – ovvero, la vita.
Alessandro Mezzena Lona, Il cuore buio dei Miracoli (Ronzani)
“Il miraggio della ricchezza ha cancellato la paura dell’Apocalisse. Nessuno si è preso più l’impegno di tramandare questi presagi di sventura”
Quando Blaise Panafieu, tentato autore di un libro talmente sofisticato che si rifiuta di essere scritto, viene spedito dallo zio nella casa natale di Dino Buzzati per prendere in consegna un misterioso quadernino di annotazioni autografe, non immagina certo di trovarsi all’improvviso al centro di un evento apocalittico.

Già la stazione sembra abbandonata in un posto fuori dal mondo; per di più, la stanza che gli viene assegnata nella vetusta dimora – per quanto affascinante – pare fatta apposta per covare l’ombra di fantasmi dimenticati. A metterci il carico da novanta è una processione di incontri sfuggenti e inquieti: una tale (bellissima) Adelaide, un vecchio eremita, un parroco dall’incarnato spettrale: il fatto è (tocca ammettere all’umanista illuminato Blaise) che esistono misteriosi legami tra fatti apparentemente banali, e la montagna, così semplicisticamente identificata come luogo di fuga, in verità luogo di fuga lo è veramente, ma per insospettati eserciti di spiriti e luciferi e presenze che soltanto in un luogo lontano possono mantenere la propria nascosta sopravvivenza sovrannaturale.
Dunque le domande che Panafieu si pone (mentre la tempesta Vaia stravolge i connotati al paesaggio e al perimetro dell’esperienza della paura), lungi dal trovare risposta, aprono semmai altre voragini: esistono altri miracoli che Dino Buzzati raccontò nel suo ultimo, leggendario, libro? Ci fu qualcosa di preveggente nella sua scrittura? E la cripta di Santa Rita da Cascia cosa c’entra con l’immaginazione dello scrittore? Ma, soprattutto: il quaderno?
Forse, il vero mistero è perché – scientemente – l’uomo stia barattando l’antica alleanza con la terra che gli permette di esistere in cambio della soddisfazione del proprio presente.
Mario Benedetti, La tregua (Nottetempo)
“Forse il nocciolo della mia inquietudine è semplicemente nell’aver toccato con mano che può sentirsi più a suo agio con persone giovani, soprattutto con un uomo giovane. E un’altra cosa ancora: ciò che ho visto non è nulla, ma in compenso è molto ciò che ho intravisto, e ho intravisto il rischio di perdere tutto”
Martín Santomé è un uomo ordinario: non l’amore, ma il sesso avventizio, una volta a settimana (“per questione di natura”, si racconta. Così tacita bonariamente la sua basica attitudine predatoria); il lavoro, tanto, per la pensione (e: dopo? dopo una vita costruita per domesticazione dentro una routine di ferro, che sarà? chiederselo è proibito); la famiglia per contiguità e abitudine (ma guai approfondire l’intimità con i figli, di cui non sa nulla di nulla).
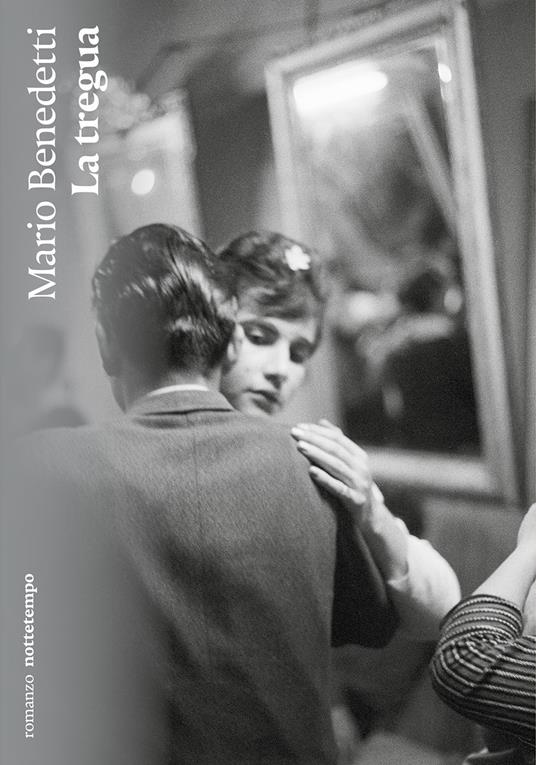
La sua postura nell’esistenza è quella di un dovizioso travet, attento a sorvegliare e conservare intatto il suo pacificato stordimento esistenziale: mai nulla di troppo, né di troppo poco rispetto alle convenzioni.
E, dunque: il machismo di default, l’omofobia di default, il dito del giudizio alzato di default.
E un bell’altare alzato intorno alla memoria della moglie, santa – e morta, naturalmente, da trent’anni.
Così, quando una vita viva inciampa nella sua, Santomé tenta di ripararsi dall’esondazione dietro ai soliti argini: la chiama per cognome, la sottopone a costante giudizio, la paragona (ovviamente) alla cara inarrivabile defunta, la blandisce, decide per lei.
Ma.
Un libro-paradigma: il fastidio e la resa, la tensione e la perdizione. E un doppio salto di bravura mortale dell’uruguayano Mario Benedetti (cui Nottetempo ha dato una seconda vita nel suo catalogo).
Mircea Cārtārescu, Melancolia (La Nave di Teseo)
“Gli piacevano i libri voluminosi, cartonati, che assorbivano di più la luce, dorata all’inizio poi sempre più melanconica e fioca, in modo che soprattutto d’inverno, quando la sera calava più in fretta, filtrata dal folto fitto dei rami spogli degli alberi, le pagine lucide si ammantavano della luce del crepuscolo, in quell’ombra piena di rumori lontani. E allora tutto sembrava improvvisamente immobile, racchiuso in una goccia d’ambra come gli insetti e i fiori di un tempo lontano, immutabile e immortale e assai triste, eppure più desiderabile della felicità, perché durevole”
L’infanzia è un mondo immaginifico e misterioso. Lo è, soprattutto, perché di quella vista non resta ricordo tangibile; a meno che non succeda, come accade in questo libro, che una voce decida di spingersi in un territorio scomparso per tirarsi dietro una narrazione che, rivelata, finisce per tornare ad appartenere.
È qualcosa di straniante e profondo quello che Cārtārescu riesce a esercitare attraverso la scrittura; non è solo una regressione, è una riappropriazione, acciuffata per un lembo, di una parte sprofondata della memoria: il rapporto con i giocattoli, il senso delle parole, la deformazione fantastica dello spazio, le paure stravolgenti e atroci, la solitudine e la scoperta di un immaginario selvaggio.

Tre perfetti movimenti per incontrarsi di nuovo: nel bambino che attende il ritorno di una madre andata a fare la spesa (e sperimenta, predittivamente, ciò che sarà l’abbandono), nel fratello che ama di sconfinato amore (e, per non perdere la propria metà originaria, è disposto a rischiare il più grande dei sacrifici), nel ragazzino che, per la prima volta, conosce il cambiamento e la mancanza (pelle dopo pelle).
Un incanto terribile e favoloso.
Magda Szabó, Per Elisa (Edizioni Anfora)
“Due persone si erano sposate con l’idea di vendicarsi della loro vita antecedente, e di far crescere la loro figlia libera, nel proprio mondo fiabesco; la figlia per la quale avrebbero riscritto tutte le favole di Andersen, se avesse preteso che non ci fosse morte, tristezza, amarezza (…) Non ci fu bisogno che qualche estraneo poi me lo venisse a dire; lo avevo intuito subito che per queste due persone io ero tutto, un lusso, e anche senza denaro mi avrebbero fatto crescere ricchissima, assicurando che i miei desideri spirituali liberi e assurdi si realizzassero uno dopo l’altro”
Questa ragazzina terribile, che non le manda a dire a nessuno, che dà filo da torcere ai suoi insegnanti, che ha un cervello tumultuoso e una sfrontata fame di vita: ecco. Questa Magda è proprio lei, la grande Szabó, superba scrittrice ungherese, che si racconta bambina e poi ragazzetta, fino al tempo delle scuole superiori, e apre le porte della narrazione all’amore enorme e sgangherato dentro il quale è cresciuta tra le pareti di casa.

Dell’eccezionalità, calda e tumultuosa, della sua famiglia, non si fa mistero: da una parte la madre, che le dà la musica e un catalogo bizzarro e incantevole di idiosincrasie; dall’altra il padre, con cui parla correntemente in latino e che la rinforza all’intelligenza del dubbio – anche alle spalle dello spaventoso, religiosissimo zio.
È, questo (la cui traduzione Anfora ha affidato alla linguista Vera Gheno), l’ultimo libro di Magda Szabó: un romanzo di formazione su sé stessa, condotto con sapienza ferma e piglio vivissimo. Lì dove la scoperta dell’amore rimescolerà ogni certezza, la giovane Magda è già diventata un personaggio difficile da dimenticare.