In una campagna depressa un bambino sordo sta per perdere l’unico legame che lo sostiene come umano, mentre il fratello geniale inventa un supercomputer. Un padre mai cresciuto, un nonno anarchico, un vicino odioso e una nonna in barattolo. Il mondo senza sfumature di Giacomo Sartori per un romanzo di sorprendente bellezza (e: sì, si ride pure).
Se Giovanni Verga decidesse di riscrivere oggi Rosso Malpelo, sceglierebbe di puntare l’occhio esattamente lì dove Giacomo Sartori (scrittore e agronomo) ha deciso di guardare per costruire il suo ultimo romanzo, Baco (pubblicato da Exòrma).
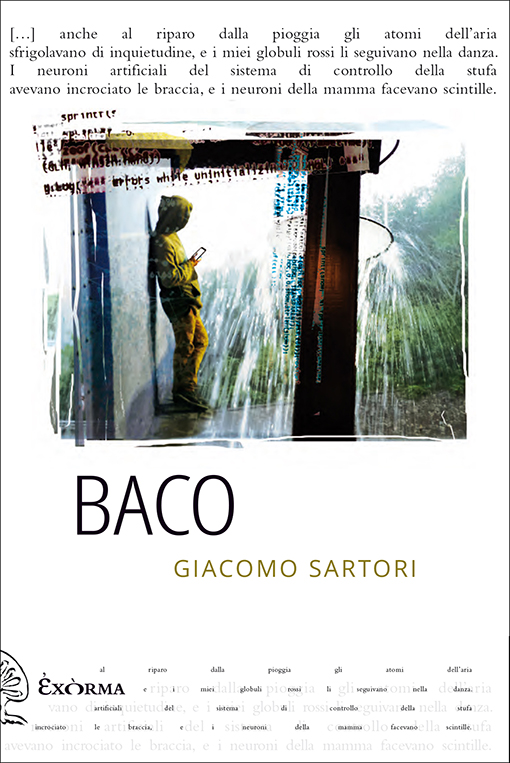
Tutto concorrerebbe a fare della voce narrante di questo libro (interna e in prima persona) un vinto in edizione contemporanea: un bambino di dieci anni, sordo e iperattivo, a tratti incapace di trattenere la necessità di mordere (con devastanti effetti quando si trova in situazioni di tensione), che vive in una pianura periferica e depressa, che ha imparato tardi la lingua dei segni a causa dell’opposizione del padre. Il quale padre, a empatia zero, troppo giovane per rendersi cura persino di sé, barcolla tra la genialità e il complottismo, e attraversa i legami più sfasciati (l’ex moglie, il suocero, i figli) con una leggerezza sconclusionata e siderale.
Senza moralismo, né pietismo, Giacomo Sartori costruisce – nudo e crudo – il mondo scalcinato di una campagna inurbata e abbandonata, che pare perfetto per condurre a perdizione il suo piccolo protagonista, immerso in un silenzio denso, faticoso, con cui viene a patti solo attraverso la lingua dei segni, mezzo in cui è peraltro abilissimo, ma che non tutti comprendono.
Così, esattamente come per lo storico Malpelo (rosso, e dunque cattivo, mentre in questo caso il protagonista è sordo e dunque incomunicabile) c’è un orizzonte predittivo di perdizione intorno a una infanzia che ha già i suoi guai da gestire: un corpo che va per i fatti suoi e combina disastri, un fratello geniale (non a caso il suo soprannome è QI185) specializzato in hackeraggi spinti e diviso tra complicità domestica e affrancamento, una integrazione scolastica (difficilissima) che deve fare a patti con la roulette russa delle graduatorie di istituto.
Non avere parola, in questo contesto, significa stare con tutte le proprie fragilità all’aria – tanto più che lì dove articolare i suoni è un campo di battaglia tardivo e periglioso, c’è invece, dietro, una capacità di pensiero lucidissima.
E infatti, per certi aspetti, questo libro è anche la storia di una guerra per l’apprendimento e, insieme, una riflessione su quanto profondamente, nel disegnare la realtà e determinarla, la parola sia contemporaneamente pennello e spada.
Ciò che si dice è ciò che appare, ma ciò che appare non è (sempre) ciò che è; così l’amara considerazione interiore del piccolo protagonista:
“A ben guardare le parole si prestano senza ritegno alle più colossali menzogne, si direbbe anzi che ci prendano gusto. Se avessero un minimo di dignità si rifiuterebbero di veicolare così tante frottole, e invece appena sentono odore di fanfaluca si fanno sotto come i clienti a una svendita di smartphone, e sgomitano per essere in prima fila. I segni non fanno così”
Con perfetto esercizio di straniamento, e con i dovuti aggiornamenti, i Malavoglia contemporanei sono, nell’occhio di Sartori, una famiglia scoppiata che arranca cercando di non perdere troppi pezzi per strada, il cui unico punto fermo è la figura della nonna – ferma in quanto defunta e in quanto cenere, imbarattolata sopra una mensola.
C’è, certo, un nonno, depositario dei saperi della natura, che inventaria vermi e anellidi prelevando campioni di terreno e maneggiando fetidi liquidi ad alto tasso incendiario, fieramente anarchico.
E certo c’è, si sente, dovrebbe esserci, la madre – l’amore, l’affetto, il calore strambo e biunivoco – ma il punto è proprio questo: la storia comincia il giorno in cui questo microcosmo si schianta sulla fiancata di un tir e comincia ad andare a rotoli perché l’utilitaria scassata della madre viene sbalzata fuori di carreggiata e la donna finisce in coma.
L’equazione della disperazione degli attori che passano intorno al letto dell’ospedale (l’ex marito, il nonno, i medici, il figlio più grande) è direttamente proporzionale al passare del tempo, e inversamente proporzionale alla possibilità di una svolta positiva. Con l’unica eccezione della voce narrante, perché il bambino non vuole, non può, si rifiuta di arrendersi all’idea di poter perdere il suo unico, flebile aggancio con la normalità dell’amore:
“Io parlo molto male, ma lei capisce, è l’unica che ha sempre capito tutto, anche quando non avevo nessun mezzo per penare e esprimermi. Non bisogna confondere le maschere con le facce che ci sono sotto, e me che meno ignorare i sentimenti acquattati sotto a queste ultime. Se non mi risponde con le sue parole leggere e precise come giravolte di uccelli, vuol dire che per ora preferisce comunicare con me col pensiero”
Nello spietato disincanto neoverista, a questo punto, l’unica scelta dovrebbe essere quella di bersi fino in fondo l’amaro calice.
E però.
E però, appunto, “Baco” di Giacomo Sartori non è (solo) un romanzo neoverista, e la voce che racconta è ben oltre l’espediente di una vigile voce interiore.
Siamo, invece, all’interno di un ben congegnato gioco di specchi: il bambino che non parla detta nel linguaggio dei segni alla logopedista il suo pensiero senza filtri (commentando in presa diretta anche le reazioni che la logopedista fa). Quelle che dovrebbero essere lettere per la madre, ovvero un commentario di ciò che si è perduta durante il suo essere altrove, destinate a tenerle compagnia e a ragguagliarla nel momento in cui si sveglierà, sono in realtà anche un ininterrotto flusso di coscienza, che permette al lettore di entrare in questa vicenda in modo eccezionale: con gli occhi di un bambino e con una voce di incantevole, grottesca, divertente e spiazzante umanità.
E poi c’è lui, Baco: non a caso, l’unico personaggio di tutta la vicenda ad avere un nome. Il super computer che, nella sua disperazione nerd, QI185 crea nella solitudine della sua stanza: il moderno Frankenstein destinato – come ogni Frankenstein che si rispetti – a tradire e a scavalcare tutte le aspettative e le buone intenzioni con cui è stato forgiato.
Un libro intelligente, un linguaggio acuto e mai banale. Una riflessione spiazzante su tutto quello che oggi possiamo considerare come naturalità.
Assurdità umane comprese.