Una guida per perdersi (lentamente) a Venezia; la storia di un uomo abitato da voci; una casa che decide di far vivere il proprio tempo a chi la visita; un repertorio di delitti ad alta voce; un romanzo svizzero che sembra Mad Men, ma trent’anni prima; l’avventurosa visita di un seguace del magnetismo in casa di Giulia Beccaria. Cees Nooteboom, Leonardo G. Luccone, Simona Vinci, Giuseppe Paternò Raddusa, Alice Rivaz, Alessandro Zaccuri. Sei consigli di primavera (perché a quelli dell’estate, ancora, ci manca tempo: ma intanto ci prendiamo avanti).
Gita fuori porta
Cees Nooteboom, Venezia – Il leone, la città e l’acqua (Iperborea)
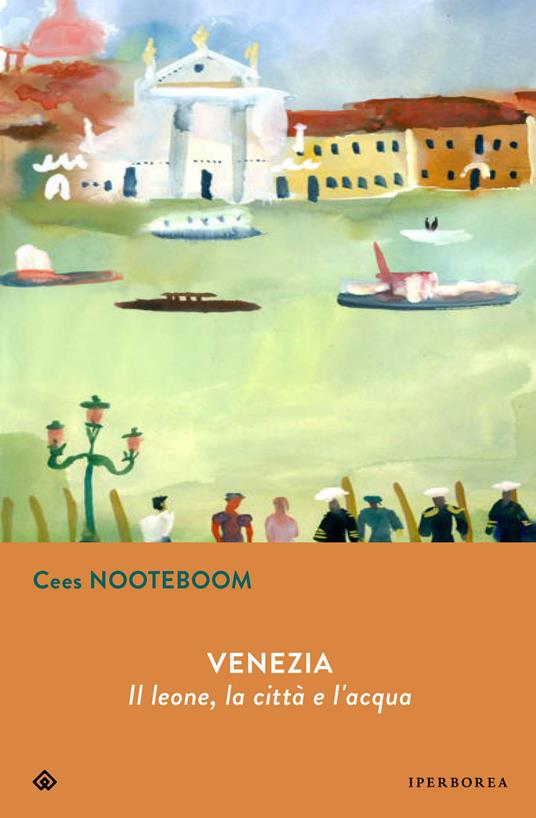
Per chi ricorda la questione della differenza tra un turista e un viaggiatore (la trovare qui), questo libro è una sorta di intensa parabola sulla partita che si gioca tra eternità e anacronismo.
Per cinquant’anni Cees Nooteboom è tornato a Venezia. Ci ha abitato da viaggiatore, da innamorato, da cercatore di meraviglia e da camaleonte. Una dedizione che si traduce in un reportage che è, contemporaneamente, romanzo di vita, percorso di formazione emotiva, guida sentimentale e, in controluce, dialogo ininterrotto con il mistero di una città che oggi paga in contanti il prezzo dell’abbandono, della difficoltà, dell’assenza di cura, del passaggio massivo e distratto, delle grandi navi e dell’invecchiamento.
Certo, scegliere un luogo unico e abusato, posto come cittadella in mezzo ai molteplici assalti della contemporaneità, per andare a scovarci ciò che vi sopravvive della sua innata eccezione, significa assoggettarsi a un gioco di pazienza e di osservazione, oltre che di resistenza.
Cees Nooteboom interroga Venezia a partire dai dettagli, dalle impronte che il tempo ha lasciato sovrapporsi sulla sua scommessa di luogo in bilico; individua l’inquadratura che permette di riflettere sulla continuità e sulla contiguità, fa parlare le statue (come quella di Paolo Sarpi) e i quadri (Tiepolo, Carpaccio, Tintoretto), riposa negli angoli in cui un verde insospettato si incunea tra le pietre.
Così, dietro al suo sguardo, il periplo dei sestieri diventa un racconto di nòstos: un ritorno a sé.
Com’è noto, non siamo in grado di immaginarci l’eternità nella sua essenza. Quello che, per il mio intelletto umano, si avvicina di più è una cosa come il numero mille, probabilmente per la tonda vacuità dei tre zeri. Una città che esiste da più di mille anni è una forma tangibile di eternità. È questa, credo, la ragione per cui qui si va in giro un po’ disorientati, smarriti tra gli strati del passato, che a Venezia appartengono tutti contemporaneamente al presente. Qui l’anacronismo è l’essenza stessa delle cose: in una chiesa del XIII secolo osservi una tomba del XV secolo e un altare del XVIII; quel che vedono i tuoi occhi è quello che milioni di altri occhi, non più esistenti, hanno visto prima di te, e questo non è una tragedia, perché mentre tu guardi loro continuano a parlare, sei sempre in compagnia dei vivi e dei morti, prendi parte a una conversazione che si protrae nei secoli. Proust, Ruskin, Rilke, Byron, Pound, Goethe, Mc Carthy, Morandi, Brodskij, Montaigne, Casanova, Goldoni, Da Ponte, James, Montale, come l’acqua nei canali le loro parole ti fluiscono intorno, e come la luce del sole scompone in mille bagliori minuscoli le onde dietro le gondole, così in tutte queste conversazioni, lettere, bozzetti, poesie echeggia e risplende un’unica parola, Venezia, sempre la stessa, sempre diversa.
La medesima concisione evocativa già esercitata da Nooteboom in un altro lavoro in cui decide di intrattenersi con la misura del tempo (l’ormai iconico Tumbas, sempre pubblicato da Iperborea), assume anche in questo caso la forma libera di un vagabondaggio curioso e inesausto.
Una ottima lettura per incontrare Venezia al di fuori dei (facili) luoghi comuni: anche per chi pensa di conoscerla già.
Perché allora tornare? La prima risposta potrebbe essere che non ho ancora finito con Venezia, ma è una sciocchezza, nessuno finisce mai con Venezia, nemmeno passandoci la vita intera.
L’una, l’altra, nessuna.
Leonardo G. Luccone, Il figlio delle sorelle (Ponte alle Grazie)

Può la volontà di generare un figlio diventare il metro di uno sbilanciamento che disassa radicalmente?
Il protagonista del romanzo di Leonardo G. Luccone, chiuso tra le pareti della propria malattia, ossessionato da ricordi che gli si distorcono contro, ripiegato dentro un dolore pronto sempre a sabotargli ogni tentativo di relazione, è un uomo irrisolto, circondato da rapporti intermittenti.
Non ha nome (unico, in un sistema di personaggi a netta prevalenza femminile); non è in grado di ordinare il proprio passato (lo invadono, a stralci, i ricordi di un tempo cristallizzato ed ellittico, avviluppato in perenne ritorno all’evento che non riesce a focalizzare: l’episodio dell’accoppiamento da cui è – sarebbe – nata la figlia); non può permettersi di non sorvegliarsi, perché il timore di ciò che lo abita lo accompagna come una minaccia sopita (e ciò che lo abita è sempre in agguato, pronto a farlo scendere dentro il nervo vivo della divergenza).
Nella testa hai solo sbucciature. Nella testa hai solo trucidature. Nella testa hai solo mancature. Solo troncature. Smangiucchiature, tramature, stancature, sbavature, sporcature, strozzature, smerigliature, annaspature, sgommature, abbandonature. Abbandonature.
Se il punto di vista è quello di un io danneggiato, è inevitabile che tutte le relazioni deflagrino, che i confini tra realtà e mistificazione si incrocino, che le parole scorrano su superfici di crudeltà e impossibilità: ha avuto una figlia, non si capacita della madre; aveva una moglie, ha una compagna; è padre ma non paterno. Neppure i luoghi si salvano dalla lente della deformazione: l’America della sua personale narrazione è il nome di ben altro, e sulle rive del lago di Pergusa le ombre si allungano per interrogare chi passa e riconsacrare alla natura, tra crochi e melagrane rituali, gli antichi culti orfici.
Ne nasce un romanzo franto, che si spinge nella penombra della mente, facendo saltare ogni convenzionale rapporto emotivo.
Pensavo che il dolore sarebbe finito, un giorno, stordito da altri dolori, poi ho capito che il dolore c’è sempre, cresce, cresce perché respira con te e diventa parte del funzionamento. Questo maledetto dolore con i connotati, questo custode di rughe, rabbia e silenzi; il dolore è un infiltrato, un essere losco e insicuro; traballante come se dovesse rispondere a una domanda a trabocchetto.
Il dolore non si esaurisce, a finire è la disperazione, basta allagarla con altra disperazione e miscelarla per sciogliercela dentro. La disperazione finisce per sfinimento, il dolore pulsa a seconda del ritmo.
Tutto muove la natura femminile: l’abbandono, la passione, la ricerca, il sogno. Ma chi narra ne è soggetto passivante: disattende, si slabbra nelle ossessioni, trova rifugio nel silenzio, trasgredisce. Ed è, insieme, feritore e ferito.
Abitare è essere abitati?
Simona Vinci, L’altra casa (Einaudi)
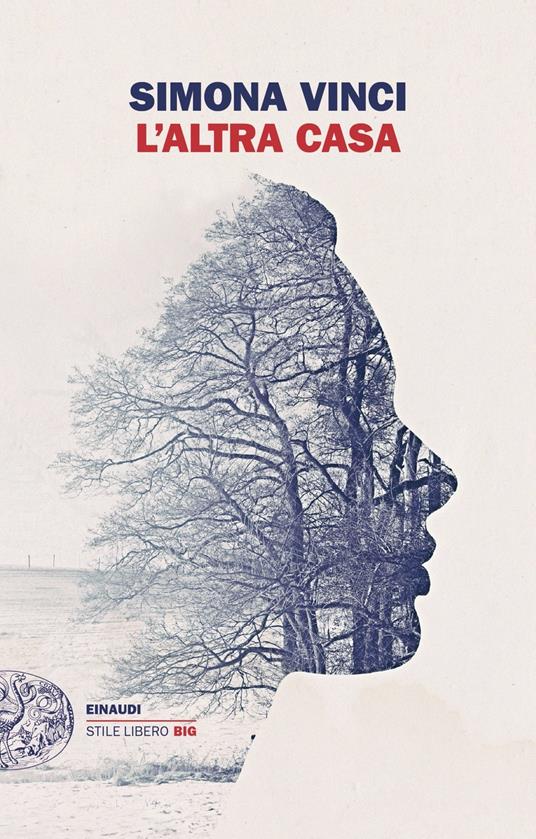
In ognuno dei personaggi che Simona Vinci mette in scena c’è stata un interruzione: quella che riguarda Maura e la sua reale possibilità di tornare a cantare, dopo l’operazione alla gola, è solo la più evidente e la più esposta.
Del resto, Maura è in qualche modo l’apice di un sistema di relazioni di cui riassume perfettamente l’ambiguità: l’uomo che la guida è un manager ma forse non più un amante; di sicuro, il sentimento che li lega è ormai il fossile della passione che è stata. La pianista con cui dovrebbe esercitarsi è una donna che è stata costretta a negare la sua carriera artistica per sopravvivere ai danni che la vita le ha messo davanti: e Maura, volente o nolente, è la carta che le rimane per giocarsi il suo riscatto. Quanto al compagno di lei, Marco, arrivismo e naufragio se lo competono in eguale misura – e di entrambi lui dà prova di non avere compreso mai abbastanza.
Una doppia coppia, dunque, ruota intorno alla villa appartenuta a Giuseppina Pasqua, amica intima di Giuseppe Verdi: riabitarne le stanze, tornare a riempire di suoni gli ambienti che sono stati testimoni e palcoscenico degli ultimi fasti dell’epoca d’oro del Melodramma italiano è il motivo sotteso a una villeggiatura che si propone come risanamento e insieme come rinascita.
Gli arredi gentili, gli armadi pieni di memorie, il rosa che pervade certi scorci parrebbero propizi; ma la memoria di un luogo non è soltanto puro decoro: le pareti hanno vissuto, hanno sofferto, sono state attraversate dai desideri e dagli strazi. Abitare non è mai un atto neutro, come cerca di avvisare l’affittuaria, l’architetto Nissim, che ben sa che il tempo dello spazio abitato incide sempre, e imprevedibilmente, sugli ospiti.
Il movimento è millimetrico, ed è anche fisiologico, fino a un certo punto. Bisogna immaginare, capire, che le case sono organismi: respirano, si muovono, si assestano.
Nonostante la cornice (la casa abbandonata, la natura pulsante, le notti di luna, il mistero del desiderio), ben altro rispetto al Romanticismo è il mondo in cui i personaggi di Simona Vinci si muovono, e non c’è spazio per coltivare affinità elettive: è invece il loro lato oscuro e negato quello che la casa, in misura diversa, riporterà a galla. Chiedendo a ciascuno di fare i conti con le proprie strozzature, con ciò che non hanno saputo o potuto confessare fino a quel momento neppure a sé stessi.
La colpa appartiene all’esperienza di ogni vita, lo insegna anche qualsiasi melodramma, ciò che avremmo voluto e potuto fare per gli altri e non abbiamo fatto, ciò che gli altri avrebbero potuto fare per noi o non avrebbero dovuto fare, e invece. I sospesi, gli errori, gli squarci, le parole di troppo e quelle di meno, i gesti brutti che disegnano traiettorie indelebili tra un corpo e l’altro, una mente e un’altra, un destino e l’altro, e restano lì, incandescenti per sempre, per sempre nitidi e osceni come certe incisioni sulla pietra, graffiti della vergogna che è impossibile sfregare via.
Così funzionano i fantasmi di questo tempo: certo ancora sanno spostare il ritmo del cuore e formulare il mistero di apparizioni sconosciute, ma si sono evoluti. Ed entrano anche nelle esistenze presenti e vive.
Dal podcast alla pagina
Giuseppe Paternò Raddusa, Demoni urbani (Sperling & Kupfer)

Se esiste un orologio che segna lo scivolamento sociale verso il male, la raccolta di testi scaturita dal podcast “Demoni urbani” di ore non se ne perde una; anzi: le doppia proprio.
Quattordici sono infatti le vicende che dalle colonne della cronaca nera scivolano nell’impianto narrativo di questo volume, che compone una sorta di atlante del delitto a noi contemporaneo.
Gli elementi della non fiction inaugurata dal Capote di A sangue freddo ci sono tutti: aderenza formale dei dettagli alla realtà, ingresso della voce del narratore nei pensieri dei narrati, alto tasso di tensione tenuto teso da un uso oculato di artifici retorici (sospensioni, promesse di ulteriori particolari, inquietudine serpeggiante).
L’epica del male fa sistema – e che sia un sistema in grado di esercitare una sua attrattiva anche al netto di mistificazioni sempre possibili ce lo racconta il gusto della tragedia, dalla Grecia antica alle pagine dei nostri quotidiani; tanto più che è proprio dal delinquere che la società registra i propri disgraziati scarti d’uso, come è il caso dell’omicidio della giovanissima Desirèe Piovanelli:
È la prima volta, sui media, che viene utilizzato il termine «branco», a esaltare la rapacità di un piccolo collettivo di disgraziati che si muovono come randagi affamati e senza morale. Un momento fondante, nella storia del crimine in Italia, in cui una scelta linguistica diventerà seminale per altri casi simili.
Il giornalismo narrativo si misura sempre con la violenza, in cui trova fondazione. E in questo suo guardare al morbo agita la nostra capacità (o meno) di confrontarci con il potenziale lato oscuro che accompagna il cammino umano. In questo volume, Giuseppe Paternò Raddusa alla scrittura chiede qualcosa che avevamo dimenticato da qualche secolo: tornare a farsi tridimensionale in una privata lettura ad alta voce.
Uffici, amori e solitudini: Mad Men, ma in Svizzera
Alice Rivaz, Il cavo dell’onda (Edizioni Paginauno)
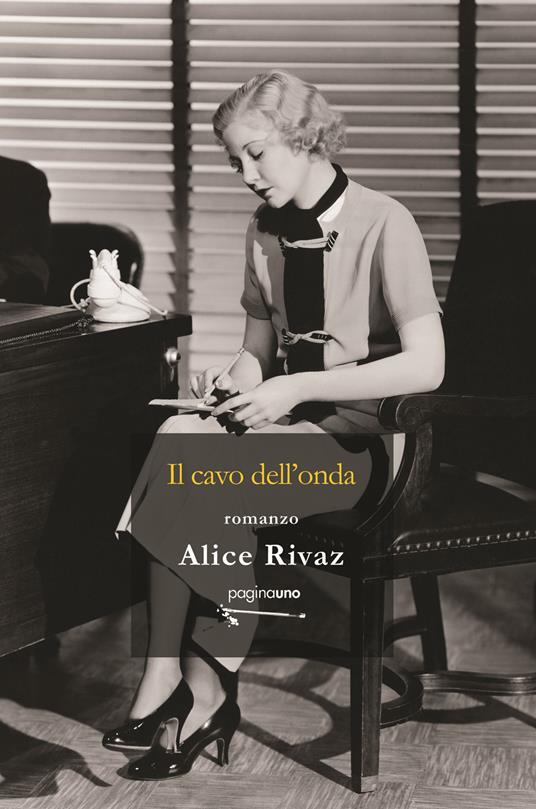
Il movimento antifascista per la pace, le catene di solidarietà per i primi ebrei scappati dalla Germania, la nascita di una nuova classe sociale attratta e sostenuta dal lavoro negli uffici internazionali, i bistrot e le feste private, i negozi del lusso e i comitati: Ginevra, nel 1933, è una città vivace e attraversata da tensioni e impegno, crocevia di apolidi, culla di pensieri divergenti. Neutralità non è infatti parola blandamente acquisita, ma la conquista di un preciso ideale: c’è una generazione dedita al pensiero non violento, protagonista di manifestazioni a lungo represse, attivista per l’obiezione nel tempo in cui l’intera Europa correva verso il nazionalismo più spinto.
Paginauno ha (per la fortuna dei lettori) cara l’opera di Alice Rivaz, della quale ha già pubblicato La pace degli alveari e Come la sabbia.
Con Il cavo dell’onda aggiunge una tessera importante alla restituzione agli scaffali di una voce viva e acuta, che anticipa riflessioni e temi che sono oggi di piena attualità.
C’è, tanto per cominciare, una insofferente cornice di determinismo di genere, e l’ufficio sembra l’incubatore perfetto per mettere in scena tutte le possibili variazioni sul tema del rapporto uomo-donna in termini di potere, di ruolo, di prevaricazione, di pregiudizio. C’è la questione della diversa distribuzione dei carichi di lavoro e delle aspettative. E c’è, molto netta, la percezione che autoaffermazione, ribellione e indipendenza siano inevitabilmente legate alla possibilità di sopravvivere del proprio denaro.
A lei gli uomini non mandavano fiori né regali, ma in compenso le rubavano il tempo, la disturbavano per qualsiasi sciocchezza. Pretendevano che leggesse i loro stessi libri e poi ne facesse un commento: “Hélène, lei che sa cogliere così bene il senso delle cose…” Chiedevano il suo parere sul freudismo e la sessualità, si mostravano desiderosi di vederla condividere le loro preoccupazioni del momento, estetiche, religiose, politiche o altro, come Berthold o Schulz. La consultavano sui loro affari, sui loro amori, su un problema, ma senza il riguardo che avevano nei confronti di Chatenay. A quest’ultimo si accostavano solo con rispetto, scusandosi di portargli via il suo tempo prezioso. Con lei, poche storie; e addirittura, fra quegli sciagurati, c’era chi tentava di accollarle le faccende scoccianti, come se le faccende scoccianti fossero per forza di competenza delle donne, eterne tuttofare, in ufficio come a casa.
Isabelle, Claire-Lise, Hélene sono donne che non possono dimenticare chi le ha lasciate. Le vediamo trattenute e concilianti, sottilmente vendicative e soccombenti mentre studiano l’arte di una difficile sopravvivenza dell’equilibrio tra le proprie pulsioni, il desiderio di felicità e la necessità di non essere messe in scacco, cinte come sono da un universo maschile dominante (che finisce sempre per piegarsi sul proprio narcisismo) da cui vengono irretite, respinte, sedotte.
Intelligenza, così, significa capacità di trattenersi per salvare la raggiunta possibilità di scegliere in che misura essere sole. Il privato e il pubblico sono insomma due fronti sui quali lo sguardo maschile e quello femminile arrivano inevitabilmente a divergere; ma è proprio ai suoi personaggi femminili che Rivaz consegna la capacità di affermare un mondo diverso. Capacità che, a ben vedere, è tutt’altro che conquistata.
E invece non era strano, in fin dei conti, che non si fosse mai tranquillizzata, che non si fosse mai data pace al pensiero degli uomini che dappertutto, in tutti i tempi, si fanno uccidere sui campi di battaglia; che si fosse sempre ribellata all’idea di tutti quelli che soffrono, dappertutto, persone e animali, a causa della stupidità degli uomini e della crudeltà delle spaventose leggi cosiddette naturali…
Quel barone sembra Leporello. E casa Beccaria è un palcoscenico
Alessandro Zaccuri, Poco a me stesso (Marsilio)

Giulia Beccaria ha ormai i suoi anni, il suo salotto è stato leggendario, i suoi amori mormorati a fior di labbra. Tutto farebbe supporre un placido imbrunire della vita al riparo da fole e bizzarre alzate d’ingegno. Del resto, alla metà dell’Ottocento, nessuno è più scopertamente libertino e in società va di moda castigare i costumi, al limite fermarsi sulla soglia di una sensualità allusa. Così quando nel palazzotto milanese arriva il barone di Cerclefleury – esotico rappresentante di quella schiatta di uomini usi a camminare sul crinale tra scienza e magia – ci si aspetta certo un poco di brivido, qualche blanda reprimenda di parte ecclesiastica, il consueto chiacchiericcio che si può alzare intorno all’opera di uno che si porta in giro la fama di essere legato nientemeno che agli insegnamenti del (peraltro già ampiamente chiacchierato) Mesmer. Il mondo è contraddizione, si sa. E che le sedute di magnetismo siano motivo di seduzione anche per quegli animi un tempo assoggettati dalla dea Ragione è una constatazione cui parcamente arrendersi: il desiderio olistico, a ben guardare, non è andato mai tanto distante e il Mesmer l’aveva saputa cavalcare bene, quella vena profonda dell’inquietudine umana:
Presto aveva intuito che il cosmo è legato da un’unica energia, o forza, che ne costituisce l’anima nascosta. Non v’è distinzione nel vincolo tra l’uomo e la pianta, né tra la pianta e il bestiame, né tra il bestiame e la roccia. Un effluvio invisibile scorre per ogni dove, istruendo una selva di corrispondenze e un intrico di influenze che per l’intelligenza umana costituiscono il più alto e il più risolutivo cimento.
Insomma: Cerclefleury è uno che coi misteri del cosmo va a nozze, per di più ha il fisico, l’allure, la spavalderia e la ventura di vivere in un mondo disposto a credere alla parola ben detta. Nelle stanze della Marquissa ha ricevuto ospitalità e udienza, buon desco e un uditorio certo mediamente attempato, ma grazie al cielo dotato di prole (quando non di servitù) acconcia all’esercizio della propria leggenda.
Prudente non meno che ardito, il barone di Cerclefleury aveva cura di non approfittare in eccesso dell’ascendente naturale che facilmente gli avrebbe consentito di cogliere le più felici vittorie sul sesso femminile.
Che dunque pensare di una certa strana presenza di quel palazzotto, ovvero di quel tale Evaristo così incongruo e sproporzionatamente devoto alla padrona di casa? Che un mistero ci sia, l’accorto barone è certo; ma quando si mette in testa di risolvere a suo favore la mala stella di quell’altro, finirà per incontrare i bassifondi di una Milano dominata da un guitto per nulla incline alla carità, né all’umorismo.
Alessandro Zaccuri mette in moto una macchina degli umani affetti: un romanzo condotto con la spettacolarità di un’opera buffa, disseminato di opulente e sibilline memorie manzoniane.
Se già ne Il signor figlio (che Marsilio ripubblicherà a breve) aveva inventato Leopardi oltre Leopardi misurandosi con i temi dell’identità e del possibile, qui mette in scena una narrazione nella quale nulla è mai (solo) ciò che sembra. E lo fa – sempre – muovendo al sorriso.