Molta musica, tanta Russia, ma anche scritture femminili, saggi tra storia e arti e piccole perle nella nostra rubrica di letture in cui si annida anche un’inaspettata stroncatura
Corrado Augias, Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo, RaiLibri, 2023

Paolo di Tarso nato Saulo, fariseo e persecutore di cristiani. Dopo la conversione di Damasco forgiatore del cristianesimo come religione universale, oltre l’ambito giudaico e gli esclusivismi settari della piccola cerchia di Gerusalemme guidata da Pietro e da Giacomo fratello di Gesù. La Fede prima della Legge, l’amor di Dio prima dei tabù alimentari e della circoncisione, l’apertura alle “genti” di una nuova religione al tempo stesso inclusiva e totalizzante. Paolo tessitore e fabbricante di tende che si guadagna da vivere, orgoglioso di non dipendere dall’aiuto dei fedeli. Viaggiatore instancabile, vigoroso edificatore di una teologia che prenderà le mosse da lui quanto dai Vangeli, predicatore e oratore aspro e sublime. Carattere imperioso e segnato da una misteriosa malattia, forse l’epilessia. Attento più a Dio che agli uomini, come sarà l’altrettanto imperioso Agostino da Ippona. Il Lenin del cristianesimo, come lo ha definito con formula pregnante Emmanuel Carrère. Ricostruzione attenta al contesto dell’ecumente ellenistico-romana: Augias maneggia con finezza ammirevole i teologi e gli autori classici, da Giuseppe Flavio a Tacito, da Svetonio a Tito Livio, da Cicerone a Lucrezio. E squarci narrativi che riempiono il vuoto documentale. Misurato, colto, piacevole.
Alan Bennett, Arresti domiciliari. Diari della pandemia, trad. Mariagrazia Gini, Adelphi, 2023

Il covid, il confinamento, il disastroso Boris Johnson visti con l’umorismo lieve ma affilato di Alan Bennett. Piccoli accadimenti quotidiani e tanti ricordi – la pesca senza prendere pesci praticata dal padre, su tutti – che rimandano a Una vita come le altre. Uno sguardo limpido che fa da contraltare alla retorica di quei mesi tristi. Una vecchiaia senza piagnistei, le belle pagine conclusive del ritorno a Leeds. Non sapevo, lo apprendo da questo aureo libretto, che Alan Bennett è stato lo sceneggiatore di un film del 1984 che molto mi è piaciuto, Pranzo reale di Malcolm Mowbray.
Patrizia Carrano, La figlia della serva, Vallecchi, 2024

Elisabetta, savia e solitaria protagonista del fortunato La bambina che mangiava i comunisti, qui è diventata una giovane donna quietamente intrepida e difficile da scordare, con una piccola cerchia di amicizie, pochi amori quasi sempre deludenti e una dolceamara solitudine addolcita dalle “serve”. Cresciuta dall’affettuosa balia veneta Beppa, che le ha fatto da madre in assenza di quella vera troppo presa da sé e dalle sue battaglie verrebbe da dire contro i mulini a vento, Elisabetta si sposa giovanissima per uscire di casa e giovane si separa, trova lavoro in un’agenzia letteraria di cui diventerà socia, riesce a farsi carico persino dell’anaffettiva madre e del suo compagno, un irsuto archeologo marxista molto assorbito dal suo lavoro e dall’ideologia. La madre bella e altera dell’infanzia, Franca Gobbi, una vita al riparo dai sentimenti, è diventata un’anziana imperiosa, tenace e apodittica nelle convinzioni e vessatoria, nella vita di tutti i giorni, con chi le capita a tiro. Una frattura scomposta al femore, di cui l’inaffondabile novantenne è vittima, dà l’avvio alla narrazione e offre il destro per ricapitolare settanta e passa anni di vita italiana. Franca, che rischia di dover cedere l’appartamento in cui abita alla meschina figliastra per ritirarsi in una casa di riposo, troverà il modo di reinventarsi una nuova vita e di spianare la strada per un lavoro futuro al fedele badante peruviano Manuel Perez. Nei modi della commedia crudele, movimentata nel plot spesso esilarante e accesa da annotazioni acute e puntuali sul (mal) costume di casa nostra, Beppa e le altre – Ofelia e Ottavia, Annalisa e Ernestina, Melinda e Luisita, da ultimo il solido e paziente Manuel – sono le vere protagoniste di questo romanzo corale che trova presidio affettivo e morale, conforto e cura, nelle persone che stanno nella stanza della servitù. Balie, domestiche, portinaie, colf, badanti, ma anche confidenti e spesso amiche, che arrivano dal Veneto e dal Perù, dalle Marche e dalle Filippine, dalla campagna laziale e dalla Georgia. Una saga familiare di amori e disamori, eredità e capricci, tra Venezia e Roma, dal 1947 a oggi. Nel romanzo c’è molta infelicità familiare. Tenuta a bada, occultata, lasciata in eredità come una mela avvelenata. Divertente e ricco di colpi di scena, il romanzo di Patrizia Carrano ha vera empatia con il mondo dei “servi”, superiori nella loro verità ai “signori”. E nasconde tra le pieghe un lessico famigliare che intuisco rielabori lutti e dispiaceri dell’autrice. Scrive Carrano, nella nota finale: «Alla luce di quanto è avvenuto – non solo sul fronte familiare ma anche su quello della politica – mi sono convinta che la sinistra abbia avuto molti e indiscutibili meriti, ma anche numerose colpe: e fra queste voglio sottolineare la frattura che negli anni si è creata fra le istanze teoriche delle élites intellettuali e i sogni e i bisogni della gente più semplice: quel popolo rosso che, non sentendosi più compreso e riconosciuto, si è allontanato dalla politica, migrando verso altri ingannevoli lidi». Meglio non si sarebbe potuto dire.
Suso Cecchi D’Amico, Storie di cinema (e d’altro) raccontate a Margherita D’Amico, Bompiani, 2023

Sul suo mestiere Suso Cecchi D’Amico, 1914-2010, ha avuto le idee chiare: «Lo sceneggiatore non è uno scrittore; è un cineasta e, come tale, non deve rincorrere le parole, bensì le immagini. Deve scrivere con gli occhi». Quanto al cinema: «Una volta Giorgio De Chirico scrisse che la vera pittura è morta il giorno in cui il pittore non preparò da sé i colori, sbriciolando le polveri nel mastello, dosandole, mischiandole con l’olio. Pensa di quanti complici e marchingegni ha bisogno un regista per riuscire a portare una sola immagine sullo schermo. Flaiano in un giorno di cattivo umore scrisse che il cinema non è arte, ma “una specie di gastronomia che sazia nel pubblico la fame del momento”. Io non sono così crudele, ma non si può ignorare che l’artista lavora da solo e per sé, mentre l’uomo di cinema… che dirti? Non è arte. Eppure, come si può sostenere che Bergman – per fare un esempio – non sia un artista…». Figlia del letterato Emilio Cecchi e della pittrice Leonetta Pieraccini, sposa del musicologo (e cattocomunista) Fedele D’Amico, Suso Cecchi è stata un pezzo fondamentale del cinema italiano e l’elemento centrale, il collante di una vasta e ramificata tribù imparentata con Antonio Baldini e Natalia Ginzburg, Luigi Pirandello e Benedetta Craveri, Antonio Giolitti e Benedetto Croce, nei cui rami è facile perdersi (Tullio Kezich e Alessandra Levantesi l’hanno ricostruita in Una dinastia italiana, Garzanti, 2010). Come sceneggiatrice ha esordito nel 1946 con Mio figlio professore di Renato Castellani, e da allora ha lavorato con i nostri registi maggiori: Zampa e Lattuada, De Sica e Comencini, Blasetti e Camerini, Antonioni e Pietrangeli, Monicelli e Rosi, Zurlini e Zeffirelli, Maselli e Bolognini. Soprattutto con Luchino Visconti: e almeno tre titoli frutto del loro sodalizio, Bellissima, Rocco e i suoi fratelli e Il gattopardo, sono entrati nella storia. Leggera, senza mai scomporsi di fronte a niente, meticolosa ma indulgente con l’imperfezione, in queste godibilissime memorie frutto di lunghe conversazioni con la nipote Margherita D’Amico – l’edizione originale è del 2002 – Suso Cecchi passa in rassegna colleghi, amici e volti conosciuti: la “scimmietta” Coco Chanel, Alberto Moravia giovane “simpatico ma molto pedicelloso”, lo svagato e geniale Nino Rota del quale traccia un ritratto delicatissimo. C’è il sodalizio con Flaiano che si innamora di lei e che Suso è forse tentata di corrispondere, ma non se ne fa niente. I ritratti rapidi e vivaci di Loren, Mangano, Mastroianni e Lancaster, Stoppa & Morelli, Zavattini e Magnani e molti altri, frutto di amichevole e duratura consuetudine. Suso Cecchi D’Amico l’impavida. Scrive la nipote Margherita: «Le due notti che precedettero il funerale del Nonno le trascorsi in clinica con la Nonna. Una di quelle mattine, in cui mia madre era venuta a tenerci compagnia per la prima colazione, conversando affettuosamente con la Nonna le chiese cosa, in fondo, l’avesse convinta a sposare quell’uomo tanto geniale ma anche così difficile. “Lo sprezzo del pericolo”, rispose lei senza pensarci. E credo che, pur avendola amata pazzamente, anche nella decisione di lui ci dovette essere una componente di questo tipo. Fu in fondo l’incontro i due temerari».
Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile, Einaudi, 2023
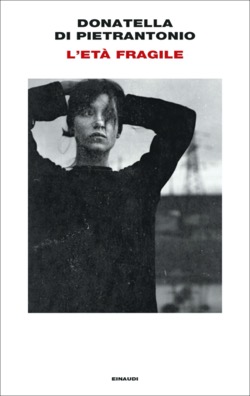
Amanda è tornata a casa, in Abruzzo. Aveva scelto la grande città, l’università a Milano, contro “il nulla” del paese. Ma è tornata. Spenta, azzerata, inerte. Non studia più, passa le giornate chiusa in camera, non dice che cos’ha, non frequenta nessuno. A Milano l’hanno aggredita una sera per rubarle la borsa e nessuno l’ha soccorsa, è soltanto questo? Lucia sua madre, l’io narrante, è una donna sola, il marito Dario se n’è andato a Torino e non è più tornato. «Ti ha lasciato e tu neanche te ne sei accorta» le dice la figlia. Deve occuparsi di Amanda, stare dietro al padre patriarca vecchio ma non ancora arreso. «Mio padre mi chiede di accompagnarlo nel suo ultimo tratto, insiste che prenda quel terreno. A mia figlia devo restituire il mondo. Mi tirano ognuno dalla propria parte, al proprio bisogno. Mi spezzano». Una storia di non detti, di silenzi, di lutti elaborati male, nascondendo la testa sotto la sabbia. Trent’anni prima, nel terreno che il padre vuole cedere a Lucia, il suo amico Osvaldo aveva aperto un campeggio, indebitandosi. E una sera tre ragazze non erano tornate. Due uccise e la terza, Doralice migliore amica di Lucia, ferita e scampata alla morte per tenace istinto di sopravvivenza. L’assassino, un servo pastore straniero, era stato condannato all’ergastolo. E sulla vicenda era calato il silenzio del rimosso. Doralice, dopo l’ospedale e il processo, se n’è andata lontano, in Canada, a fare l’avvocato, e in paese non torna più. Lucia si è accontentata della laurea breve in fisioterapia, dopo un periodo di rifiuto simile a quello che ora sperimenta Amanda, spegnendosi nella famiglia e nel paese. E suo padre, rimasto vedovo, ha continuato a fare il contadino. Una storia di esili ed erranze, della fatica di stare assieme e di quella di separarsi, raccontata con pudore, per sottrazione. La terra lasciata andare, non curata, come le vite degli abitanti, murati vivi e persi in quel che è stato e non passa. Lucia prova a rimettere ordine nella sua vita («A me non era successo niente. Ero stata colpita, come tutti, ma non di persona. E la mia amica era sopravvissuta. Eppure avevo perso la forza, i nervi si erano spezzati, azzerata la volontà»), a capire Amanda («La vita segreta dei figli. Sappiamo che esiste, ma non siamo mai pronti a toccarla. Restano per sempre angeli senza sesso nel chiuso delle nostre teste. Indifferenziati, mai del tutto partoriti»), ad accettare l’amore laconico del padre che slanci d’affetto ne ha avuti soltanto per gli amici. L’occasione arriva con l’offerta d’acquisto del terreno da parte di uno speculatore di Pescara. I pastori, supportati dai giovani ambientalisti, protestano. E Lucia, aiutata da Amanda, fa demolire quel che resta del vecchio campeggio perché la terra ritorni ad essere terra e quella ferita venga infine suturata. Il concerto di un coro, di cui Lucia fa parte, può essere la pace possibile, il superamento di quel lutto. La riconciliazione tra “i vivi e i morti” come nel racconto conclusivo dei Dubliners di Joyce. Un romanzo importante, che dipana molti fili con invisibile sapienza.
Ted Gioia, Gli standard del jazz. Una guida al repertorio, c. Francesco Martinelli, Edt, 2015

Ted Gioia è l’autore della più aggiornata e autorevole storia del jazz. L’edizione italiana l’ha pubblicata la benemerita Edt di Torino nel 2021, un anno dopo quella edita da Hoepli (autori Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco). Io continuo a tenermi caro Jazz di Arrigo Polillo, mio testo di iniziazione, ma risale al 1975 e termina agli albori del free jazz, con Ornette Coleman. Fidandomi della competenza di Gioia, che arriva a oggi, mi sono andato a cercare anche la sua guida agli “standard”, i classici del songbook americano reinventati da solisti, trii e formazioni più ampie, nonché entrati nel repertorio delle/dei cantanti. Dalla A di After you’ve gone alla Y di You’d be so nice to come home to, 250 pezzi di cui Gioia racconta genesi e fortuna e consiglia le esecuzoni imperdibili. Ho fatto la prova con Round midnight, lo struggente brano che Thelonious Monk compose a 19 anni. Gioia suggerisce ovviamente l’autore (1957, ma Monk l’ha incisa una ventina di volte), l’epocale Miles Davis del 1956 e poi Barry Harris (1962), Betty Carter (1962), Sarah Vaughan (1963), Dexter Gordon (1976), Wayne Shorter (1982), Bobby McFerrin con Herbie Hancock (1985, nella colonna sonora del film di Tavernier) e James Carter (1994). Inappuntabile, io avrei aggiunto anche Charlie Haden con Chet Baker, Enrico Pieranunzi e Billy Higgins (l’album è Silence del 1989), ancora Charlie Haden con Keith Jarrett, per concludere con Bill Evans, Michel Petrucciani e Lee Konitz. Insomma, avrò da ascoltare e fare confronti a lungo.
Paolo Nori, Una notte al Museo Russo, Laterza, 2024

Con Paolo Nori, scrittore di eccentrica e spesso esilarante emilianità e traduttore dal russo fra i nostri maggiori, la chiave di lettura può essere anche una battuta, una divagazione della cui arte tiene lo scettro, un tirare in lungo e, sarei tentato di dire, un fingere di fare lo scemo per non pagare il dazio. Anche se poi, alla fine, Nori il dazio lo paga eccome. Discorsi che ti sembra scappino da tutte le parti, in libera uscita, per poi tornare al nucleo, sempre: gli affetti. L’affetto, la passione di tutta la vita per Paolo Nori – a parte la compagna detta Togliatti e la figlia detta Battaglia – è la Russia e la sua letteratura. La visita del Museo Russo e non dell’Ermitage, le disavventure grottesche con la burocrazia russa – e la divagazione sul Gogol teatrale che sferza i burocrati – sono il pretesto per una ricognizione di Pietroburgo dopo l’invasione dell’Ucraina, dopo “l’operazione speciale”. Il clima è mesto, i russi con cui parla sono turbati.
«E parlare di Russia in questo momento fa male. Per chi, come me, è appassionato di letteratura russa questo è stato un periodo molto doloroso, ancora più doloroso per via del fatto che il nostro dolore, rispetto al dolore vero, non vale niente. (…) Ho sentito un ragazzo, un cittadino russo che aveva detto che lui era nato a Kiev, e aveva fatto le scuole a Kiev, adesso abitava a Mosca e aveva la cittadinanza russa e a Kiev abitava sua mamma, e a Odessa suo fratello, e lui si era svegliato, quella mattina che la sua nazione, la Russia, bombardava Kiev e Odessa, bombardava sua mamma, e suo fratello, e poi aveva taciuto e aveva stretto le labbra e non sapeva più cosa dire e gli veniva da piangere e veniva da piangere anche a me».
Gli opposti fanatismi: quelli che in Russia parlano delle menzogne occidentali in tono protervo, quelli che in Italia annullano un corso universitario su Dostoevskij (è accaduto, con l’Università Bicocca, proprio a Nori) o vietano la proiezione di Stalker, capolavoro di Andrej Tarkovskij, perché è russo e la Russia “è cattiva”. E, in Russia come in Italia, la peste morale che ha il nome di zloradtsvo, l’equivalente dello schadenfreude tedesco, la gioia che viene dal male, che si prova di fronte all’altrui sventura. Siamo più bravi a costruire muri che ad abbatterli, l’appello tra le righe di Nori a non perdere l’umanità mi ricorda l’adorato Stefan Zweig il quale, in piena guerra mondiale che vedeva Italia e Austria nemici, passava qualche guaio per avere tessuto l’elogio di Benedetto Croce su un giornale viennese.
Naturalmente nel libretto di Nori, nella forma divagatoria che è il suo marchio di fabbrica, c’è molto altro: Dovlatov e Brodskij, Dostoevskij e Anna Achmatova, Sklovskij e Chlebnikov e Charms e – nonostante tutti gli intralci messi in campo dai burocrati – anche il Museo Russo. Sull’autocrazia che oggi regge la Russia Nori ha parole nette: «Alla sera, alla stazione della metropolitana Aleksandr Nevskij, incontriamo una persona che si occupa di letteratura del primo Novecento, e che ha lavorato anche su Daniil Charms. Gli chiediamo se pensa che il drammatico caso di Charms, che hanno fatto morire di fame perché qualcuno aveva sostenuto che lui avrebbe detto che la guerra l’avrebbero vinta i tedeschi, si possa ripetere, e lui ci risponde: “Pensavamo che non potesse ripetersi, adesso sappiamo che può ripetersi”.
E ci dice che in generale, in questo periodo, non ci sono tanti prigionieri politici. Sono pochi. Ma non si capisce il senso delle condanne. La legge sulle fake news che hanno approvato subito dopo l’inizio della cosiddetta operazione speciale consente al potere di punire con quindici anni di carcere chi diffonde notizie false sull’esercito. A decidere quali notizie sono vere e quali sono false sono loro, e lo fanno con un metro che è difficile decifrare. «Uno dice delle cose contro la guerra, e non gli succede niente. Uno dice le stesse cose, e prende quindici anni. Non c’è bisogno di arrestarli tutti: l’arbitrio che vige in Russia ha, come conseguenza, di scatenare la paura. Ecco».
Paolo Nori è prezioso, teniamocelo caro.
Daniele Olschki, Gioverà ricordare. Meminisse iuvabit, Olschki, pref. Liliana Segre, Olschki, 2024

Un libretto, scarno quanto inestimabile, per ricordare la vicenda editoriale e umana di Leo Samuele Olschki, ebreo della Prussia orientale che nel 1883 si trasferisce a Verona, per poi spostarsi a Venezia e, nel 1897, stabilirsi definitivamente a Firenze. Dove crea la casa editrice che ancora oggi porta il suo nome, presidio di molti saperi umanistici, nome venerato tra i bibliofili e i lettori colti. Racconta soprattutto, il libretto di Davide Olschki, l’odissea dolorosa della sua famiglia che solo per poco non si è fatta tragedia, dopo l’orrido bando agli israeliti del 1938. Che impone il censimento dei dipendenti e degli autori ebrei, il mutamento di nome della casa editrice, fino alla confisca e, per gli Olschki, alla privazione della cittadinanza italiana. Dopo l’esilio svizzero, a guerra conclusa e fascismo caduto, la casa editrice risorgerà dalle ceneri, ma “gioverà ricordare” di quali atti si sia macchiato il fascismo: il libro riproduce anche le miserabili missive burocratiche con le loro ingiunzioni vessatorie. Andranno accostati a questo volumetto, per completare il quadro, anche il vivace memoir Terza liceo 1939 di Marcella Olschki (io lo possiedo nell’edizione Sellerio del 1993 con la prefazione di Piero Calamandrei, assieme al successivo Oh, America del 1996) che Olschki ha appena ripubblicato. E Il fuoriuscito (Piemme) che Marco Ventura ha dedicato al grande editore Angelo Fortunato Formiggini (ho trovato negli ultimi anni alcuni dei suoi “Classici del ridere” nelle bancarelle domenicali a Brera), che nel 1938 si uccise gettandosi dalla Torre della Ghirlandina di Modena per protestare contro le leggi razziali.
Gian Piero Piretto, L’ultimo spettacolo. I funerali sovietici che hanno fatto storia , Cortina, 203

Sotto il segno del kitsch, sotto il segno di un “sacro secolare” contro la religione che ci si proponeva di sradicare, i grandi funerali dicono molto di che cosa fu l’Unione Sovietica. E di recente, con le esequie di Gorbacev disertate dal potere, con quelle clandestine del criminale Evgenij Prigozin capo della milizia Wagner, dicono molto anche dello stalinismo senza Stalin, dello zarismo senza zar che è il regime di Putin. Piretto, acuto slavista che molto ha indagato sulla società e sulla cultura sovietiche, rilegge oltre un secolo di cerimonie funebri, dai “funerali rossi” a Nikolaj Bauman e alle vittime della rivoluzione del 1905, che sono manifestazioni di rivolta e fierezza, alla prima glorificazione, quella di Lenin morto nel 1924. In quell’occasione la commemorazione terrena di un capo diventa creazione di una divinità, imbalsamata ed esposta nel mausoleo sulla Piazza Rossa. Con la commozione vera e quella suscitata ad arte, con la retorica del “Lenin vive!” che, in quei primi anni di consolidamento del potere bolscevico, è manifestazione di compattezza rivoluzionaria (già allora apparente) prima che comincino le purghe – Trotskij, Zinovev, Bucharin, Kamenev – e gli anni del “grande terrore”. Con Stalin la deificazione del capo raggiunge l’apoteosi nel 1953: file di chilometri per vedere “l’immortale” nella bara – i ritoccatori ufficiali non erano riusciti a nascondere i segni del vaiolo e le macchie della vecchiaia, annota perfido Piretto – scene di isterismo collettivo, svenimenti, suicidi. E qualche raro sussurro di sollievo. Duecento cameramen per documentare l’afflusso popolare, la cerimonia solenne e interminabile. Per ricavarne un film che non verrà mai proiettato, perché nel frattempo alcuni sodali del dittatore, Berja in primis, stavano cadendo in disgrazia e andavano rimossi dallo spettacolo. Esequie pubbliche, quelle dei capi-dei, che contraddicono quelle private, con l’adozione in parte igienica e in parte ideologica della cremazione, per prevenire epidemie – le pagine belle e terribili, quelle che restano più impresse del libro, dedicate agli 800 mila morti dell’assedio di Leningrado tra il 1941 e il 1944 – e per desacralizzare la morte, per sottrarla al controllo della chiesa ortodossa. Diverso ancora, e contraddittorio, l’exit degli intellettuali, da parte di un potere che ha distrutto i suoi poeti: dall’esecrazione per il suicidio del “poeta contadino” Esenin – Piretto lo rilegge, acutamente, come “teppista urbano” – all’imbarazzo per il suicidio di Majakovskij, accompagnato alla dimora estrema da una cerimonia ufficiale. Dai funerali – privati e tollerati, per quanto controllati da polizia e apparati di sicurezza, per quanto con i partecipanti schedati e in seguito perseguitati – di Boris Pasternak, Anna Achmatova e dell’amatissimo attore-chansonnier Vladimir Vysotskij, 500 mila che si affollano attorno al teatro Taganka, con i magnetofoni che diffondono le sue canzoni proibite. Fino alle esequie quasi clandestine del grande Sergej Prokofiev, che ha avuto l’estrema sventura di morire negli stessi giorni di Stalin. In questo caso i funerali sono manifestazioni, se non di dissenso esplicito, di non conformità. Ma prevale la propaganda, l’indottrinamento anche emotivo e sentimentale, la creazione artificiale di una sindrome che non si chiama ancora di Stoccolma e che spinge la vittima a venerare il carnefice. Una lunga storia di negazione della democrazia passa anche per i funerali.
Raoul Precht, Quintetto romano, Bordeaux, 2023
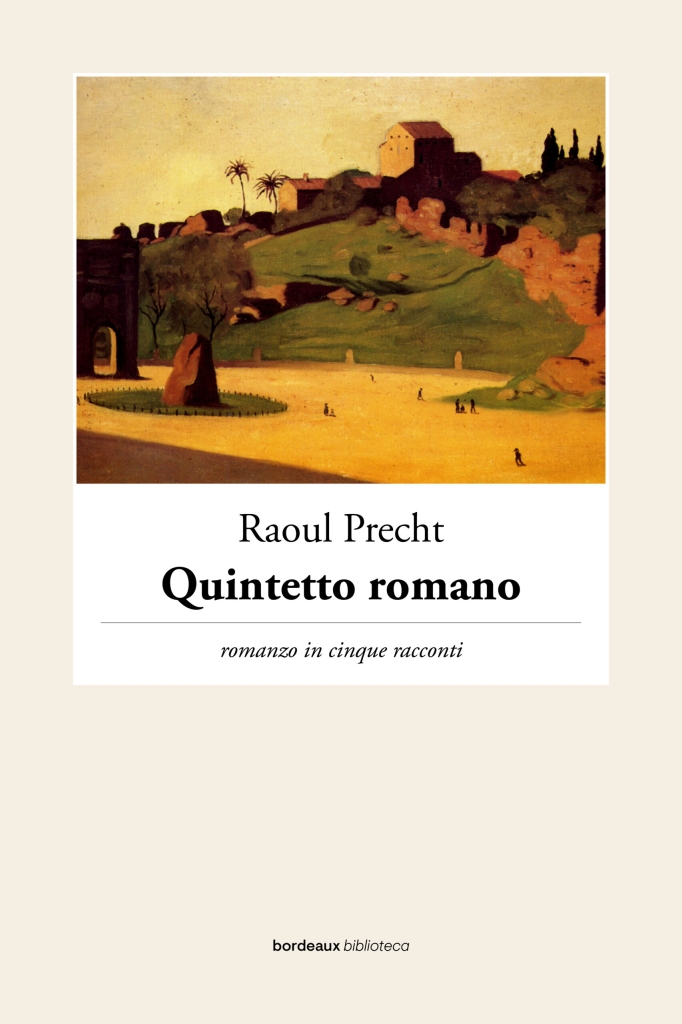
Cerca di non guardare i monumenti
viandante, se per Roma t’incammini,
apri cento occhi, le pupille affina,
schiavo soltanto dei suoi pavimenti.
Cerca di non guardar tanti portenti,
fonti, palazzi, cupole, rovine:
troverai mille morti repentine
se vuoi guardare senza accorgimenti.
Guarda a destra, a sinistra, attento al vigile,
fermati all’alt, avanza quand’è avanti!,
Vai su un filo, con l’animo sospeso.
Se vuoi vivere, mutati in colomba;
se perire, o viandante, vieni a Roma,
alma garage, alma garage immenso.
Così Rafael Alberti, tradotto da Vittorio Bodini, in Roma pericolo per i viandanti. Roma incantatrice e inconoscibile, meta suprema e smarrimento, rivelazione e turbamento. Raoul Precht, raffinato narratore di scrittori (Stefan Zweig. L’anno in cui tutto cambiò) qui mette cinque grandi autori a confronto con Roma. Stendhal nel 1823, tramontato il periodo milanese (a Roma e Civitavecchia soggiornerà spesso negli anni della Restaurazione e della monarchia di luglio), nella città eterna ha modo di visitare i resti della basilica di San Paolo, divorata da un incendio che sospetta doloso e carbonaro. La lettera (apocrifa, bello il tour de force mimetico di Precht) che invia a Clémentine “Menti” Curial dà corpo a questi turbamenti, e rivela lo spirito caustico dello scrittore nei confronti della sua cerchia di liberali moderati. Nikolaj Gogol, a Roma per sfuggire al colera, lenire la delusione per la fredda accoglienza che L’ispettore generale ha ricevuto a Pietroburgo, tra il 1837 e il 1838 si innamora della cucina locale e conosce Giuseppe Gioachino Belli. L’incontro è avvenuto realmente, forse dal principe Poniatowski di cui Belli era segretario, forse a un ricevimento della principessa Volkonskaja. La congettura di Precht, sul filo di un’invenzione sorretta da corposi indizi, è che i Sonetti abbiano influenzato struttura e tono delle Anime morte. Di sicuro Gogol lodò Belli con Sainte-Beuve, e qualche reminiscenza di quello sboccato, inarrivabile dialetto romanesco si può ammirare nello skaz, il parlato quotidiano che Gogol porta in dote alla letteratura russa. Al soggiorno romano di Romain Rolland, tra il 1889 e il 1891, è dedicato il terzo racconto. Giovane d’ingegno ma non ancora narratore – il fluviale Jean-Christophe che gli procurerà nel 1915 il Nobel per la letteratura è di là da venire – a Roma il futuro amico di Gandhi e profeta dell’antimilitarismo scopre la sua vocazione musicale, si costruisce una solida fama di pianista che lo porterà a diventare musicologo – alla Sorbona sarà il primo a insegnare storia della musica – e, soprattutto, si libera dall’assillante tutela materna. Contemporanee e alcoliche le vicende degli ultimi due autori: Malcolm Lowry che dopo una rissa arriva a essere internato in clinica e che si perde in vagabondaggi e John Cheever incaricato di una missione per lui impossibile: cercare un luogo, a Villa Borghese, dove seppellire la topolina del figlioletto Ben. Cinque racconti, cinque sottili ritratti di scrittori, un romanzo fascinoso sull’impossibilità di sottrarsi alla malia di Roma.
Patti Smith, A book of days, trad. Tiziana Lo Porto, Bompiani, 2023

Patti Smith su Instagram. Una foto al giorno, 365 foto, ciascuna accompagnata da una breve didascalia. Pochi selfie, qualche ricordo di familiari e amici, misurati accenni alla carriera musicale. E tanti, tanti rimandi a poeti, musicisti e artisti, a luoghi visti, a vagabondaggi. Una viaggiatrice curiosa, una lettrice che fa scelte non banali. Il prediletto Rimbaud: Patti Smith ha acquistato la fattoria bombardata e in rovina della sua famiglia, nei pressi di Charleroi in Belgio. Assieme a tanti degli amati francesi: Camus, Genet, Nerval, Artaud, Baudelaire, la libreria Shakespeare & Co., Apollinaire, Daumal, Simone Weil, Godard (e Anna Karina). I giapponesi: Murakami, le ruote dei mulini di Sogni di Kurosawa, Dazai, Mishima, Akutagawa, Ozu. Affettuosamente gli altri: scelgo gli “insoliti” – Burroughs, Ginsberg e Corso non potevano mancare e suonano presenze obbligate – Beckett, Shepard, Tarkovskij padre, Bolaño, Nicanor Parra, Robert Walser, Hermann Broch. I riferimenti politici sono democratici – e antifascisti: il banjo di Pete Seeeger, con cui è orgogliosa di avere suonato in un benefit per tramandare la memoria della Brigata Lincoln, i volontari americani che combatterono contro i franchisti in Spagna – e culminano nel ricordo di un misconosciuto padre della patria: «Thomas Paine, scrittore, filosofo e rivoluzionario, scrisse “Il mondo è il mio paese, l’umanità è la mia razza e il bene è la mia religione”. Si dichiarò apertamente contrario alla schiavitù e alla crescente tirannia della religione». Per l’Italia annota suggestioni lontane dalla sua musica: Raffaello, Pasolini e La Scala, la Cappella degli Scrovegni, ma anche i ruderi della biblioteca di Adriano (Patti scrive che doveva avere 17 mila volumi) e San Severino Marche: «Nel giardino della Pinacoteca comunale Tacchi-Venturi, un piccolo ma meraviglioso museo che custodisce le pantofole di San Celestino. L’ho visitato tante volte, per il mio affetto per il Putto con delfino di Andrea del Verrocchio, che si trova su una modesta fontana». Un libro piacevole, per curiosare tra predilezioni e rare idiosincrasie – una sembra essere Lou Reed – di una rockstar. Nel 1996 il mensile Max mi chiese un testo per i cinquant’anni di Patti Smith. Eccolo. «Buon compleanno, Patti Smith. Il cavallo brado del rock americano, Patti la guerriera, Patti la secca, Patti la folle, compie cinquant’anni questo dicembre. Dal 1975 al 1979, per cinque anni convulsi e magici, la ragazza di Chicago che sognava di dormire nel letto di Arthur Rimbaud e che avrebbe voluto “nascere Michelangelo, Leonardo, Giovanna d’Arco e Anna Magnani”, fu l’acclamata regina della scena intellettual-punk di New York. La sacerdotessa carismatica di un rock femminile che mischiava diavolo e acqua santa, la Bibbia e i poeti maledetti dell’800, il catechismo e il fotografo Robert Mapplethorpe, che fu anche suo compagno per qualche anno e la ritrasse nuda e così scarna e ossuta da sembrare quasi immateriale. In quei cinque anni, Patti Smith pubblicò quattro album, di cui almeno due capolavori (Horses del 1975 e Radio Ethiopia del 1976). Nelle sue canzoni inseguiva le tracce di Arthur, imprecava contro il lavoro in fabbrica, interrogava gli angeli, danzava a piedi nudi, pisciava nei fiumi e inneggiava alla vitalità della notte, regno di tutti gli amanti (Because the night, scritta assieme a Bruce Springsteen). Con la sua voce stridente e malata, feroce e febbrile, che prestava a rock tiratissimi e senza fronzoli e a lunghissimi recitativi invasati e ipnotici, fece da modello illustre a decine di bambinacce degli anni ‘80. Oltre all’arte c’entrava la vita, come accade per quasi tutte le biografie esemplari degli eroi rock. Ragazza madre a fine anni ‘60, poi operaia nel New Jersey, commessa di libreria, pittrice, scultrice, poetessa (tre libri di versi, una collaborazione con Sam Shepard, frequentazioni giuste, da Andy Warhol a tutto il giro trendy-maledetto del Chelsea Hotel), Patti Smith fu un buon esempio di questa miscela fatta di vivere e creare. Scaduti i cinque anni, nel 1979 sposò un chitarrista ex ribelle (Fred Sonic Smith, leader degli oltraggiosi MC5 di Chicago) e decise di fare la moglie e la madre. Per annunciare il ritiro dalle scene scelse l’Italia: due concerti memorabili a Bologna e Firenze, più di 80mila spettatori e migliaia di poliziotti in assetto di guerra, erano gli anni di piombo. Un lunghissimo, volontario esilio, con una sola interruzione (Dream of life, discreto album del 1988). E un ritorno trionfale quest’anno: una canzone per la colonna sonora di Dead man walking di Tim Robbins, assieme alla crema del radical-rock (Walkin’ blind); una comparsata di lusso in New adventures in hi-fi dei R.E.M. (la canzone è E-bow the letter); un libro di poesie per Einaudi e un racconto per Bompiani (Il Mar dei Coralli). E, soprattutto, un disco, un gran disco, nuovo di zecca, Gone again. Dove la sua voce da musa inquietante vede cannibali e piranha nell’assolata Georgia, piange il suicida Kurt Cobain (About a boy) e mette in guardia contro le vanità del mondo, sputando versi come proiettili di una mitragliatrice. Il cavallo brado intanto è diventata una saggia giumenta che si presenta ai concerti con qualche capello grigio e i due figli, Jess e Jackson, otto e tredici anni. E alla domanda: “Che cosa hai fatto in tutti questi anni?” risponde: “Ho lavato molti panni”».
Jacopo Veneziani, La grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna, Feltrinelli, 2023
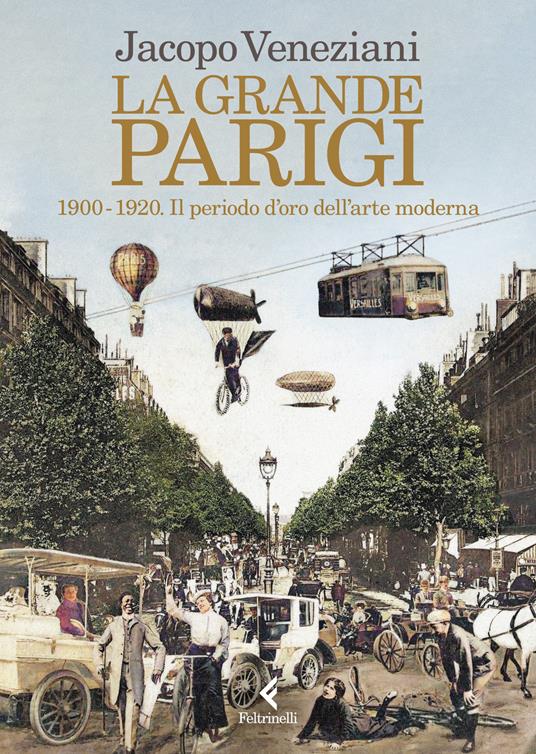
Pablo, Amedeo & c: Matisse, Derain, Van Dongen, Chaim Soutine che appestava la sua soffitta con le carcasse che si era prese al mattatoio per dipingerle. Il romanzo corale di Parigi centro del mondo, il posto dove “bisognava esserci per essere liberi”, copyright di Gertrude Stein. Pablo Picasso approda a Parigi da Barcellona, dopo un viaggio in treno di trenta ore, nell’autunno del 1900. Fame e determinazione feroce, soffitte gelide o bollenti, illuminazione scarsa e cibo inesistente – c’è una scatola di sardine che deve bastare per una settimana – e un’arte che continua a mutare pelle, mai simile a se stessa. Allo scoppio della prima guerra mondiale Picasso è già artista affermato e quotato, che può lasciare la prima compagna di bohème, Fernande Olivier, per fare il salto da Montmartre a Montparnasse. Amedo Modigliani, figlio della buona borghesia sefardita di Livorno, a Parigi arriva nel 1905. Con pochi soldi in tasca, la tisi che galoppa, le sbronze ripetute e nessun successo, comincerà ad affermarsi alla vigilia della morte nel 1920. Tra queste due date e questi due caratteri assai dissimili tra loro si dipana l’invenzione della modernità nelle arti, dopo la prima rivoluzione impressionista. I protagonisti – i fauves e i cubisti, Apollinaire e Max Jacob, Satie e Cocteau –, i mercanti e i mecenati qualche volta speculatori ma più spesso soccorrevoli – splendida la figura di Berthe Weil – , i furori nazionalistici contro i boches e le sbruffonate dei futuristi in trasferta, la fascinazione per l’arte africana e i posti di ritrovo, dal Lapin Agìle alla Closerie des Lilas alle mille trattorie dove si segna sul conto o si paga con qualche disegno. Jacopo Veneziani ha la competenza dello storico dell’arte e la vivacità del narratore.
James Wood, Come funziona la critica, trad. Raffaella Vitangeli, Minimum Fax, 2023

«Quando scrivo di un romanzo o di un autore sto essenzialmente offrendo la mia testimonianza. Sto descrivendo un’esperienza e cercando di stimolare nel lettore un’esperienza di quell’esperienza. Henry James definiva il compito del critico “eroicamente vicario”. È un po’ come far sentire a un amico un brano che ci piace molto… Vuoi fare in modo che l’ascoltatore senta (o veda) la stessa cosa che senti (o vedi) tu, vorresti condividere quell’esperienza. La critica è esattamente questo: un’avventurosa condivisione. Ciò che distingue un saggio-recensione di taglio giornalistico da un saggio accademico è la quantità e la qualità di tale condivisione, la quantità e la qualità del gesto che Cavell aveva descritto come “indicare l’opera d’arte”. Dopo tutto il saggio-recensione non si limita a indicare qualcosa, ma lo indica mentre lo ri-descrive. Più che “Devi sentirlo”, l’analogia in ambito musicale sarebbe “Ascolta, devo suonartelo al pianoforte”». James Wood, inglese trapiantato negli Stati Uniti e venerato recensore del New Yorker – fondamentale e raccomandato il suo Come funzionano i romanzi – in questa raccolta di saggi scritti fra il 1997 e il 2017 ci suona al pianoforte alcuni classici e molti contemporanei. Il pregio maggiore dei suoi interventi – l’analogia in questo caso è pittorica più che musicale – sta nell’educare chi legge alla differenza tra il “vedere” e il “guardare”. Don Chisciotte o delle pessime conseguenze che hanno le buone intenzioni (secondo Wood il principe Myskin dell’Idiota, nella sua bontà nefasta, è nipotino dell’hidalgo). Anton Cechov e Lev Tolstoj come maestri, assai diversi tra loro, nella costruzione dei personaggi. La “mistica” Virginia Woolf che cerca di rendere la contemporanetà dell’accadere – e il pensiero va a Flaubert e alla sua panoramica di una via nell’Educazione sentimentale. La “compostezza” di Primo Levi nel testimoniare l’orrore – lo stesso smorzare i toni che osserva in Sebald. Il grande e condivisibile omaggio a Joseph Roth. Di particolare interesse le riserve sui post-moderni – Zadie Smith, Don DeLillo, Salman Rushdie, Paul Auster accusato di “vacuità” – per i quali Wood conia la categoria di “realismo isterico”: un eccesso di azione e di personaggi, e un eccesso – paranoico, dice Wood – di concatenazione tra gli eventi, per mascherare la sfiducia nello scavo dei personaggi. Una sorta di “famolo strano” che mi è accaduto spesso di leggere o di vedere/guardare: donne che affettano le cipolle, che banale, meglio con la maschera antigas. Personaggi che vivono in una casa, che banale: meglio in una magione firmata da Frank Lloyd Wright. Che fanno le cameriere, che banale: meglio con un costume da sirena addosso. Centrale nella raccolta l’attenzione per la “letteratura del nomadismo”: il post-esilio, l’incapacità-impossibilità di tornare a casa quando si potrebbe, che distingue i nuovi – Aleksandar Hemon, W. G. Sebald fra gli altri – dai vecchi expat come Nabokov e Dovlatov. Il non essere di casa in nessun posto. Menzioni onorevoli per Cormac McCarthy e per la nostra Elena Ferrante, il caloroso elogio della tedesca Jenny Erpenbeck – Voci del verbo andare, in Italia lo ha pubblicato Sellerio. E un piccolo botto finale: “L’ora della ricreazione”, sorprendente e vivacissimo omaggio a Keith Moon, lo stralunato batterista degli Who.
Franco Zanetti/ Federico Pistone, Eiar Eiar alalà, Baldini + Castoldi, 2024

La radio è stata fondamentale per la mia generazione di born in the fifties, figurarsi per i nostri genitori e nonni. Io ci ascoltavo, assieme alla famiglia, i programmi di varietà, Corrado, Paolo Panelli e Bice Valori, Alberto Sordi (Mario Pio) e tanti altri. E per conto mio Arbore & Boncompagni (Bandiera gialla, Alto gradimento, Per voi giovani), nonché Adriano Mazzoletti e Renzo Nissim (Io e il mio amico Osvaldo) che contrabbandavano il jazz. Mio nonno paterno Filippo, che non ho fatto in tempo a conoscere, ci ascoltava l’opera e le canzoni di questo libro, allestito con divertito puntiglio da Franco Zanetti e dal suo compagno d’avventura Federico Pistone. Le canzoni della radio, le canzoni dell’Eiar antenata della Rai dal 1924 al 1944. C’è, ed è tutto sommato la parte meno esplorata da chi traffica in modernariato canoro, tutta l’innodia fascista: anche un inno alla X Mas composto dal principe nero Junio Valerio Borghese. Ma soprattutto abbonda, e chissà se lo ricordiamo soltanto noi più attempati, lo scintillante songbook italiano, immune dalla propaganda di regime se non blandamente (le reginelle campagnole, le Rosabelle del Molise, le casette piccine e le mille lire al mese che esaltavano le dolcezze campagnole e la placida vita del piccolo-borghese) perché la canzone, non diversamente dalle commedie di Camerini, era anche “arma di distrazione di massa”. Quante canzoni da riassaporare, da succhiare come caramelle. Anche con i loro stereotipi che ascoltati oggi fanno tenerezza: gli idoli di perversità che, sulla scia del decadentismo, erano le donne (Vipera, Balocchi e profumi), la disillusione (Scettico blues), l’esotismo (Creola, Tango delle capinere), le morti melò sul lavoro (Miniera, Ferriera), l’emigrazione (Lacreme napulitane). Assieme a capolavori che hanno superato indenni la sfida del tempo: le meravigliose Bambina innamorata, Casetta de Trastevere (ascoltavo l’autore, il grande chitarrista Alfredo Del Pelo, eseguirla negli album della preziosa serie “Fonografo italiano”, non sapevo fosse un’accorata protesta contro lo sventramento deciso da Mussolini per creare la Via dell’Impero), Chiove, Dicitencello vuje, e soprattutto le mie preferite di sempre: Ma l’amore no (Alida Valli, chi altra?) e In cerca di te o, se vi torna più familiare, Sola me ne vo per la città (Nella Colombo, ma sono affezionato alla versione che ne diede Mariangela Melato nel Regista di matrimoni di Marco Bellocchio). Canzoni melodiche cantate da tenori, stornellatori e gorgheggiatrici, canzoni surreali e cariche di swing all’italiana tollerate o bandite a fasi alterne dal regime: motivetti irresistibilmente balbuzienti (Ba-ba-baciami piccina di Alberto Rabagliati), mitemente surreali (Il pinguino innamorato), fatti apposta per ballare (Quel motivetto che mi piace tanto). Spesso “canzoni di fronda” sospette ai censori: Pippo non lo sa perché pareva alludesse ad Achille Starace, Maramao perché sei morto a Costanzo Ciano, Bombolo all’adiposo Guido Buffarini Guidi. Quando il preso di mira, ma gli autori ovviamente negavano, non era il duce: il “tamburo principale della Banda d’Affori che comanda 550 pifferi” (550 erano i componenti della Camera dei fasci e delle corporazioni), il “crapa pelada” dell’omonima canzone, persino il destinatario di Un’ora sola ti vorrei al quale dire “tutto quello che non sai” (ma i più maliziosi, alludendo alla sua sbrigativa bulimia amatoria, intonavano sprezzanti del rischio, imitandone la parlata, “un’ora sola ti vorrei per farne quattro, cinque o sei”). Opera meritoria con qualche svista storica, questa di Zanetti & Pistone, mare canoro nel quale è dolce nufragare. Contributi complici di Riccardo Bertoncelli, Vincenzo Mollica e Francesco Guccini.
Stefan Zweig, L’obbligo, trad. Iolanda e Luca Sanfilippo, intransito, 2022
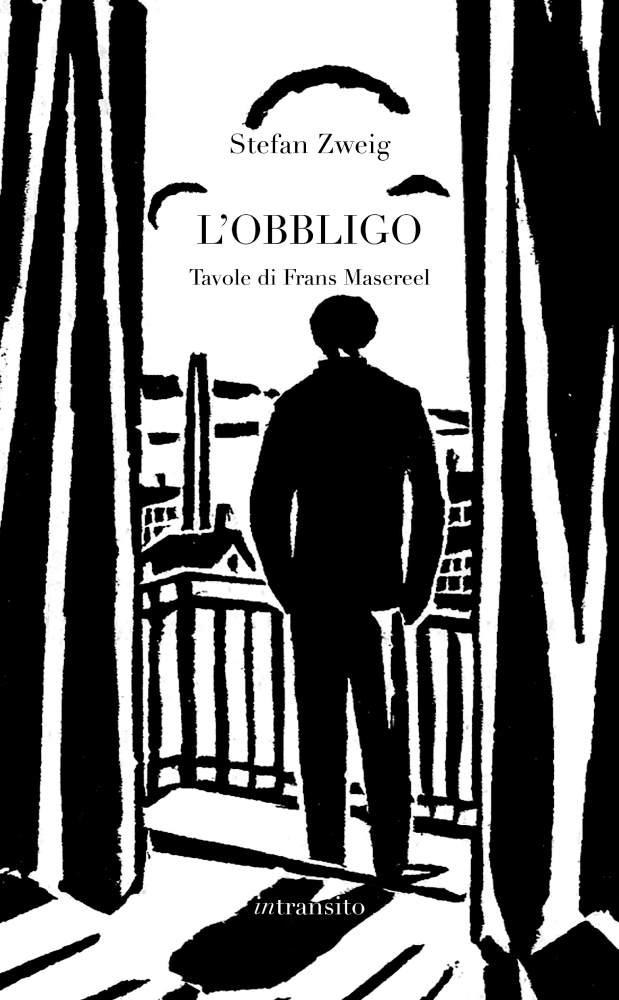
«Ormai per lui la madrepatria significava solo obbligo e prigione. All’estero, invece, si sentiva a casa e l’Europa gli restituiva l’umanità». Un pittore tedesco, Ferdinand, è riparato nella Svizzera neutrale allo scoppio della guerra. Ma una lettera del comando militare gli ingiunge di rientrare in patria e prepararsi a partire per il fronte. La ragione, che parla in favore della pace e contro la mostruosità del conflitto in corso, gli suggerisce di stracciare il richiamo. L’altra parte di sé, più fatalista e “soccombente”, per usare un termine caro a Thomas Bernhardt, lo persuade che è inutile opporsi e pensare che lui, soltanto lui, scanserà il giogo. A nulla servono le proteste appassionate della moglie Paula, persino l’aut aut che lei gli pone: se parte compie una scelta definitiva che mette fine al loro matrimonio. Il richiamo della macchina militar-burocratica, del moloch statuale, è più forte di ogni appello alla ragione. Così va al consolato di Zurigo deciso a obiettare e ne esce con il precetto, senza che abbia osato proferire verbo. Così prende il treno per tornare in Germania e soltanto al confine, vedendo un convoglio di prigionieri francesi che tornano a casa, molti fra loro i mutilati, “apre gli occhi”. Non andrà, diserterà sottraendosi all’ “obbligo”. Un brutto racconto per una nobile causa. Tutto superficie e passione esacerbata, platealità e mancanza di sottigliezza, come un dramma di Ibsen. Amo Zweig ma questa non è fra le sue prove più riuscite, assai meglio di lui sul tema hanno scritto, in patria, Joseph Roth e Karl Kraus. E, in Francia, il mite pacifista Jean Giono. Datato 1917, L’obbligo testimonia la sofferta conversione di Zweig dall’interventismo del 1914 a un pacifismo tolstojan-rollandiano. Bella edizione italiana, con traduzione e postfazione accurate e le illustrazioni originali di Frans Masereel.