Sfugge ai generi – romanzo, saggio, scritto di attualità? – ‘Piedi freddi’ l’ultimo libro di Francesca Melandri che trova il suo luogo in Ucraina e il suo tempo nella guerra di ieri – la ritirata di Russia vissuta da suo padre – e in quella di oggi. E disturba e fa molto pensare nel porre interrogativi senza sconti su come, dal caldo delle nostre case, leggiamo questo conflitto e i suoi protagonisti
Ci sono libri che è difficile rendere nella loro complessità, libri che sono come un millefoglie al lampone perché mentre li divori ne percepisci la stratificazione, l’aspro e il dolce, la sostanza che scivola più facilmente in gola e quella che deve essere masticata per essere digeribile: e certamente Piedi freddi di Francesca Melandri è uno di questi. È un libro che nella sua complessità è più facile da leggere che non da recensire, perché fin dall’inizio sfugge alle definizioni: non è un romanzo di guerra ma riporta stralci di romanzi di guerra, non è un libro sull’attualità ma parla di fatti tragicamente attuali, non è un saggio e non finge mai di esserlo ma si basa (anche) sullo studio della storia e dei fatti storici, è un libro a tratti tenero e a tratti implacabile e rabbioso, inflessibile.
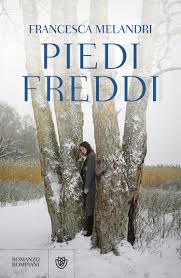
I piani principali sono due, e hanno come elemento unificante un dato geografico – l’Ucraina – e una tragedia: la guerra. Perché, come ricorda in maniera volutamente ossessiva l’autrice, quella che noi chiamiamo ritirata di Russia si svolse “in quella Russia che poi era per lo più Ucraina”. A questa ritirata di Russia prese parte il padre dell’autrice, l’alpino Franco Melandri, uomo affascinante e inaffidabile, coraggioso magari suo malgrado e cialtrone, affettuoso e bugiardo, di quei bugiardi iperbolici che non raccontano menzogne, ma fanno della vita letteratura: e la figlia cerca di ricostruirne le vicende in guerra, con i toni intimi del memoir e gli strumenti degli storici e dei giornalisti. In parallelo si parla dell’altra guerra, quella cominciata nel 2022, l’invasione dell’Ucraina che Putin cercò di gabbare, sapendo che qualcuno gli avrebbe creduto, per “denazificazione”: si parla di quest’altra guerra e delle reazioni, o mancate reazioni, che ha suscitato tra noi, che la guerra non l’abbiamo mai conosciuta, generazione baciata (finora) da una fortuna straordinaria.
È questo l’aspetto che mi ha colpita di più: mi sono sì intenerita di fronte ai racconti familiari, al rapporto difficile con un padre impegnativo sotto tanti punti di vista, ma ad attirarmi ancor più è stata l’analisi impietosa del nostro (nostro nel senso di italiani) rapporto con la storia. Siamo, per una serie di ragioni, uno dei popoli più tenacemente attaccati alle nostre narrative. In questo, diciamocelo, ci hanno aiutati i tedeschi: talmente integerrimi i nazisti nella loro crudeltà, talmente ottusi e professionali nella loro ferocia da permetterci di dimenticare e forse anche di far dimenticare che in Russia, in Grecia, in Albania non ci andammo per portare sollievo alle popolazioni locali e proteggerle dai cattivi tedeschi, ma per partecipare a conquiste e spoliazioni. In Grecia ci dicono ancora adesso “stessa raza, stessa faza”, eppure siamo stati lì da fascisti, e ci siamo presentati come “raza” superiore, anche se non lo eravamo.
E la narrativa cristallizzata deforma i nostri pensieri anche rispetto alla guerra dell’oggi. I russi – i buoni che ci hanno salvato dal diventare schiavi del Reich. Gli ucraini – i nazisti. C’è del vero, naturalmente: senza Stalingrado, senza il sacrificio di milioni di soldati sovietici, chissà, oggi parleremmo tedesco (per la verità io non parlerei affatto, in quanto non sarei nata). Ma vittime della nostra visione eroico-manichea tendiamo a ignorare quello che accadde tra il 1917 e il 1939, ci piace sposare l’immagine di un nazionalismo ucraino intrinsecamente fascista, e da questa nostra ignoranza nasce il non saper leggere quello che è venuto dopo. Ci impedisce di vedere bene, a noi che siamo nati in un Paese in cui il comunismo è stato il volto serio e gentile di Enrico Berlinguer, sono state le feste dell’Unità con il loro calore umano meraviglioso, che per i polacchi, gli ucraini, i finlandesi, gli abitanti dei paesi baltici, il comunismo è stato l’oppressione russa: cioè, chiaramente lo sappiamo, lo sappiamo, però non lo capiamo.
È quando si tratta di questo argomento che Piedi freddi si fa rabbioso, di una rabbia che nasce dal dolore e dalla delusione dell’autrice di vedersi estraniata da un mondo che pure dovrebbe essere il suo, per storia personale e familiare e formazione culturale. E sono questa rabbia, questa passione, a fare di questo libro un libro poco furbo, un libro che suscita disagio e fa molto, molto pensare.
Nel film Il sol dell’avvenire Nanni Moretti sublima nell’invenzione questo disagio, facendo sfilare i compagni per le strade di Roma, in sostegno ai compagni ungheresi massacrati nel 1956. Ma è, appunto e purtroppo, soltanto un film.
Foto di Dmytro Tolokonov su Unsplash