Spazia dall’attualità più dolorosa, ovviamente Gaza ma anche la Russia di Putin, al recupero dei lirici greci alla cronaca nera tra Turatello e Vallanzasca il percorso di letture di questo mese. Senza dimenticare uscite italiane che ben promettono e utili rovesciamenti di prospettiva come nel James di Percival Everett
Elena Bosi, Mio padre è nato per i piedi, Neri Pozza, 2024
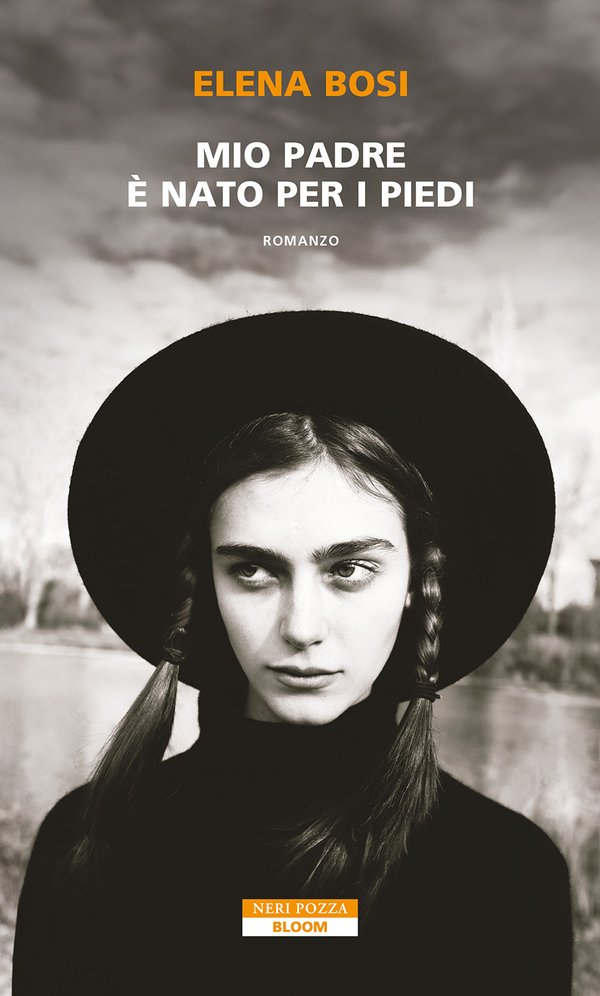
Un paesino del modenese, Concordia. Un famiglione allargato e una piccola comunità, con i generosi, gli arguti, gli eccentrici e i mattocchi. Al centro della scena lei, Giulia, tre anni all’inizio della narrazione, figlia di bottegai. Una bambina spigliata che va in giro in triciclo sotto i portici cantando Bandiera rossa – anche al farmacista, anche alle suore dell’asilo – perché gliel’hanno insegnata i vecchietti che bevono il grappino nel piccolo bar in piedi che c’è in fondo al negozio dei genitori. Giulia che rimprovera i vecchietti quando bestemmiano – diocàn proprio no, meglio dio gatto o dio uccellino – e che entra negli altri negozi per fare compere, come i grandi.
Un mondo affettuoso e bizzarro, quello di Concordia. Con il nonno che ha perso un polmone in una tempesta di sabbia, il dentista che cura tutti i mali, la cartolaia che si rifiuta di vendere i libri e spinge i clienti ad andare in biblioteca, la zia che riconosce le donne incinte dal collo e quell’altra, suora, che ipnotizza i topi. Una nonna che dorme mezz’ora per notte, sempre affaccendata, che di giorno mangia come un passero e di notte spazzola i dolcetti che tiene chiusi in un armadio. E l’altra nonna che le ha promesso in eredità gli orecchini, quando muore per prima cosa glieli deve sfilare. E poi la cliente che ha la fissa delle zucche e quella che non è mai contenta, e la vicina di casa ringhiosa o muta.
Un piccolo mondo di cui si sorride, con le vecchie case attaccate una all’altra che vengono giù insieme nel terremoto del 2012. Tra Guareschi e Paolo Nori, un romanzo corale intessuto di piccoli aneddoti affettuosi e stravaganti, un “antidotum melancholiae” semplicemente delizioso.
Nicola Erba, La banda Dovunque, Milieu, 2023

Banda Dovunque perché non operavano soltanto a Milano: anche a Bologna e Imola, anche in altri centri del nord Italia. A bordo di auto veloci, di preferenza Citroen e Lancia Aprilia, una la ruba a Eduardo De Filippo uno dei componenti della banda, Mario il Napoletano. Con i mitra spianati e almeno in un’occasione travestiti da carabinieri per assaltare una gioielleria di Città Studi, ma senza spargimenti di sangue. Tra il 1948 e il 1949 balza agli onori della cronaca la prima banda di gangster professionisti che mette in ombra i molti rapinatori brutali quanto improvvisati di quel convulso dopoguerra. Tra i componenti due che si erano fatte le ossa in Francia assaggiandone anche le galere (Joe Zanotti e Giuseppe Seno), l’ex fascista Alfredo Torta, l’ex studente di filosofia e partigiano Ettore Bogni. E soprattutto un comprimario, una comparsa che si prenderà tutta la scena, il ventunenne Ugo Ciappina che si professa comunista.
Sgomina la banda nel 1949 il questore Vincenzo Agnesina, ex guardia del corpo di Mussolini. E subito viene confezionato il “complotto”. Ciappina, iscritto alla sezione Carrobbio del Pci, tenore di vita più che modesto anche dopo le rapine, dice di avere girato la sua parte a un più che ambiguo armeno, Calust Megherian, aria da professore anche se fa il mercante di tappeti, che a sua volta avrebbe dovuto girarla al partito. A casa di Ciappina i poliziotti trovano una machine-pistole di fabbricazione tedesca, due rivoltelle, tre silenziatori, quattro caricatori, una serie di baffi e barbe posticci, tre ceroni per alterare i lineamenti. E in casa di un amico trenta bombe a mano, 27 chili di tritolo, due di plastico, 6 di Tnt, 22 fiale di liquido corrosivo e molti innesti chimici.
Ciappina dice che è un arsenale partigiano e che lo stava rivendendo ai sionisti che operavano in Palestina. La polizia individua anche decine di soldati di leva che hanno fatto affluire a lui e Megherian informazioni militari riservate: per qualche mese (in quel periodo opera a Milano anche la Volante Rossa che giustizia ex fascisti, verrà smantellata a Lambrate nel 1949) si parla di una rete spionistica a favore di Mosca, di un’organizzazione terroristica che si teneva pronta per l’insurrezione.
Al processo si sgonfierà tutto, informazioni modeste e non top secret, e intanto il Pci, che aveva già espulso Ciappina e Megherian in tempi non sospetti, si chiama fuori (le indagini lambiscono anche il giovane Giangiacomo Feltrinelli arrestato per qualche giorno e subito scagionato, alla vicenda accenna anche Carlo Feltrinelli nel suo Senior Service). Dopo le condanne, degli altri membri della Banda Dovunque si perderanno le tracce. Continuerà a fare parlare di sé soltanto Ciappina, ormai bandito comune senza alibi politici: condannato a 15 anni ma scarcerato nel 1955, verrà nuovamente arrestato nel 1958 per avere assaltato in via Osoppo assieme a sei complici un furgone portavalori della Banca Popolare di Milano, bottino 600 milioni, per i giornali “la rapina del secolo”. E negli anni successivi continuerà a entrare e uscire di galera.
Restano, alla fine della lettura, almeno due suggestioni. La persistenza del mito rivoluzionario (e della lotta armata) nei bassi ranghi della militanza comunista, mentre è in via di emarginazione l’oltranzista Pietro Secchia: se ne è indagato per sparsi aneddoti, mai mi sembra con un’opera di inquadramento generale. E la terrificante prosa della cronaca nera dell’epoca (sono qui abbondantemente antologizzati il Corriere Lombardo e il Corriere d’Informazione) con il suo impasto di allarmismo, mattinale di questura e velina governativa.
Percival Everett, James, traduzione di Andrea Silvestri, La Nave di Teseo, 2024

«Quegli stronzetti erano nascosti là fuori nell’erba alta. Non proprio piena, ma luminosa, la luna era alle loro spalle, e così riuscivo a vederli come in pieno giorno sebbene fosse notte fonda. Le lucciole lampeggiavano sullo sfondo nero. Stavo aspettando davanti alla porta della cucina di Miss Watson, facendo dondolare un’asse sconnessa dei gradini, sapendo che lei mi avrebbe detto di sistemarla l’indomani. Aspettavo che mi desse una teglia di pane di granturco che aveva fatto con la ricetta della mia Sadie. Aspettare è una parte importante della vita di uno schiavo, aspettare e aspettare di aspettare ancora un po’. Aspettare gli ordini, aspettare il cibo. Aspettare la fine delle giornate. Aspettare la giusta e meritata ricompensa cristiana alla fine di tutto questo.
Quei ragazzini bianchi, Huck e Tom, mi stavano osservando. Erano sempre lì a fare qualche gioco di fantasia in cui potevo essere il cattivo o la vittima, ma in ogni caso il loro giocattolo. Saltellavano di qua e di là per le pulci, le zanzare e le punture di altri insetti, senza mai avvicinarsi. Conviene sempre dare ai bianchi quello che vogliono, così avanzai nel cortile e gridai alla notte: “Chi è che ci sta fuori nel buio a quel modo?”».
Sì, avete letto bene. Huck e Tom sono Huck Finn e Tom Sawyer, i due eroi creati da Mark Twain, e non sarà fuori luogo ricordare qui che per Hemingway Le avventure di Huckleberry Finn (1884) era «il romanzo definitivo sull’America». E James è Jim, il nero tontolone e superstizioso al quale Huck Finn si affezionava. Jim non è un vezzeggiativo: è “Jim Crow”, Jim il corvo, nomignolo crudele con cui i razzisti bianchi dileggiano gli schiavi. E “leggi Jim Crow” si chiameranno, dopo la guerra civile e l’abolizione della schiavitù, tutte le norme che nel Sud terranno a lungo segregati i neri. Qui invece, in questo romanzo comico e tragico, avventuroso e profondo al tempo stesso, che gioca con il fuoco di vicende terribili senza mai scottarsi, Jim ha scelto di chiamarsi James, di diventare l’io narrante e il protagonista. Il controcanto a Mark Twain.
James fa lo scemo per pagare il meno dazio possibile – ma il dazio, frustate o stupri o divisione forzata delle famiglie, è per gli schiavi difficile da eludere – e istruisce gli altri schiavi all’arte del double talk e della dissimulazione. «I bianchi si aspettano che parliamo in un certo modo e non deluderli su questo fronte non può che esserci d’aiuto. Se si sentono inferiori, gli unici a soffrirne siamo noi… Allora, ripassiamo un attimo le basi». E spiega, paziente e pignolo: mai sostenere lo sguardo, mai parlare per primi, mai identificare un problema prima di un bianco (per esempio, se la casa brucia, dire: “che succede?” e non “al fuoco, al fuoco”). Al termine della lezione, gli schiavi ripetono in coro: tanto meglio si sentono i bianchi, tanto più siamo al sicuro. Chiamata a tradurre in “schiavese”, la bambina February se la cava con un «Più meglio si sentono loro, più stiamo al sicuro noialtri». La traduzione, peraltro ottima, di Andrea Silvestri non riesce a dar conto fino in fondo del linguaggio da “sì, badrone” che circola nell’originale: «Da mo’ betta dei feels, da mo’ safer we be”.
Dissimula, James che per i padroni è Jim. Di saper leggere e scrivere. Ha imparato da solo e di soppiatto, nella biblioteca del giudice Thatcher ha letto Voltaire e Locke con cui nel delirio della febbre si confronta: e sono dialoghi insieme di arguta vis comica e di sottile confutazione delle ambiguità che anche il pensiero illuminista nasconde.
E scappa, perché Miss Watson vuole venderlo a un uomo di New Orleans, separandolo dalla moglie Sadie e dalla figlioletta Lizzy. Il suo obiettivo sarà trovare la libertà e il denaro necessario per poterle riscattare. Gli è compagno di fuga il ragazzino Huck che le botte del padre ubriacone hanno quasi ammazzato. Nella fuga fraternizzano e James è quasi padre di Huck.
Sulla loro strada incontrano imbroglioni (il Re e il Duca, che campano abbindolando gli zotici), un gruppo di minstrel bianchi che si tingono la faccia di nero con il lucido da scarpe per rifare il verso agli schiavi (il loro leader è personaggio storico: Daniel Decatur Emmett 1815-1904, autore tra l’altro di Dixie e Old Dan Tucker, rifatte in tempi recenti da Bob Dylan e Bruce Springsteen), sadici padroni di segherie, soprastanti stupratori, linciaggi (ne è vittima uno schiavo che ha rubato un mozzicone di matita per regalarlo a James).
Soltanto una riscrittura dell’Huck Finn? Il romanzo di Everett, in realtà, si affianca al capolavoro di Twain con pari felicità e dignità. In epoca di “cancel culture” non rinnega la grande tradizione americana (Mark Twain, con cui nei ringraziamenti finali si augura di poter pranzare all’inferno) ma, sereno quanto implacabile, mette i puntini sulle i. Prende, per così dire, posto in una tavola finora imbandita soltanto per i bianchi. Un romanzo felicissimo nella scrittura e nell’invenzione, sottile nelle psicologie, esatto nelle notazioni storiche. In una parola: strepitoso.
Gad Lerner, Gaza. Odio e amore per Israele, Feltrinelli, 2024

Comincia tutto il 7 ottobre 2023. Con 1200 cittadini israeliani seviziati e uccisi dal pogrom di Hamas che travolge una frontiera considerata fino a quel momento invalicabile, con 250 cittadini presi in ostaggio: il massacro di ebrei più terribile e feroce dai tempi della Shoah. Prosegue, ed è ancora in corso, con la reazione fuori scala dell’esercito israeliano che fa 40 mila morti fra la popolazione di Gaza, soprattutto civili. E che in questi giorni attacca il Libano.
«…Era il giorno stesso, quel maledetto 7 ottobre, che bisognava decidere in fretta, sballottato io come tutti fra opposte emozioni: il sollievo per i figli scampati al pericolo; l’apprensione per i parenti e gli amici che vivono laggiù, molti dei quali fino al giorno prima scendevano in piazza contro i tentativi di svolta autoritaria del governo Netanyhau, ma ora dovevano porre rimedio alla sua inefficienza; l’imbarazzo di non condividere la sorte dei giovani riservisti arruolati per fronteggiare l’attacco; l’orrore per la ferocia esibita da Hamas; l’angoscia per la fragilità inaspettata che Israele rivelava.
Decidere, dunque, quale posizione assumere. Schierarsi in nome del mio vincolo di appartenenza al popolo ebraico, del mio amore nonostante tutto per questo Israele che da anni mi appariva prossimo allo snaturamento? Schierarsi e basta, di fronte all’aggressione subita, ammettendo che neanch’io avrei mai immaginato un fallimento tanto catastrofico quando scrivevo di un Israele che stava andando verso la perdizione? Tacere per non espormi all’accusa di tradimento che già in passato mi era stata rivolta e che sapevo mi sarebbe di nuovo toccata? Ma quale solidarietà potevo esprimere a un uomo come Netanyahu che si era scavato la fossa da solo, e peggio per lui se non fosse che stava trascinando tutti con sé nel precipizio?».
I dilemmi dell’“ebreo buono”, come Gad Lerner definisce se stesso con dolente autoironia. «Quello che difende Israele ma ha anche il coraggio di parlarne male. Uso il corsivo per evidenziare la sgradevolezza di certi schieramenti di comodo. Sospetto di essere visto bene, io, l’“ebreo buono”, per via del retropensiero diffuso che ci siano in giro una maggioranza di “ebrei cattivi”. E la cosa ovviamente non mi va giù».
È difficile far convivere passione e pacatezza, senso di appartenenza e attitudine a mettersi nei panni degli altri, e Gad Lerner ci riesce. Sfilano così in queste pagine lo screditamento di Israele agli occhi del mondo e l’immoralità devastante di chi accantona l’etica a favore della forza. Il fanatismo identitario e il messianismo religioso, comuni ad Hamas e all’ultradestra dei coloni. Il fanatismo degli ortodossi che ha isolato Israele come mai prima d’ora, il fanatismo di Hamas (e del suo mandante iraniano) che porta alla perdizione i palestinesi.
Molte altre cose circolano in queste pagine dense e lucide: la fine del Rinascimento ebraico e la necessità che la diaspora, veicolando l’universalismo e il lascito di tolleranza del patrimonio ebraico, torni a prevalere; la frammentazione della società israeliana e il rinchiudersi a riccio delle comunità ebraiche italiane; la lezione dimenticata di Primo Levi e il mito scellerato dell’omogeneità etnica sbandierato da Netanyhau, che si porta dietro il paradossale sionismo sbandierato dalle destre europee, dai discendenti del fascismo e del nazismo; il peso delle parole, che non possono essere scagliate come pietre.
Lerner conclude con l’invito a rimettere in campo un’utopia necessaria e dismessa, a farla diventare realtà per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti: la ripresa di un processo di pace, la soluzione necessaria e ineludibile di due popoli e due stati, accantonata troppo a lungo mentre le macerie di questa guerra hanno sepolto anche le tronfie e ciniche illusioni che la soluzione di tutto risieda nei muscoli e nelle armi. Gaza è un libro nobile e doloroso, sincero e saggio. Un libro necessario.
PS. Gad Lerner conclude così: «L’ebraismo non cerca la santità negli uomini, Dio è altrove da noi. Onora piuttosto la figura dello zaddiq, il Giusto. Che giusto si è mostrato lungo tutto il suo percorso di vita controcorrente, talora senza che di ciò nulla trapelasse o comunque senza che lui la dichiarasse come una missione.
Ora, concluso il libro dettato dall’urgenza degli eventi, posso scriverlo: credo di essermi imbattuto in una figura del genere anche fra gli ebrei italiani del secolo scorso. Un vero Giusto. Si chiamava Umberto Elia Terracini. Credeva nella giustizia sociale e voleva bene a Israele. Trascorse 6183 giorni di detenzione ininterrotta sotto il fascismo, più di qualunque altro prigioniero politico; firmò la Costituzione della Repubblica avendo presieduto l’Assemblea in cui fu concepita. Ma questa è un’altra storia. Forse un giorno la racconterò». Spero proprio che lo faccia.
Lirici greci tradotti da Salvatore Quasimodo, Mondadori, 1971 (ma 1940)
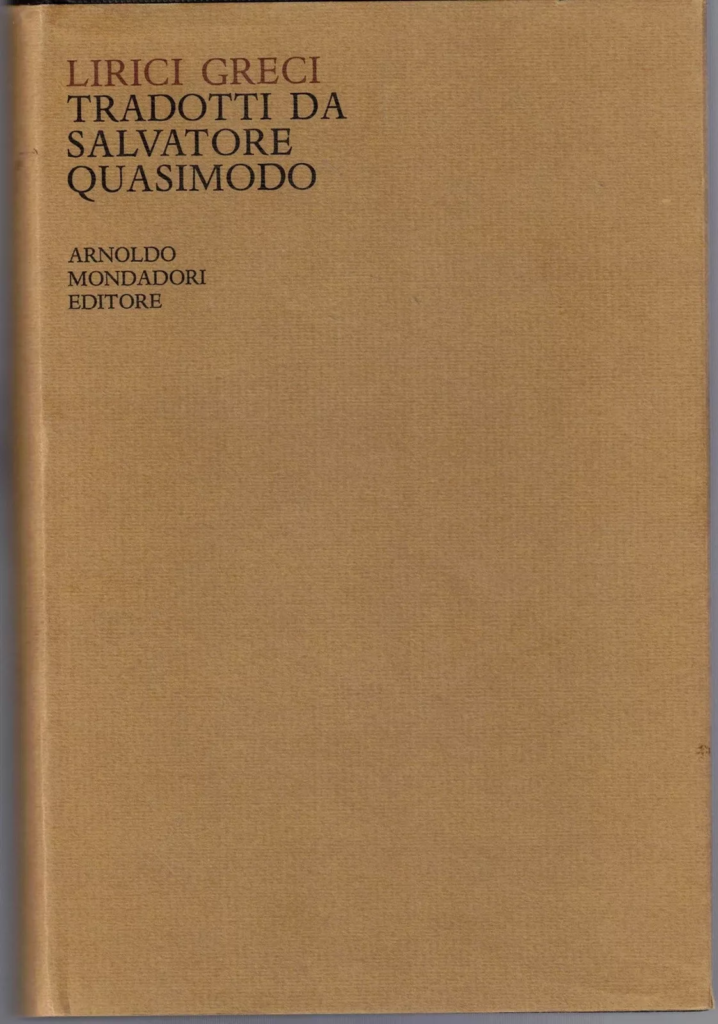
Un’impresa pionieristica, un’impresa dilettantesca. Le due cose marciano di pari passo, e non è detto che il dilettantismo sia un male. Tra le due guerre, oltre a Quasimodo erano traduttori dilettanti Elio Vittorini ed Eugenio Montale, e anche il più attrezzato Cesare Pavese ogni tanto prendeva sfondoni. Ma molta della grande letteratura americana novecentesca (per Pavese anche molto ‘800 e qualche ‘700) ci arrivò grazie alla loro mediazione.
Accadde così anche per i lirici greci levati dal piedistallo e ricondotti a più umana misura dal geometra, ermetico e autodidatta Quasimodo (prima edizione nel 1940 per Corrente, in seguito Mondadori), una boccata d’aria fresca contro il classicismo imbolsito e ridotto a retorica di cattivo gusto dei traduttori cari al regime, soprattutto i due Ettori, Bignone e Romagnoli. Scriveva Quasimodo, nella nota che congedava la sua silloge: «Ho condotto queste traduzioni fino a un risultato che non credo arido per un accostamento più verosimile a quei poeti dell’antichità che, affidati alle avventure di versificazione anche di grecisti insigni, sono arrivati a noi con esattezza di numeri, ma privati del canto».
Vero, la traduzione modernista di Quasimodo avrebbe aperto la strada a un incontro fecondo tra esigenze della filologia e felicità della resa artistica (penso, per altri testi greci e latini, alle prove posteriori di Pasolini e Sanguineti, in tempi più recenti alle rese felicissime di Alessandro Fo).
Da ragazzo, trovavo nelle antologie scolastiche il suo Alceo:
O conchiglia marina, figlia
della pietra e del mare biancheggiante,
tu meravigli la mente dei fanciulli.
E trovavo l’Alcmane che il soldatino Giuseppe Cederna legge a sera, nella sua branda, in Mediterraneo di Gabriele Salvatores:
Dormono le cime dei monti
e le vallate intorno,
i declivi e i burroni;
dormono i rettili, quanti nella specie
la nera terra alleva,
le fiere di selva, le varie forme di api,
i mostri nel fondo cupo del mare;
dormono le generazioni
degli uccelli dalle lunghe ali.
Impossibile che trovassi i fremiti amorosi di Saffo:
Tramontata è la luna
e le Pleiadi a mezzo della notte;
anche giovinezza già dilegua,
e ora nel mio letto resto sola.
Tuttavia, quel pionierismo fecondo fu anche, in qualche modo, operazione soggettiva e lievemente arbitraria: esaltazione del frammento, riduzione dei lirici quasi ad antenati dell’ermetismo. La scelta operata da Quasimodo era piccola cosa rispetto al corpus lirico che, tramontata l’aristocrazia guerriera dei poemi omerici, metteva in primo piano la quotidianità esaltando l’io poetico. E includeva poeti minori come Erinna, Praxilla e altri. (I filologi sottolineano anche le lacune filologiche di Quasimodo, ci credo sulla parola ma di più non saprei dire).
Per avere edizioni filologiche e, assieme, non private del canto, oggi sarà opportuno rivolgersi alle versioni di Filippo Maria Pontani per Einaudi e soprattutto a quelle recenti (2021) e più che esaustive di Ezio Savino, curatore Daniele Ventre, per Crocetti. Ne riparleremo.
Marzio G. Mian, Volga blues, Gramma Feltrinelli, 2024
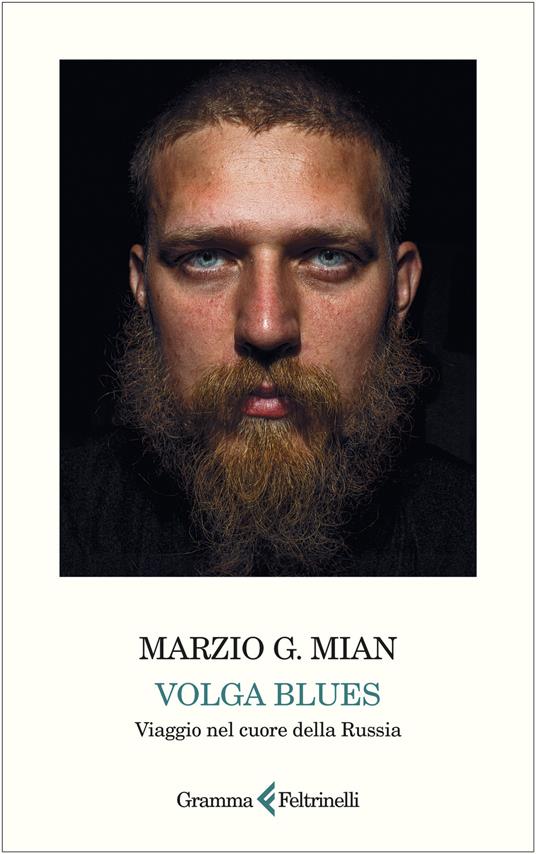
Che cosa pensano i russi? I latrati di Lavrov e Medvedev, le minacce dello zar Putin li conosciamo. Ma i russi? È andato a scoprirlo, con un avventuroso viaggio di un mese senza visto giornalistico dalla sorgente alle foci del Volga, e lo racconta in un reportage potente che è insieme meticolosa verifica sul campo e ricapitolazione della storia russa puntuale e sottile, Marzio Mian. Il Volga, la madre di tutti i fiumi, l’autobiografia della nazione. Dalle prime rotte commerciali tracciate dai vareghi alle cruentissime battaglie che inchiodarono i nazisti.
A Samara, mentre fa la fila per entrare nell’Oggetto Numero 1, il bunker approntato per Stalin nel corso della seconda guerra mondiale, in grado di ospitare 600 persone, Mian si sente dire da Andrej, ingegnere elettronico moscovita di 24 anni arrivato in visita assieme a tre amici, che Stalin «è stato un vincente, per noi giovani è il numero uno». Stalin superstar, riabilitato da Putin e dal clero ortodosso, con il suo faccione baffuto sulle t-shirt di tanti adolescenti.
Andrej prosegue: «Dobbiamo combattere il male come durante la Grande guerra patriottica. Putin dovrebbe seguire il suo esempio, la sua concretezza. Guarda come aveva creato questa cosa in poche settimane, pazzesco. Gli aspetti negativi? Boh, si dicono tante cose. Contano i risultati, no? Secondo me, ci sono stati più morti negli anni novanta per le guerre criminali e l’alcol. Quella è stata la nostra prima esperienza di democrazia, il periodo peggiore della nostra Storia». Andrej non è comunista. «Sono russo. Non siamo fatti per le vie di mezzo. Essere un vero russo oggi è una forma di estremismo».
La Russia in guerra con l’Ucraina, nelle decine di voci che Mian interroga e ascolta, è o sembra compatta. Più che contro l’Ucraina, una sorta di parente traviato, contro l’Occidente sentina di ogni male. Contro la “contaminazione”. Non a caso, gli anni di Eltsin, delle scorrerie americane e dell’iperliberismo, dell’arraffa arraffa e della fame, sono raccontati da tutti come un incubo. La “smuta”: i torbidi, il caos, terrore ricorrente e radicato nell’animo russo. Assieme al rancore per l’impero perduto, per l’orgoglio calpestato. E alla gratitudine per Putin, che la bandiera dell’orgoglio ha tornato a fare sventolare. Sbaglierebbe, questo reportage lo testimonia in maniera nitida, chi sopravvalutasse il dissenso: poche, timide voci e nessuna, neanche i pacifisti rifugiati in un’isoletta sul Volga a suonare reggae russo, che guardino a ovest. Le critiche, semmai, vengono da destra, dai falchi della grande Russia euroasiatica e dall’integralismo ortodosso: che senso ha un mondo senza la Russia? Se bisogna immolarsi, muoia Sansone con tutti i filistei. Anche a costo di usare l’atomica. Per tutti costoro, Putin è semmai troppo morbido.
La Russia oggi riscopre i valori eterni della “terza Roma”, frulla insieme l’ortodossia degli onnipotenti pope (la religione, racconta Mian, è la nuova ideologia che fa da collante al potere russo: anche se le chiese restano vuote e il paese fa registrare il record mondiale dei divorzi), rigurgiti fascisti, culto di Stalin e dei kolchoz (ma Lenin è quasi dimenticato), un supernazionalismo che è insieme aggressivo e isolazionista, venato di eccezionalismo (la missione storica per salvare il mondo), ma pronto a rinchiudersi a riccio. Pronto a scagliare in faccia al mondo la sua “passionarnost”: coniato da Lev Gumilev figlio di Anna Achmatova, il termine designa “l’energia interiore di una nazione capace di sacrificarsi per un bene comune superiore”.
Questa Russia in guerra non se la passa peggio di prima: l’export con l’Unione europea è calato del 58% , ma in compenso quello con l’Asia è cresciuto del 78% (ad Astrakan, Mian documenta i rapporti sempre più stretti con l’Iran, cementati in questi giorni dai colloqui fra Putin e Pezeshkian), il benessere è abbastanza diffuso, il Pil in crescita e la disoccupazione contenuta. Anche se le fragilità e le angosce affiorano: si beve più di prima, e già si beveva troppo. E il richiamo alle armi terrorizza i più giovani. Ma la guerra è uno sporco mestiere per poveri delle province e una paradossale forma di welfare: un morto in battaglia vale 80mila dollari per le famiglie, un ferito 30mila dollari.
La Russia che emerge dalla ricognizione di Mian è lontana da noi come, nel corso della sua storia, non è mai stata. E anche se continuiamo a distinguere fra gli aggressori e gli aggrediti – per non essere fraintesi: fra Mosca e Kiev – non possiamo fare a meno di chiederci se l’Occidente, nell’avere accerchiato e umiliato la Russia, non abbia la sua parte di colpa.
Stefano Nazzi, Canti di guerra, Mondadori, 2024

«Quel giorno anche l’asfalto era incandescente, il sangue sembrava quasi bollire mentre si allargava nel cortile del carcere di massima sicurezza di via Badu ‘e Carros, a Nuoro, in Sardegna. Erano le 13.50 del 17 agosto 1981. Le urla dei carcerati intorno erano alte, eccitate, quattro persone venivano portate via a fatica, il direttore del carcere era corso nel cortile, e così anche il medico. Erano entrambi chinati su un corpo. L’uomo a terra aveva il ventre squarciato, ovunque ferite di coltello. Indossava pantaloni corti e una canottiera traforata, gli zoccoli, che aveva quella mattina come sempre, erano distanti, a qualche metro, dove era iniziata l’aggressione. Dal collo pendeva una svastica in oro, la portava per scandalizzare, per far vedere che lui poteva tutto, si poteva permettere ogni cosa».
Il morto, lo sbudellato, è Francis Turatello, “Faccia d’Angelo”. Lo ha fatto eliminare, dicono, il suo vice Angelo Epaminonda “il Tebano” per subentrargli, ma si fanno anche i nomi di Raffaele Cutolo, Luciano Liggio, Renato Vallanzasca, si parla addirittura di uno scambio di favori con le Brigate Rosse, perché Turatello vessava i terroristi in carcere.
Falso nome francese (era in realtà di Asiago), Turatello per gran parte degli anni ‘70 è stato il “re di Milano”: bische clandestine, prostituzione, sequestri e rapine con i marsigliesi di Albert Bergamelli. Si è scontrato, per consolidare il suo potere, con l’anarcoide e guascone Renato Vallanzasca: si sono sparati, hanno cercato di eliminarsi in agguati sanguinose, poi in carcere hanno fatto pace e a Rebibbia Turatello è stato testimone di nozze del bel René. Angelo Epaminonda, un catanese sanguinario che ha preso il posto di “Faccia d’Angelo” ai vertici della mala milanese consolidando lo scettro a suon di stragi, negli anni ‘80 si pentirà confessando diciassette omicidi e aiutando a ricostruirne quarantaquattro. Morirà nel suo letto, con una nuova identità, nel 2016.
Rievoca quegli anni turbolenti e quel trio di criminali, in maniera vivace ed esatta, Stefano Nazzi, autore con Indagini e Altre indagini per Il Post dei migliori podcast dedicati alla cronaca nera.
Marino Niola, L’Italia dei miracoli, Cortina, 2024

«Certo è che le divinità pagane durano molto più a lungo di quanto noi sospettiamo, qualche volta sono apparse nella loro intrinseca nudità, qualche volta negli abiti riadattati della Madonna e dei Santi. Esisteranno ancora ai nostri giorni?» si domandava Vernon Lee, scrittrice inglese trapiantata in Toscana con largo anticipo su Muriel Spark.
Esistono, esistono. In questa Italia che per Henry James viveva «una interminabile luna di miele paganeggiante» (L’ultimo dei Valeri), il cristianesimo ufficiale è infiltrato non da oggi da riti e divinità antichissime, perché se non li puoi cancellare fatteli amici e inglobali. L’antropologo – e vivacissimo scrittore – Marino Niola racconta il san Paolo apostolo che, in Salento, diventa protettore e guaritore delle tarantate «per effetto di quella sorta di effetto cumulativo della storia, che non scarta ma ricicla. Non cancella ma riscrive. Non scomunica ma comunica. Non elimina ma contamina».
In Salento è la tarantola, a Cocullo in Abruzzo ci sono i serpenti. Innocui, ma stanati alla fine del letargo e allevati amorevolmente nelle case dei fedeli per avvolgere la statua di san Domenico Abate nella processione del 1° maggio. Dietro questa celebrazione stanno le antiche dee serpentarie dei marsi e dei piceni.
A volte il vecchio e il nuovo si combattono: ad Amatrice e dintorni, zona sismica, al monte della Sibilla si contrappone lo scoglio di santa Rita, patrona delle cause impossibili, anche se il protettore che dovrebbe scongiurare i terremoti è sant’Emidio.
Saltando i casi più celebri (Padre Pio taumaturgo populista; santa Rosalia e sant’Agata; la lingua di sant’Antonio a Padova; la manna miracolosa che stilla dalle reliquie di san Nicola; il monaciello spiritello domestico soccorrevole o dispettoso; il sangue di san Gennaro che si scioglie: non troppo distante da lui, ma meno conosciuta, santa Patrizia si liquefà una volta alla settimana, a dimostrazione del fatto che le donne devono fare due volte più fatica degli uomini per essere considerate brave la metà), c’è da ricordare la Madonna che piange lacrime di sangue a Sant’Anastasia; Santa Maria delle Cinque Piaghe che nei Quartieri Spagnoli di Napoli rende fertili le donne; e “mamma schiavona che tutto concede e tutto perdona” invocata dai femminielli e della comunità Lgbtq a Montevergine in Irpinia. Un matrimonio allietato da una sessualità soddisfacente garantivano invece un tempo i dioscuri cristiani Cosma e Damiano, ai quali le spose recavano in dono a Isernia ex voto falliformi in cera rossa, con la richiesta perentoria: “Così lo voglio”.
La storia per me più bella è quella delle pezzentelle o capuzzelle, sempre a Napoli. Le testoline, quelle dei morti di peste che nel cimitero delle Fontanelle sotto la collina di Capodimonte o nella cripta di san Pietro ad Aram sono raccolte in immensi ossari. Alcune di loro vengono adottate dai fedeli, portate in casa, venerate in altarini domestici e ripulite e strofinate con alcool e ovatta. In cambio devono concedere miracoli: una guarigione, un matrimonio, un posto di lavoro, almeno qualche numero buono per il lotto.
Chi fa miracoli diventa capa gloriosa, riportata nella cripta e omaggiata da tutti dietro una teca di vetro. Chi viene sbeffeggiato dai fedeli si vendica: è il caso del Capitano, il cui cranio viene preso a calci da un temerario che, per sfotterlo, ha l’ardire di invitarlo a cena. Il Capitano si presenta, e per l’incosciente anfitrione si spalancano le porte dell’inferno. Vuoi vedere che la storia di Don Giovanni è nata qui? In effetti L’ingannatore di Siviglia di Tirso de Molina (1616) in cui compare per la prima volta il seduttore che Mozart renderà immortale, prende le mosse da Napoli. Ci ritorneremo.
Giacomo Papi, La piscina, Feltrinelli, 2024
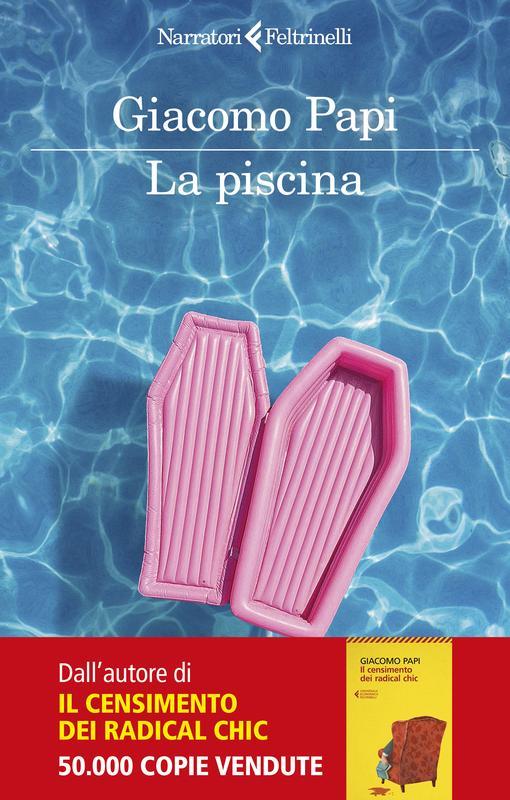
Metti Agatha Christie in Umbria. Metti la lotta di classe nel castello di Abborracciano. Dove l’artista miliardario Klaus Signori, maestro della disinstallazione – per decenni ha fatto saltare in aria o ridotto in detriti monumenti inutili o mostri edilizi, anche un chilometro di muro di Berlino, per rivendere a caro prezzo i frammenti – sta per festeggiare gli ottant’anni con una sontuosa festa.
Sono stati convocati i nipoti scrocconi e inetti che prima o poi erediteranno i suoi beni: la maestra di yoga con la figlia adolescente che flirta con la rivolta e sogna SciencesPo, il viticultore sull’orlo del fallimento da quando ha irritato Armani. E l’elegante corte dei miracoli che lo ha circondato nel corso degli anni: l’avvocato, la gallerista svizzera, il “droghiere” che gli offre paradisi artificiali. Dovrebbe presentarsi ai cancelli anche una troupe lituana, convocata per girare un documentario sulla sua vita.
Schierata ad attendere gli ospiti una variopinta tribù di servi: l’autista serbo, la cuoca peruviana, il maestro d’armi africano che ha accompagnato Signori nelle battute di caccia, la social media manager gallese, gli inservienti filippini, le due attempate cameriere italiane che si fingono sorelle.
Ma il festeggiato non appare: lo troveranno surgelato in cantina, dentro uno dei freezer che ospitano la cacciagione.
Chi è stato? Gli ospiti accusano i domestici che insorgono e, sequestrata la “bella gente”, diventano padroni per qualche giorno, facendosi servire. Intanto sui telefonini arrivano criptici messaggi del morto: che li sprona a una caccia al tesoro, cinque milioni di euro nascosti in un trolley tutto d’oro. Con una doppia soluzione a sorpresa che è obbligatorio non rivelare, un romanzo aguzzo che “disinstalla” i congegni del giallo classico confermando il grande talento satirico di Giacomo Papi, sulla scia delle precedenti prove (Il censimento dei radical chic, Happydemia).
Qui, come di recente altrove (penso all’ottimo e altrettanto aguzzo film britannico Saltburn, con un giovane finto povero e in realtà ragno predatore che si insinua in una famiglia nobiliare, la manipola e la elimina prendendone il posto) è di scena il conflitto fra padroni e servi, fra chi ha e chi non ha. Con la conclusione amara che neanche la lotta di classe è più possibile, al massimo potrà esserci una rivolta che sa di Carnevale, di mondo alla rovescia per qualche giorno, perché oggi i poveri sono ricchi senza soldi e i ricchi sono poveri con i soldi.
Ricardo Piglia, Bersaglio notturno, traduzione di Pino Cacucci, Sur, 2024
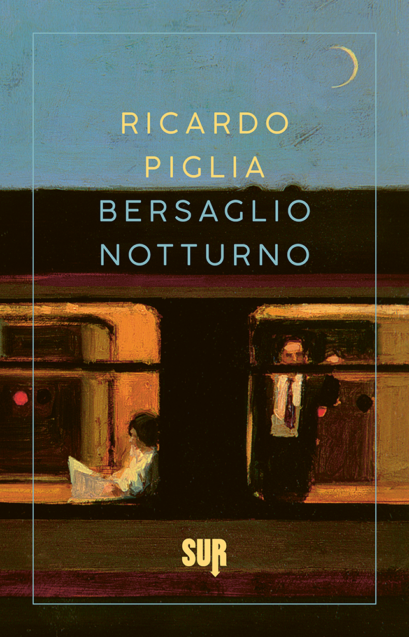
«Tony Duràn era un avventuriero e un giocatore di professione e scorse l’opportunità di vincere la migliore delle scommesse quando si imbatté nelle sorelle Belladona. Fu un ménage à trois che scandalizzò la cittadina e accentrò l’interesse generale per diversi mesi. Si faceva sempre vedere con una di loro nel ristorante dell’Hotel Plaza ma nessuno poteva sapere quale fosse delle due perché le gemelle erano talmente identiche da avere persino la stessa calligrafia».
È sbarcato in un paesino della “pampa umida” abitato da discendenti di piemontesi, dove la noia favorisce il delirio, il portoricano Tony Duràn. Bello, dandy, mulatto, bravo ballerino e sciupafemmine. Le sorelle Belladona sono soltanto la copertura, in realtà Tony ha affari misteriosi da sbrigare e poco tempo dopo l’arrivo viene trovato morto nella sua stanza d’albergo. Del delitto è accusato un nikkei, cioè un nippo-argentino, il portiere dell’albergo Yoshio.
Ma il commissario Croce, poliziotto della vecchia guardia inviso al procuratore Cueto, che lo farà pensionare e, in seguito a una vicenda di lettere anonime, internare in manicomio, non è convinto. Trova il vero assassino (un fantino che si è fatto passare per il giapponese, suicidandosi dopo avere ucciso Tony) ma non riuscirà a concludere l’inchiesta.
Al centro della quale c’è la famiglia vagamente chandleriana dei Belladona (sia le gemelle Ada e Sofia, sia il loro padre, l’ingegnere Cayetano Belladona che ha difficoltà a camminare e non esce di casa, ricordano il generale Sternwood e le sue figlie viziose Vivian e Carmen del Grande sonno), divisa da burrasche sentimentali e rancori legati al denaro.
Tra i componenti del clan, menzione d’onore per Lucio Belladona, fratello delle due gemelle, che ha impiantato una fabbrica automobilistica all’avanguardia, una cattedrale futuristica inquietante nel mare d’erba della pampa, è stato costretto a cessare l’attività in seguito a un “golpe” familiare e vive asserragliato in fabbrica lottando per non farla chiudere: una determinazione eroica e un po’ folle, quasi da Fitzcarraldo, che si accompagna in lui al febbrile lavorio per trascrivere e decifrare tutti i suoi sogni.
Finirà male, molto male e né il commissario Croce, né il giornalista Renzi che viene da Buenos Aires, potranno dire che giustizia è stata fatta. Falso thriller, meglio ancora romanzo visionario dietro l’apparenza del thriller, Bersaglio notturno intreccia soldi, veleni familiari e potere (siamo nell’anno che precede il ritorno di Perόn) in una pampa lontanissima dall’oleografia, dove i gauchos non hanno più i denti per mangiare l’asado e sono diventati vegeteriani e, come in Dürrenmatt, l’ordine non viene ristabilito perché l’ordine trionfa soltanto nei polizieschi.
Ricardo Piglia (Buenos Aires, 1941-2017) ha insegnato letteratura sudamericana all’università di Princeton. In Italia ha già pubblicato Respirazione artificiale, Soldi bruciati e L’ultimo lettore. Ha una scrittura fluida che si impregna dei luoghi che descrive, atmosfere e persone. Con repentine impennate metafisiche (le pagine sulla fabbrica vuota e su Lucio Belladona che graffita i suoi sogni sulle pareti sono da antologia) e un curioso vezzo stilistico: affidare rivoli di narrazione laterale, particolari dimenticati, citazioni, falsi articoli, dettagli storici, a note a pie’ di pagina. Niente di pedante o di “scientifico”: piuttosto, come quando facevamo i compiti in classe con i fogli protocollo, aggiunte laterali che avevamo dimenticato nella prima stesura della “brutta”.
Tra le note, una mi interessa in particolare: per bocca del giornalista Renzi, Piglia racconta che il personaggio di Bartleby deriva dallo scrivano Nemo di Casa desolata di Dickens. E offre prove convincenti. Bella traduzione di Pino Cacucci.
Il romanzo, ora opportunamente riedito da Sur, venne pubblicato nel 2011 con la stessa traduzione da Feltrinelli.
Intervistato allora da Sebastiano Triulzi per Repubblica, Ricardo Piglia raccontava: «La mia famiglia proviene da Pinerolo, provincia di Torino. Mio nonno ha combattuto nella prima guerra mondiale. Arrivò a Buenos Aires nel 1922 quando mio padre aveva sette anni. Faceva il capostazione ad un crocevia di binari per le ferrovie inglesi. Praticamente fondò la città. Mi sono ispirato a lui per il personaggio di Bruno Belladona e a mio cugino per quello di Luca. Era un inventore, un uomo straordinario. Quando ero bambino lo vedevo come un eroe. Creava giocattoli incredibili: uccelli meccanici, radio per ascoltare le conversazioni del vicino, apparecchi per conquistare le ragazze (che non funzionavano mai). Poi ha messo in piedi una fabbrica, finì per chiudervisi dentro fino a morirne. Produceva oggetti per i quali la realtà non era preparata. La storia dell’immigrazione italiana – come quella dei nuovi migranti – è una delle più grandi leggende epiche, soprattutto in questi tempi dove l’esperienza viene sommersa dall’informazione. Le famiglie italiane sono delle grandi macchine narrative: hanno la loro lingua, i loro cantastorie, i loro eroi, le loro tragedie quotidiane. Mia madre sapeva raccontare in modo meraviglioso, fondamentalmente perché giudicava i propri vicini. Se nella famiglia ci fosse stato un assassino seriale, avrebbe detto: “Bueno, quel ragazzo è sempre stato un poco nervoso…”».
Adalbert Stifter, Il vecchio scapolo, traduzione di Margherita Carbonaro, Carbonio, 2024
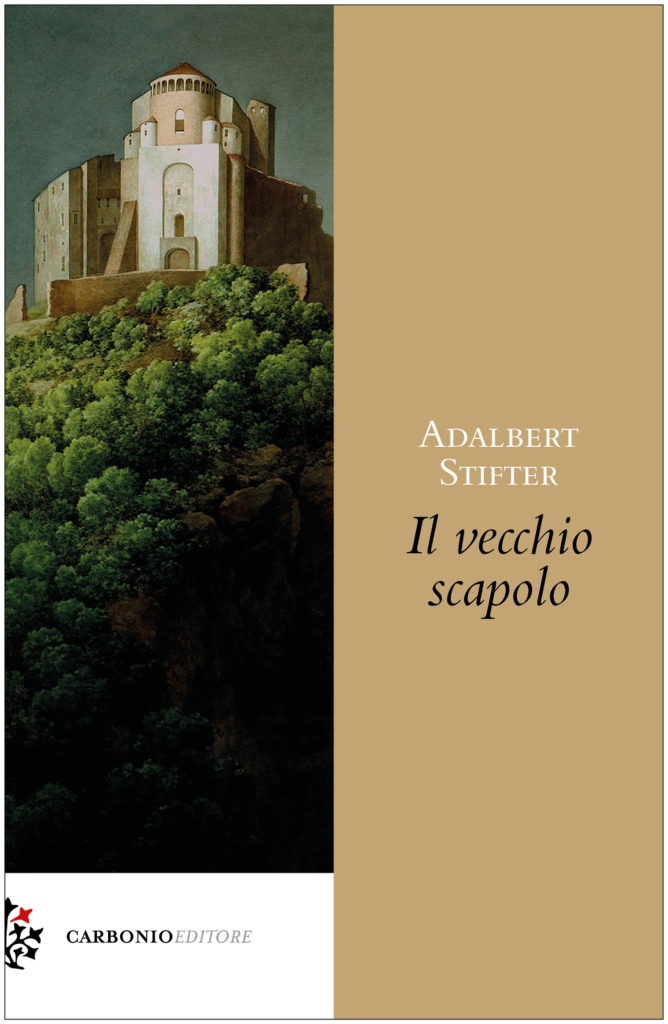
Un viaggio che è anche rito iniziatico, un incontro con l’orco che è messa alla prova, un tesoro del quale nessuno sospettava l’esistenza che viene profuso. È tutto questo e altro ancora – un inno vivido alla natura austriaca e alla sua montagna, un’elegia dei quieti affetti familiari, un’esortazione all’increase, un confronto tra la giovinezza fulgida e pronta a dubitare di sé e la vecchiaia che si ritrae e si rinserra – il racconto che Stifter dà alle stampe nel 1840, nella raccolta Studi.
Il giovane Victor ha perso padre e madre ed è stato cresciuto, con tenerezza e affetto, da una madre putativa vedova che fu amore giovanile del padre. Assieme a lui è cresciuta, come una sorella, la giovane Hanna che della donna è figlia e che Victor sente di amare. Ma è arrivato il momento di separarsi: Victor dovrà andare in un’altra città per prendervi servizio e trovare il suo posto nel mondo. Prima, dovrà adempiere a un ultimo obbligo. Recarsi in visita da un vecchio zio, fratello del padre morto, che lo vuole conoscere.
Si avventura a piedi per aspre montagne – è una condizione posta dal vecchio – e dopo tre giorni lo raggiunge, stremato, il suo vecchio cane volpino. Mentre cammina, Victor sente di crescere: prima era della famiglia, ora è del mondo. Il potere del girovagare, tema caro al romanticismo tedesco da Jean-Paul a Schelle.
Raggiunge, traghettato da un barcaiolo e da sua figlia, la casa dell’anziano parente: una fortezza in un’isola lacustre, un ex monastero che mi fa venire in mente la posteriore Isola dei morti di Arnold Bocklin. Dove lo zio vive come recluso assieme a tre anziani domestici.
Invitato ad annegare il suo cane se vuole entrare (Victor rifiuta e si accinge a passare una notte all’addiaccio, verrà dissuaso da uno dei domestici: è una delle prove a cui è sottoposto, capiremo), il giovane trascorrerà settimane di semiprigionia nell’isola. Di giorno in giorno sempre più libero di vagare ed esplorare, osservato senza che lui se ne accorga con sguardo sempre più mite e benevolo dall’anziano despota, ma senza che i due quasi scambino parola. Curiosa figura quella del vecchio misantropo, come altre ne incontreremo nell’800, penso alla Miss Havisham del dickensiano Grandi speranze. E strana casa la sua, una polverosa e quasi sepolcrale dimora di Dracula senza vampiri.
Il giorno prima della partenza, l’anziano zio finalmente gli parla. Ha amato la donna che lo ha cresciuto, ma lei gli ha preferito il fratello. E quando il fratello è morto sommerso dai debiti, senza dire niente a nessuno, ha riscattato dai creditori la sua proprietà ipotecata e l’ha fatta fruttare, ora quei beni sono a disposizione del giovane Victor. Che deve approfittarne per conoscere il mondo e, tornato a casa, sposarsi per non essere un albero infruttifero come è stato lui. Victor, che all’inizio rifiuta l’eredità per ritegno e bacia commosso la mano del benefattore, alla fine gli obbedisce e chiede la mano di Hanna. Una fiaba gentile e delicata dalla buccia perturbante. Bella e scorrevole la traduzione di Margherita Carbonaro.
Adalbert Stifter (1805-1868), autore anche di quel capolavoro che è Cristallo di rocca, fu boemo di lingua tedesca. Figlio di un tessitore di lino, visse a Vienna, dove fu precettore della nobiltà austriaca (anche di un figlio di Metternich), e a Linz dove venne nominato ispettore scolastico. Liberale deluso (appoggiò la rivoluzione del 1848 per ritrarsene spaventato dalle sue violenze), fu buon pittore, novellatore assai apprezzato da Nietzsche, educatore entusiasta quanto frustrato dalla burocrazia imperialregia. Si tolse la vita con una rasoiata alla gola, stremato da una lunga malattia.
Raffaele Oriani, Gaza, la scorta mediatica, People, 2024

«Non sono mai stato una testa calda, e se non scrivo più per il giornale che amo non è perché ho smesso di condividere le opinioni del mio vicino di pagina (…) Il 7 ottobre in Israele c’è stato un massacro, e dall’8 ottobre a Gaza è in corso una carneficina, uno sterminio: insomma, un genocidio. Mi sono chiesto se Il Venerdì di Repubblica, il gruppo la Repubblica, il lavoro che stavo facendo, fossero il posto giusto dove trovarsi quando tutto crolla. O almeno un posto non troppo sbagliato. Non si tratta di essere o non essere d’accordo con l’approccio geopolitico del giornale. Quando succede una cosa così enorme come un genocidio si tratta prima di tutto di non averci nulla a che fare, di essere proprio sicuri di non averci nulla a che fare. Molto semplicemente, a Repubblica questa certezza non l’avevo. Tutt’altro. Me ne sono andato per non sentirmi parte della scorta mediatica che in Italia, in Europa e in tutto l’Occidente ha accompagnato, accompagna e probabilmente accompagnerà ancora lo sterminio dei palestinesi di Gaza da parte dell’esercito israeliano».
Un’opzione dura, un taglio netto. Conosco e stimo Raffaele Oriani da oltre vent’anni, per un lungo periodo siamo stati colleghi a Io donna. Se una testimonianza personale può servire a qualcosa, confermo che non è una testa calda e che è uno dei migliori giornalisti-narratori che io abbia conosciuto. La scelta di dimettersi da Repubblica è un atto etico, una scelta che probabilmente io, al suo posto, non avrei avuto il coraggio di fare. Non è l’odio per Israele, non è la giustificazione di Hamas. In qualche modo ha a che fare con l’esigenza di chiarezza totale che spingeva Hannah Arendt a scrivere: «Quando scegliamo il male minore, abbiamo comunque scelto il male».
Questo suo lucido, pacato e implacabile pamphlet racconta e documenta tutte le omissioni, le sviste, le giustificazioni, il voltarsi dall’altra parte di molta stampa italiana (e non solo), dopo un anno di massacri. Assolutamente da leggere.