Potere, solitudine e morte: a 20 anni di tutto ciò si ha una rappresentazione sommaria. Molti anni dopo, e molta America latina attraversata e raccontata, riprendere in mano l’Autunno del Patriarca di Garcia Marquez risveglia prepotente un miscuglio di memoria storica e di esperienza individuale
Il rapporto con un romanzo cambia a seconda di come evolve la relazione de lettore con gli elementi che lo fondano, che ne L’autunno del Patriarca di Gabriel García Márquez sono la morte e il potere, la solitudine del potere. Quando ho letto quel libro per la prima volta avevo vent’anni e una idea sommaria di entrambe le cose, e del romanzo mi aveva colpito la perfezione nell’architettura, la costruzione del personaggio mitologico del dittatore latinoamericano con un linguaggio nuovo e potentissimo che ricordava il monologo interiore non fosse che a raccontare il despota sono molte voci che si accavallano e si alternano senza che nessuna di loro sia mai identificata, e senza un punto o virgola che definisca il passaggio dall’una all’altra: così che il quadro che se ne ricava è un grande affresco in cui il dettaglio – o meglio il fatto che un dettaglio venga capito o meno – non è fondamentale se non in funzione del risultato finale.
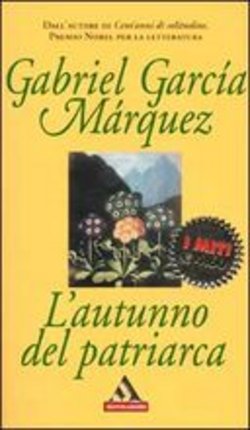
Mi aveva conquistato il fatto che quel linguaggio, così complesso e originale e plastico coincidesse perfettamente con il contenuto, che la forma non si sovrapponesse alla sostanza. E che il tiranno-patriarca della cui vecchiaia e decadenza tratta il libro, un archetipo di tiranno le cui caratteristiche sono cosi esasperate da superare di gran lunga la realtà, così paradossali da rischiare il macchiettistico se a descriverlo fosse stato uno scrittore meno attento, meno disciplinato, non avrebbe potuto essere spiegato se non con quel linguaggio, con quelle iperboli e anacoluti e barocchismi, con quegli eccessi che ne trasfigurano i tratti: l’età incalcolabile che lo trasforma nell’ essere “più vecchio d tutti gli uomini vecchi e tutti gli animali vecchi della terra e dell’acqua”, la terza dentizione a più di cento anni e il ricordo delle tre caravelle che sbarcavano sul Paese caraibico che lui governa da quando le potenze straniere con cui si è indebitato fino al collo lo hanno insediato al potere.
Soltanto quando ho letto il romanzo per la seconda volta ho capito che il grado di realtà da cui partiva l’autore era molto maggiore di quanto mi fosse sembrato nella prima lettura, e che non c’era nulla in quel despota di completamente inventato ma tutto aveva un fondamento storico, una base reale poi dilatata sensorialmente. Mi occupavo ormai di America Latina da molti anni e avevo una nozione troppo chiara dei dittatori latinoamericani per non cogliere la verosimiglianza nel protagonista e in molti spunti della storia: la svendita del mare agli americani per ripagare il debito, la convinzione della propria onnipotenza che porta a eccessi inverosimili, esasperati nella fiction. La debordante untuosità dei cortigiani è tale che quando il dittatore chiede: “Che ora è?” gli rispondono: “Quella che lei ordina, Eccellenza”. Sono le stesse persone che lo tradiranno, cercando di ordire trame e golpe, in prima linea il suo compare di tutta una vita, il fidato ministro delle Finanze Rodrígo de Aguilar di cui scopre il tradimento e per vendicarsi lo fa ammazzare e poi servire a tavola steso su un letto di cavolfiori e alloro con l’uniforme intatta, macerato in spezie, per poi invitare i commensali pietrificati dall’orrore che presenziano “alla squisita cerimonia dello squartamento e della spartizione” a servirsi di una razione uguale di ministro con ripieno di pinoli e di erbe aromatiche: “Buon appetito, signori”.
Al giornalista statunitense Peter Stone che lo aveva intervistato nel 1981, un anno prima che prendesse il Nobel e un anno dopo la pubblicazione dell’Autunno del patriarca, García Márquez aveva raccontato che quel romanzo era completamente storico. E con questo intendeva, immagino, che a essere storico erano sia molti fatti, sia l’essenza di quel dittatore che aveva distillato dalle letture delle storie di molti dittatori per oltre dieci anni, intervistando centinaia di persone che avevano vissuto sotto una dittatura e andando a vivere lui stesso a Barcellona durante il franchismo. Non sono un critico letterario né uno studioso di letteratura e la mia non è un’analisi ma un’impressione da lettrice, sia pure allenata a leggere scrittori latinoamericani, a partire da quelli che a volte spregiativamente vengono incasellati nel realismo magico. E proprio una certa stanchezza verso gli eccessi e gli epigoni di quest’ultimo genere mi avevano portato a rileggere con una certa diffidenza L’autunno del patriarca e invece, così come dopo la prima lettura sono rimasta stupita e in silenzio mentre giravano dentro di me le immagini del libro e si mischiavano con sensazioni e sentimenti che nel frattempo si erano formati nel mio cosiddetto mondo interiore: un miscuglio di memoria storica e di esperienze individuali accumulate negli anni. E mi è sembrata ancora più potente e immaginifica della prima volta, grandiosa e centrata la descrizione del palazzo presidenziale che a mano a mano che il patriarca invecchia diventa fatiscente e vuoto tanto che ad abitarlo sono soltanto qualche lebbroso dei molti che un tempo si affollavano nelle sale e lo aspettavano tra i roseti per chiedergli il miracolo, e qualche vacca che sale le scale fino ad affacciarsi alla finestra del balcone in cui il tiranno da molti anni (o decenni o secoli?) non si affaccia più, nessuno lo ha più visto da un tempo infinito e credono alla sua esistenza in vita per una sorta di abitudine, perché conoscono solo lui e sono stati governati solo da lui non si immaginano con nessun altro.
Non c’è immagine che mi sembri una trovata, in questo romanzo che è un succedersi di immagini e non c’è situazione che mi sembri forzatamente paradossale in questa storia che si conclude con la morte del tiranno, morte solitaria e triste senza nemmeno un cane a fargli compagnia perché i pochi esseri che ha amato davvero sono morti: prima di tutto la madre ex puttana povera che lui ha santificato dopo che il nunzio inviato dal Vaticano aveva stabilito che i presunti miracoli della donna erano truffe e lui, il patriarca, aveva aizzato il popolo contro monasteri e chiese e bandito preti e monache mettendoli nudi su una barca. Tra le novizie espulse ce n’è una tozza e goffa di cui il dittatore si innamora per pura chimica e che gli darà un figlio, ma che verrà sbranata da una muta di cani insieme all’erede per ordine di generali complottisti. Ogni capitolo si apre con il ritrovamento del cadavere del patriarca ma ripercorre in flash back stralci di storia del dittatore fin dalle origini di bambino povero e alle avventure di “marito urgente” con le migliaia di amanti che partoriscono soltanto settimini e che lui sistema in una sorta di harem triste di rapporti arruffati e rapidi in cui le stesse amanti lo snobbano e trattano da ragazzino rimbambito. Ed è così che nelle pieghe di personaggio spaventoso, senza pietà né amore emerge ogni tanto qualche scampolo di compassione, o qualche elemento che spinge il lettore e compatirlo, per poi riprendersi quando quello scampolo si dilegua e lui torna a essere il malvagio miserabile che è sempre stato. “Una persona molto potente, un dittatore, è circondato da interessi e da genti il cui interesse è isolarlo dalla realtà: ogni cosa sembra collaborare al suo isolamento”, aveva detto. Alla fine questo romanzo può essere letto anche come un libro sulla solitudine, non necessariamente dovuta al potere ma a qualunque evento isoli dalla realtà, o anche a nessuno evento.
Immagine di copertina di Soledad Amarilla / Ministerio de Cultura de la Nación