Il conflitto generazionale? Si combatte in età adulta: tra genitrici bisavole e figlie che si inventano una comune di cura pur di far fronte alla fatica dell’accudimento e alla paura della solitudine. Lo racconta Fiammetta Palpati nel suo romanzo d’esordio: opera buffa condotta con lingua spumeggiante (e tutta la tragicità del caso). Le grottesche irridono, si sa, ma anche inquietano.
Rompe il tabù del silenzio, dal canto suo, il mémoire di Alaine Polcz, che Anfora edizioni rende fruibile in italiano, con una nuova traduzione, a trent’anni dalla sua uscita in Ungheria. La guerra raccontata da una donna che l’ha attraversata, patita, subita – ma che non se n’è fatta schiacciare: un racconto limpido, durissimo, sulla violenza perpetrata sul corpo delle donne nella Transilvania contesa, persa, barattata, invasa. Il 1944, a ben guardare, non è mai trascorso.
Fiammetta Palpati, La casa delle orfane bianche (Laurana editore)
«Ma tu cosa vorresti da tua madre?».
Germana posa il bicchiere. Il palmo, il dorso – sulle labbra bagnate. Sulle guance. È accaldata.
«Essere sua figlia, per una volta. Prima che muoia».
Rimane assorta. Sorride.
«E tu, dalla tua?»
Lucia alla finestra, di spalle:
«Vorrei che fosse mia madre, per una volta. Prima che muoio».
Una vecchiaia grottesca, feroce, disperata, sospettosa.
Una adultità consumata, livida, ferita, deprivata: di vite costrette subito in fretta a crescere ruvide, estranee alla leggerezza, all’infanzia, alla gioventù.
Tra queste due direttrici si dipana il romanzo d’esordio di Fiammetta Palpati: ambientato in una casa di campagna, dove tre donne decidono di riunire le proprie magagne incarnate dalle rispettive, anziane madri, nell’intento di portarsi reciprocamente assistenza e sollievo.
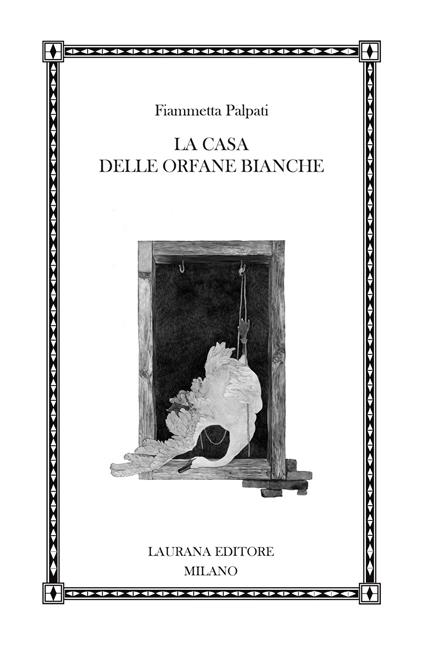
Ciò che accade è che, invece, prive di strumenti che non siano la buona volontà, tutte quante si ritrovano a fare i conti con l’idea del decadimento che su tutto impera (cadente è la casa, macilento il cane, finali le esistenze delle madri, terribile il catalogo olfattivo della corruzione); per di più, contemporaneamente, il reciproco confronto tra coppie figlie-madri e la vita gomito a gomito comportano lo sconquasso emotivo di apprendere in diverse forme l’evidenza di essere tutte state defraudate di una parte della propria vita: quella dell’affettività, della genitorialità accogliente e in grado di educare senza le distorsioni dell’aggressività.
Come fare per far digerire una pillola tanto amara? Fiammetta Palpati usa tutta la sua capacità affabulatoria per allestire una lingua e un ritmo che strizzano l’occhio all’opera buffa: e come in questo caso spesso accade, il brio dell’impianto scenico e la velocità con cui si susseguono colpi di teatro ed eventi, oltre a perimetrare gli spazi per gli a solo (e, di conseguenza, la melodia dell’interiorità e degli affetti inclini al pathos), non nascondono mai del tutto la natura oscura e inquieta – quando non inquietante – della vicenda.
Non c’è pietà per le tre donne mature, a un passo dallo sfiorire senza mai essere state in boccio, che tutto provano per trovare un rimedio: dallo scambiarsi le madri per trovare finalmente una corrispondenza fino al tentare di affrettarne la morte.
E pure quando la risoluzione non può che invocare l’intervento di un deus ex machina (in questo caso una dea ex machina) la china che ha preso la faccenda si rivela tale che nulla va come pronosticato. Quella che si presenta alla porta di casa come badante è in realtà una millantatrice, e il suo ingresso avoca a sé, ancora una volta, le poche forze residue delle figlie.
Le bende della suora mendace sanguinano, bisogna curarsi del suo corpo prima che appesti di ennesimo dolore gli ambienti: sarà mai che il suo travestimento balzano non riveli, sotto la finzione, una (autentica) reminiscenza del significato pasquale?
Il fatto è che, intorno all’accudimento della sconosciuta, avviene una potente rivelazione: il riconoscimento della propria orfanitudine, che coincide con il riconoscimento della propria sete di affetto: balorda, mai prosciugata nonostante le estenuanti incapacità familiari, insistente benché lacera. Nel dare non si può non ricevere, paiono dire, come parabola non priva di crudeltà, le azioni delle figlie e i silenzi delle madri. E questo, inevitabilmente, cambia.
Alaine Polcz, Donna sul fronte (Edizioni Anfora)
“Quando ero bambina giravamo il cannocchiale, e tutto diventava improvvisamente piccolo e lontano. Questo era quello che capitava in quel momento; il cannocchiale si era girato.
Realizzai che era perfettamente indifferente che i russi mi avessero trascinata via, che János non mi amasse, che mi avesse tradita, che avrei vissuto poco, che non avrei potuto diventare un medico. Perfettamente indifferente, le cose della vita non erano importanti. Questa non era indifferenza, non era apatia ma riconoscimento di un’altra dimensione temporale”.
Forse soltanto La Storia di Elsa Morante o Il dolore di Marguerite Duras (e più di recente Il pane perduto di Edith Bruck) sono riusciti a fare quello che compie la scrittura di questo libro potente, che la casa editrice Anfora – nel suo coraggioso progetto di militanza culturale per la diffusione della letteratura ungherese – ha da poco pubblicato in italiano con la traduzione di Antonio D’Auria.

Se esistono, dal mondo antico fino ad oggi, centinaia di titoli che raccontino la guerra (e lo fanno unanimemente da un lato all’altro dell’Europa, e di continente in continente), è pur vero che sono narrazioni che portano immancabilmente una firma maschile.
Così, maschile è l’apparato di riferimenti morali (per opposizione, o per adesione), che ha costruito nei secoli la nostra maniera di intendere e decifrare gli eventi bellici: il valore, la lealtà, il coraggio, il dolore, e persino il dovere, la necessità e la postura sono tutti, da sempre, declinati a partire da un punto di vista maschile storicizzato.
Cosa sia la guerra delle donne, cosa significhi per le donne, è una zona della letteratura nella quale solo poche, pochissime voci (e a fatica riconosciute) hanno deciso di spingersi.
La guerra opera per la soppressione dei corpi maschili e per l’attraversamento dei corpi femminili: una diversa forma di morte, che prevede un rilascio omeopatico del veleno della violenza.
Ciò che mostra il libro di Alaine Polcz, senza blandizie e senza sconti, è esattamente questo: il modo in cui si riesce a sopravvivere quando il nemico ti ha ucciso la vita.
Che questo accada all’interno di un sistema totalissimamente governato da forze maschili (il matrimonio, il grado permesso di consapevolezza sessuale, la libertà di accedere agli studi universitari, l’autonomia) è una sorta di conseguenza estrema, e drammaticamente coerente.
Appartenere, da donna, a una minoranza etnica di un territorio di confine, racconta il libro di Alaine Polcz, significa l’esposizione a uno stato di minorità al quadrato: poiché, nel 1944, ciò che accadde in Transilvania fu l’applicazione di ciò che sempre accade in ogni guerra, e che però è un aspetto che volentieri si omette. Lo stupro come arma supplementare, pervasiva, tombale.
È l’Armata Rossa a procedere in questo scampolo di mondo, e sono decine di migliaia, forse duecentomila (ma cifre meno caritatevoli, scrive in nota l’editrice, dicono quattrocentomila) i corpi violati.
Alaine Polcz è uno di questi corpi: un foglio che viene accartocciato nelle mani della Storia.
Eppure la sua femminilità resiste, e c’è qualcosa di intrepido, e di disarmante nella sua volontà di serbare memoria, e passarla – passare la rettitudine e la gentilezza, non permettere il naufragio del suo essere donna.
A trent’anni dalla sua prima uscita, un testo magistrale, di atroce attualità.