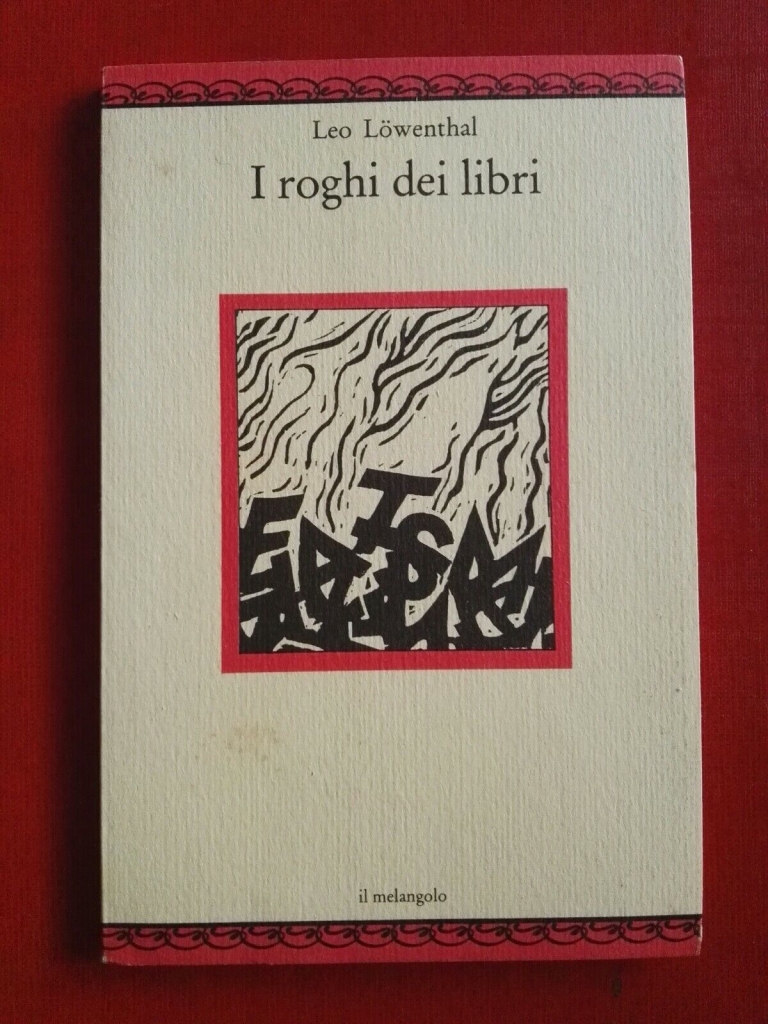Tra recuperi di alcuni titoli da non perdere e un appassionante excursus tra libri che parlano di libri – fatti, pensati, usati per altri scopi, bruciati – questo mese c’è molto da scoprire, senza perdere in leggerezza (culinaria, per esempio)
Regali di compleanno ricevuti, acquisti per lavoro, la lista degli ingressi del mese è questa. Poche novità fra le letture, ho campato di recuperi. Il perché è presto detto: sto sistemando la mia biblioteca, ed è un lavoro immane, che mi tiene occupato nei ritagli di tempo da qualche settimana. Mentre sistemo mi distraggo e recupero libri che erano stati accantonati. Che ci vorrà a mettere i libri negli scaffali?, direte voi. Intanto, i libri sono tra nove e diecimila, e poi ho deciso, con grande perplessità degli amici, di semplificare (nel frattempo mi sono piombati in casa, e c’era da fargli posto, una decina di scatoloni da un’altra casa). Quindi, tutta la letteratura è andata in ordine alfabetico da A di Abelardo alla Z di Zweig, come pure la saggistica. Fanno eccezione, radunate nella mia stanza-studio (la “tana”), le grandi opere (Storia d’Italia Einaudi e simili), le opere di consultazione (dizionari, repertori), i libri di cinema e di musica, gli illustrati e i particolarmente voluminosi. Ho registrato le obiezioni degli amici: no, noi mettiamo gli italiani con gli italiani, la poesia con la poesia, la psicologia con la psicologia… Anch’io facevo così, e finivo per non trovare più niente. Quindi semplifico. E allestisco un catalogo: alfabetico per autori, intanto, se avrò tempo anche per argomenti. Autore, titolo, eventuale traduttore o curatore, editore, anno di pubblicazione e, fondamentale, lo scaffale in cui è collocato il libro, così lo trovo. Per esempio, La camera segreta di Trezza Azzopardi è catalogato come S5/1, il che vuol dire che sta in sala al quinto scaffale, in seconda fila. Come ci sia arrivato (è un romanzo pubblicato da Rizzoli nel 2001) è un altro paio di maniche. L’ho senz’altro ricevuto in omaggio, l’avrò anche fatto segnalare a suo tempo, e alla fine l’ho tenuto. Ma non l’ho mai letto. Lei, Azzopardi, è una scrittrice inglese di origine maltese (finora di maltesi mi ero imbattuto soltanto in un malavitoso che faceva capolino in un bel thriller, Duffy, che Julian Barnes scrisse da giovane firmandolo con lo pseudonimo Dan Kavanagh). Più volte, nel corso degli anni, ho avuto la tentazione di eliminarla e poi mi sono detto: ma no, teniamolo, che ti hanno fatto di male i maltesi? Stavolta giuro che lo leggo, e il mese prossimo vi so dire. Intanto voi potreste scrivere come organizzate le vostre biblioteche, e che abitudini di lettura avete. Fate le orecchie ai libri? Io no, metto dei post-it. Li sottolineate? Io a volte sì, e a volte li annoto. Li prestate? Io sì, e pazienza se a volte non tornano indietro (da ragazzo avevo il vizio di non restituire, crescendo l’ho perso e sono diventato prussiano, ma ricordando il ragazzo un po’ cialtrone che ero, con quelli che si prendono i miei libri, mia figlia in primis, sono indulgente). Li tenete tutti, o alcuni (pochi, molti) li eliminate? Io faccio pulizie periodiche ma tengo sempre quelli che hanno una dedica, anche se il libro non mi convince: mi capita, nelle bancarelle, di trovare libri con dedica (a Roma anche uno che Giuseppe Dessì aveva destinato a chissà chi) dati in pasto a occhi estranei, e inorridisco. Quello di Dessì l’ho acquistato ed è in biblioteca (Michele Boschino, S17/1). Li comprate in libreria, o andate anche per bouquinistes? Vi è mai accaduto di rubarli? Insomma, scrivete.
Per questo mese, le recensioni che trovate sono dedicate a libri abbastanza recenti, che avevo lasciato indietro nelle letture. E a libri che parlano di libri. Il prossimo mese ci saranno più novità, prometto, ma senza rinunciare a recuperi e incursioni nel passato. Buona lettura.
LA SPESA (acquistati e/o ricevuti)
Jeanine Basinger/ Sam Wasson, Hollywood: the oral history, Faber & Faber, 2022
Italo Calvino, Romanzi e racconti vol. II, Mondadori, 2022
Vincenzo Corrado, Il cuoco galante, Forni, 1990
Mario Da Passano, Omicidi, rapine, bardane, Carocci, 2015
Paul Duncan/Jurgen Muller, Film noir, 100 all time favourites, Taschen, 2014
Anna Maria Foli, Guida letteraria di montagna, Ets, 2021
Mario Gromo, Cinema italiano (1903-1953), Mondadori, 1954
Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell’umanità, trad. Giuseppe Bernardi, Bompiani, 2022
Giorgio Ieranò, Atene. Il racconto di una città, Einaudi, 2022
Marina Jarre, Il tramviere impazzito, Einaudi, 1962
Primo Levi, Opere complete III, c. Marco Belpoliti, Einaudi, 2018
Libri d’Italia 1953, Sansoni, 1954
Antonietta Mazzette, Dualismo in Sardegna. Il caso dela criminalità, Angeli, 2019
Jurica Pavicic, Acqua rossa, Keller, 2022
Piccola guida tascabile alla gastronomia non convenzionale in letteratura, ABE, 2022
Nuto Revelli, L’anello forte, Einaudi, 2018
Colm Toibin, Il Mago, Einaudi
Gene Wilder, Baciami come uno sconosciuto, trad. Catia Lattanzi, Sagoma, 2010
LIBRI (ABBASTANZA) RECENTI RECUPERATI
Carlo Emilio Gadda, I Luigi di Francia, a cura di Marina Bertoldi, Adelphi, 2021
Un divertimento, un ‘lavoro alimentare’ come si dice per alcuni film laterali di grandi registi. In definitiva un’opera minore e, come per molto Gadda, un’incompiuta. Trasferitosi a Roma da Firenze nel 1950 e assunto al Terzo Programma della Rai, il Carlemilio propone i ‘quattro Luigi’ che si fermano a tre e vanno in onda nel 1952. I testi, variamente anticipati, sono raccolti in volume nel 1964, sulla seconda edizione garzantiana è stabilito il testo della presente, con in coda tutte le varianti di uno scrittore che, ha ricordato Stajano in una recente intervista, impiegava venti minuti anche soltanto per vergare la dedica a un libro, impegnato a rimuginare le parole acconce.
La cupa malinconia del malaticcio Luigi XIII figlio dell’assassinato Enrico di Navarra (e l’ocaggine di Maria de’ Medici, la grullaggine di Anna d’Austria, il francese biascicato con cadenze siculo-romanesche di Mazzarino), il ‘marmocchiaccio’ Luigi XIV e la scialaquatrice Montespan, Luigi XV il beneamato insofferente del suo ruolo pubblico (sono memorabili, per me le più belle del libro, le pagine sulla sua politica fiscale). Ritratti psicologici e ‘pettegoli’ che attingono in pari grado alla memorialistica e alla diaristica d’epoca e alle ampie narrazioni storiche di Michelet e Lavisse, saccheggiati e in taluni casi scopiazzati (di un mostro sacro non si può dire, meglio ricorrere a perifrasi come “la fantasiosa rielaborazione”, ma il confronto fra originali e rese italiane condotto con acribia dalla nota al testo è impietoso). E stile controllato e piano: con qualche svolazzo, senza i suoi memorabili voli, ma qui siamo al servizio del servizio pubblico.
Il ‘gran borghese’ Gadda è attratto dall’arte di governo dei reali di Francia perché vi ravvisa una lento e costante lavorio che mira a costruire l’ordine, contro il plebeismo parvenu che (lo si può cogliere nell’ Entr’acte dedicato a Molière e al suo “borghese gentiuomo”) sfocerà in Napoleone e, per li rami, nel sommo borghese plebeo Mussolini-Pirgopolinice investito dalla sua furia in Eros e Priapo.

Giulio Guidorizzi, Il grande racconto di Roma antica e dei suoi sette re, Il Mulino, 2021
I greci mercanti e navigatori protesi verso l’altrove, i romani agricoltori e pastori attaccati alla terra. I greci intestatari di una mitologia lussureggiante e ramificata, i romani privi di miti. Ma è proprio così? I miti romani, spiega Guidorizzi, sono quelli della fondazione: non soltanto né soprattutto quello di Enea, posteriore all’età arcaica (è noto agli etruschi nel VI-V secolo ma viene sistematizzato da Catone il Censore, e siamo all’incirca al 200 a. C., prima che se ne impadronisca Virgilio), o quello del brigante-mostro Caco ucciso da Ercole, ma proprio quelli delle origini della città, dei sette re. Già Romolo e Remo intrecciano nella loro vicenda diverse leggende ricorrenti nell’area mediterranea e non solo: la discendenza eneadica dei latini dai quali i due fratelli si distaccano, la genealogia divina (Marte che si congiunge con la vestale Rea Silvia), l’abbandono alle acque (come Mosè e altri personaggi mitici e storici), l’animale-totem che li nutre, la rivalità mortale fra i due fratelli (come Caino e Abele, in modo molto più cruento come Esaù e Giacobbe) a testimonianza che la primogenitura e l’origine del potere furono vicende non pacifiche. A differenza dei greci ferocemente divisi in città-stato che restringevano la cittadinanza e discriminavano i metechi, la città-stato Roma è inclusiva e sempre pronta ad allargarsi: come estensione della cinta urbana (l’integrazione di latini, sabini, etruschi che procede di pari passo con l’inglobameno dei “sette colli”), come imperialismo regionale e poi italico e globale. I primi re, a metà fra storia e leggenda, sono sabini (Numa Pompilio, Anco Marzio, per via di parentele anche il feroce Tullo Ostilio) ed etruschi (Servio Tullio, Tarquinio Prisco, Tarquinio il Superbo), a dimostrazione che si cresce incorporando gli altri. La crescita di Roma è storia di guerre continue (il “bellum iustum”) e di sviluppo degli ordinamenti. Che sono soprattutto religiosi: una religione, forse ancor più di quella greca, che intride di sé ogni momento della vita quotidiana, con una “pax deorum” da conquistare con riti, sacrifici e norme di condotta che permettono o, più spesso, tabuizzano. Non è questione di fede ma di magia: ogni momento della giornata, ogni atto, ogni porzione del territorio, ogni stato mentale ha il suo “piccolo dio” che vi presiede e che va blandito (felice la derisione di Agostino d’Ippona nel De civitate Dei, a proposito delle divinità che presiedono alle vicende matrimoniali, tanto quanto è atroce la svalutazione della casta Lucrezia: Agostino era uomo di talento e mascalzone al tempo stesso), e sarebbe interessante ricostruire nel dettaglio il calendario religioso romano: si ha come la sensazione, leggendo, che non esista giorno privo di un rito, e che l’anno dei romani fosse un percorso di guerra irto di trappole. Dal V secolo, le divinità maggiori si allineano a quelle etrusche e, con la mediazione etrusca, a quelle greche: Zeus-Iupiter, Era-Giunone, Afrodite-Venere, Ares-Marte, Efesto-Vulcano, Demetra-Cerere. Ma con divinità autoctone (Giano, Fauno, Quirino) e divinità greche che attecchiscono poco (Minerva, Diana, Apollo, Nettuno, per non parlare di Bacco: il vino e l’ubriachezza a Roma sono visti con sospetto quando non con ostilità, le donne che si ubriacano vengono messe a morte). Che altro? La persistenza di riti arcaici (il “rex nemorensis”, che mi fa venir voglia di riprendere il Ramo d’oro di Frazer), gli strati della lingua latina (a scuola, tanto tempo fa, apprendevo soltanto l’idioma tirato a lustro della classicità), una prossimità al primitivo maggiore di quanto pensassi. Guidorizzi scrive scorrevole e sapido, la narrazione è sontuosamente illustrata.

Marina Jarre, Ritorno in Lettonia, Einaudi, 2003 e Bompiani, 2023
Ci sono libri che fanno vibrare corde profonde, che interrogano chi li legge. A me è accaduto con Ritorno in Lettonia di Marina Jarre (1925-2016), che il 10 maggio Bompiani rimanda in libreria curato dalla bravissima Marta Barone (il suo Città sommersa, Bompiani 2020, è tra i libri più memorabili degli ultimi anni).
Non conoscevo Marina Jarre se non per sommarie informazioni: una scrittrice torinese circondata dall’aura degli autori einaudiani, i titoli delle sue opere, non molto altro. Con questo libro, con questa “autobiografia aggiustata” (la definizione è dell’autrice) ho cominciato a conoscerla e continuerò a leggerla, perché della sua arte mi interessa il nocciolo duro che riguarda, lo dice Claudio Magris, «l’identità e la sua incertezza e la sua polivalenza; la frontiera o meglio le frontiere e il loro rapporto con la scrittura; la continua perdita o riconquista della propria persona». Sono in un’età in cui diventa naturale riflettere su quel che è rimasto del me stesso di ieri e su quel che è mutato. Su quel che ho perso e su quel che ho acquisito. Sulle frontiere che ho attraversato e sui tradimenti di cui sono stato vittima o attore.
Ritorno in Lettonia narra, con molte necessarie divagazioni che riannodano i fili di un’esistenza e connettono la vicenda personale alle tragedie collettive, un viaggio compiuto, oltre sessant’anni dopo la fuga precipitosa, nei luoghi dove l’autrice è nata e cresciuta. Dice ancora Magris: «Il senso dell’arte di Marina Jarre risiede, si potrebbe dire, nella stratificazione della Storia nella sua memoria, talora in un suo fondo di oblio. (…) Quel lavoro di disseppellimento che è la narrativa di Marina Jarre, ritrovamento e creazione di vita che è anche costruzione di se stessa, come dice splendidamente la scrittrice: “Come donna sono dovuta nascere da me stessa, mi sono partorita insieme ai miei figli”».
Riga, 1925. Clara Coisson (1896-1981), piemontese di famiglia valdese e di forte tempra calvinista, è lettrice di italiano presso la locale università. Si è laureata nel 1922 a Magistero, dopo l’esperienza in Lettonia dirigerà dal 1940 al 1943 l’Istituto di cultura italiana a Sofia, in Bulgaria. Nel secondo dopoguerra insegnerà e sarà una delle grandi traduttrici dal russo per Einaudi e Frassinelli. A Riga, la giovane e inflessibile Chiara conosce un ebreo affascinante, Samuel Gersoni.
Figlio di pellettieri, Gersoni ha trascorso qualche anno in Russia, è stato anche nell’Armata Rossa. Poi ha fatto l’allenatore e il rappresentante della Michelin per i paesi baltici. L’industriale no, appena riceve in eredità l’azienda paterna di pellami la cede subito a un cugino e per qualche anno folleggia con i proventi. Clara e Samuel si sposano, il matrimonio dura dieci anni ed è costellato di splendori e miserie: regali sontuosi, pony e bambole a Marina “Minni” e alla sorella minore Annalisa detta Sisi, che negli anni ’70 sarà segretaria di redazione di Tuttolibri; brillanti a Clara, uno viene scagliato in faccia a Samuel durante una lite e non verrà più restituito; e periodi in cui Samuel va in giro con il cappello in mano. Soprattutto, il matrimonio è costellato di scenate furibonde: Samuel è un uomo che ama le donne e Clara non tollera i ripetuti tradimenti. Si separano e Clara, temendo che le vengano sottratte le figlie, fugge in Italia con loro.
Marina e Sisi approdano a Torre Pellice, capitale del piccolo mondo resistente dei valdesi, dei ‘barba’ che riuscirono a sopravvivere ai progetti sterminatori dei Savoia e di Luigi XIV. Vengono cresciute dalla nonna materna; Marina che fino a quel momento ha parlato in tedesco (e anche in russo e in polacco, non in lettone) continua a corrispondere in tedesco con la madre. Le lettere sono a volte inquietanti: «Si è rifatto vivo il brigante» scrive la bambina Marina, è il padre che le va a trovare due volte e il cui appello estremo a essere salvato («Ricordatevi che anche voi siete ebree» scriverà nell’ultima lettera alle figlie) resta inascoltato. Perché nessuno può immaginare la tragedia all’orizzonte, perché c’è un grumo di rancori duro da sciogliere.
Imparerà l’italiano come una lingua straniera, Marina Jarre, e qualche esitazione, qualche inflessione inconsueta affiora «nell’asciutta maestria del suo stile». Lei stessa scriverà: «La lingua di mia madre, divenuta forse quella dei miei sogni – ma i sogni hanno davvero accordi e grammatica, o non parlano nella nostra anima, e intanto dormiamo, con parole invece tutte e soltanto loro? – lingua però non immediata, che devo ogni volta riafferrare e controllare, da impropria rendere propria. Che non è mai intima. La impiego in quanto strumento».
Intanto il padre si è rifatto una vita con un’infermiera tedesca, che nel 1940 rientra in patria lasciandogli la figlia Irene. Moriranno insieme, il padre e la bambina, in quel dicembre 1941 in cui a Riga si fanno le prove generali della soluzione finale, prima ancora che sorgano i lager: i circa trentamila ebrei di Riga vengono rinchiusi in un ghetto, poi condotti nel bosco di Rumbula non lontano dalla città, dove sono fucilati in massa e sepolti in profonde fosse comuni, dopo che i loro corpi sono stati bruciati perché del massacro non rimanga traccia. Sovrintende all’eccidio la Wehrmacht, provvedono materialmente i nazisti lettoni, oggi in gran parte riabilitati in quanto “patrioti antisovietici”. E di questo silenzio più rancoroso che impacciato, di questa omertà che non arriva a essere negazionismo ma ci si avvicina, si colgono molte tracce nel “diario di viaggio” di Marina Jarre.
La storia, le storie. Il padre perduto e rimosso, trasformato in fantasma (tutte le lettere e le fotografie smarrite o distrutte, quasi a non volere eco o memento di quell’infanzia prima incantata e poi infelice) è recuperato nel viaggio che l’autrice settantenne, accompagnata dal figlio Pietro che quel viaggio ha organizzato, compie. Assieme alla memoria dell’orrore, che si ha pudore a raccontare perché «la cosa non può essere narrata».
Ritorno in Lettonia è tante cose insieme: il diario di uno spaesamento, di un non essere da nessuna parte (in un suo intervento Marina Jarre si chiederà: «Quale patria per chi non ne ha nessuna o ne ha più d’una?»), la ricostruzione di uno sterminio ancora poco noto che è anche lutto privato e, insieme, della genealogia dei Gersoni (la sorte più che secolare di una famiglia, che riflette e incarna quella di un popolo).
Ha detto Marina Jarre in una bella intervista rilasciata ad Antonio Gnoli, a proposito dello scrivere: «Lo preferisco al parlare. Scrivendo restituisco i miei vari strati. I dolori, come le gioie. Le frastornate vicende accadute. È l’accumulo delle cose che mi interessa. La polvere che si toglie dalla vita. Scrivere è una forma di chiarezza. Di onestà con se stessi».
La chiarezza e l’onestà possono produrre il miracolo di un’epifania inattesa. «Vidi al margine di una macchia di alberi una lapide, mi parve, coperta di fiori. Non ebbi tempo per chiedermi che cosa fosse perché un attimo dopo, molto in alto, a destra, scorsi una scritta enorme, «Rumbula» – l’insegna della stazione –, e proprio nel medesimo momento, dall’altra parte della strada, una pietra nera con incisa, ben visibile, nell’angolo superiore a sinistra, la stella di Davide. Ecco i miei, mio padre, Irene, e Levin e Beile e Frume e Juddel e Abrahàm e Isacco, ecco i miei. Adesso, al contrario, ciò che diventava vero e presente, in quella stella di Davide che segnava il luogo dove lo avevano ucciso, non era la morte di mio padre, era la sua vita. Lo ritrovavo vivo. Scesa dalla macchina, mi fermai piangendo davanti alla pietra nera posta su un’altra pietra nera. Sopra questa, alcuni sassolini. Pietro stava in silenzio alle mie spalle. Non lessi la scritta, mi asciugavo gli occhi e pregavo. Così, pregando, chiesi perdono in tedesco, la nostra lingua, a mio padre, al mio Papi, per quello che gli avevano fatto e per essere uscita, quel mattino di dicembre, senza tornare indietro».
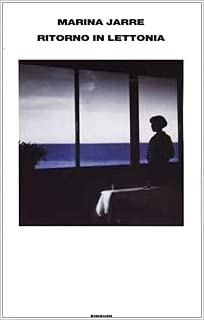
Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, Feltrinelli, 2022
Da qualche tempo si affacciano in libreria romanzi scritti bene e documentati con scrupolo ma senza particolari assilli di stile, che hanno soprattutto l’urgenza di raccontare: un fatto, un personaggio, una storia, una famiglia. Erano così Il treno dei bambini di Viola Ardone, tutto sommato anche I leoni di Sicilia di Stefania Auci. Storie ‘vere’, a volte – è il caso di Titti Marrone – storie dolorose e necessarie. Qui è di scena il combattimento tra l’inferno e l’amore, non saprei dirlo altrimenti.
L’inferno è quello che hanno vissuto i bambini ebrei scomparsi nella Shoah, ma anche i sopravvissuti ad Auschwitz e Terezin, quelli nascosti in conventi e orfanotrofi, quando non in soffitte, scantinati e armadi. Di venticinque di loro, quattro anni il più piccolo e quindici il più grande, si prendono cura dal 1945 un gruppo di donne guidate dalla psicoterapeuta – e governante, e madre sostituta – Alice Goldberger. Li ospita la villa di sir Benjamin Drage, ebreo soccorrevole, a Lingfield nel Surrey, vigila su di loro la donna che ha voluto e avviato l’impresa, la grande Anna Freud figlia di Sigmund. Restituire l’infanzia a bambini che combattono ogni minuto con gli incubi, che diffidano dei grandi e in genere del mondo, che reagiscono con il mutismo e l’apatia oppure con scatti improvvisi di violenza. Che sono sgomenti di fronte a tanta generosità e sospettano la trappola. Che non mangiano ma rubano e nascondono il cibo come facevano nei lager.
Farli sentire a casa, dare loro il necessario, ma anche vestiti belli, giochi e musica e istruzione, vegliare sui loro sonni agitati, accarezzarli e non punirli mai senza rinunciare a guidarli, accogliere i loro silenzi e ascoltare i primi esitanti racconti senza forzare loro la mano. Farli crescere, rintracciare genitori e parenti superstiti o trovare loro una famiglia adottiva, avviarli alla vita e alla fatica – per loro più forte – di crescere. Non sempre c’è il lieto fine, e questa non è una fiaba, ma nell’asciutta commozione che guida la penna di Titti Marrone trova misura di verità quello che Giacomo Debenedetti definiva, sulla scorta di George Eliot, “il latte dell’umana bontà”.
«Erano passati sette mesi dall’arrivo del primo gruppo e Alice sentiva che era venuto il momento di fare di più. Oltre ad accogliere, sfamare, curare, tranquillizzare, oltre a insegnare l’inglese e a inserire i piccoli ospiti nelle scuole, c’era da cominciare l’altro lavoro, il più difficile. Toccava farlo insieme ai bambini, che dovevano essere aiutati a ricordare, penetrando nei loro segreti cullati dal silenzio. Con delicatezza, senza forzarne l’interiorità scorticata, senza mettere a nudo troppo bruscamente la carne viva di memorie tanto vulnerate. Lei sapeva bene che rammentare è come rammendare, cucire gli strappi, inclusi quelli interiori. Ripararli sapendo che i segni sarebbero restati comunque indelebili e visibili. Il recupero delle memorie di traumi estremi come quelli vissuti dai piccoli ospiti di Lingfield non era mai stato tentato prima. Non esistevano precedenti né teorie di supporto né strade già tracciate. Ed era facile immaginare che sarebbe stato devastante».
Rammendare il mondo, spendersi, esserci. Vale per tutti la scritta sulla stele all’ingresso del Giardino dei Giusti, nello Yad Vashem di Gerusalemme: «Chi salva una vita, salva il mondo intero».

Rita Monastero, Il manuale degli errori in cucina, Gribaudo, 2020
Trucchi semplici: come ovviare agli eccessi di limone, di sale, di piccante in un piatto. Come rimettere sui binari una maionese impazzita. Come evitare che il purè risulti colloso. Facile: evitare le patate a pasta gialla, cuocerle il giusto e non farle impregnare d’acqua, usare lo schiacciapatate e non il frullatore, non aggiungere il latte freddo alle patate calde, pena uno shock termico che scompone il composto.
Un passo indietro. Mi hanno regalato l’ottimo Manuale degli errori in cucina di Rita Monastero (Gribaudo), che sfoglio con piacere e divertimento, pensando che ne avessi bisogno. Avevano ragione: scrivere di cucina non significa essere bravi ai fornelli, come scrivere di musica non significa saper suonare. Il grande Gianni Mura, mi racconta un amico che lo conosceva bene, aveva qualche problema anche con le uova sode.
Insomma, si teorizza spesso quel che non si sa fare. Vado avanti, certi trucchi verranno buoni: lasciare riposare la carne (il bollito o l’arrosto) o il pesce (il polpo: non c’è nessun bisogno di sbatterlo contro uno scoglio o contro il lavello) perché le fibre si rilassino e si inteneriscano. Evitare la carne troppo magra per lo spezzatino e il lesso. E non usare la maionese quando si frulla il fondo di cottura del girello, per fare il vitello tonnato: meglio le uova sode.
Ma il dubbio che serpeggia, l’empatico manuale non ne ha colpa, diventa certezza di fronte al quesito: «Ho un problema con l’involucro esterno del timballo: si rompe o resta bagnato sul fondo, come se fosse crudo. Da cosa dipende?» Ecco, io questo errore non lo commetterò, perché non farò mai il timballo di pasta, come non farò la sachertorte o l’anatra all’arancia.

Vladimir Nabokov, Mašen’ka, traduzione di Franca Pece, Adelphi, 2022
«La nota propensione dei principianti a violare la propria vita privata inserendo sé stessi, o un sostituto, nel loro primo romanzo è dettata, più che dall’attrattiva di un tema già pronto, dal sollievo di sbarazzarsi di sé prima di passare a cose migliori». La “scintillante alterigia”, definizione di Citati, con cui Nabokov congeda il suo primo romanzo (lo scrisse a Berlino fra il 1925 e l’inizio del 1926) è temperata dalla sincerità priva di schermi con cui ammette, nell’introduzione del 1970, «l’acuta fitta sentimentale di attaccamento al mio primo libro».
La rievocazione di un primo amore – Nabokov dice con fedeltà superiore alla rammemorazione di Tamara nell’autobiografico Parla, ricordo – che reca con sé anche il congedo, il distacco: nell’esergo (“Ricordando i flirt di anni passati/ ricordando l’amore di un tempo”, Puskin), nella dedica alla moglie Vera. Come a dire: vedi, non era niente.
A Berlino, nella pensione per gli emigrati russi allestita e gestita dall’anziana e blandamente eccentrica Lidija Nikolaevna Dorn – le stanze sono contrassegnate da fogli di calendario – si dà convegno un’umanità sospesa fra il bizzarro e il patetico, in una sorta di Père Goriot segnato dalla sconfitta: l’estroverso Alferov che aspetta la moglie in arrivo dalla Russia, non la vede da quattro anni e sfinisce gli altri ospiti con la sua esultanza; l’anziano e cardiopatico poeta Podtjagin che forse non giungerà mai a Parigi; i ballerini Kolin e Gornocvetov che dividono una stanza e aspettano un ingaggio; la malinconica segretaria Klara dal seno generoso.
Abita nella pensione anche l’alias di Nabokov, il giovane e bello Lev Glebovic Ganin. Di lui si sa poco, non riesce troppo simpatico per l’eccessiva sicurezza ma è di buon cuore: con ogni probabilità nato bene, ha combattuto nella guerra civile contro i bolscevichi, è stato ferito ed è espatriato. A Berlino ha fatto l’operaio, il cameriere e, prima accensione che annuncia il Nabokov maggiore, «più di una volta aveva venduto anche la propria ombra, come abbiamo fatto tanti di noi: ossia, andava in periferia a lavorare come comparsa su un set cinematografico, nel capannone di un luna park, dove la luce ribolliva con un sibilo mistico dalle enormi sfaccettature di lampade puntate come cannoni su una folla di figuranti, irradiati di un chiarore cadaverico. Sparavano una raffica di fulgore micidiale, illuminando la cera dipinta dei visi immobili, per spegnersi poi con un click – ma rossi tramonti morenti continuavano a lungo a baluginare in quei cristalli barocchi: era la nostra umana vergogna. Il lavoro era finito, e le nostre ombre anonime venivano mandate in ogni angolo del mondo».
Ganin il cui corpo prima «ardeva sempre dall’urgenza di fare qualcosa», di fare colpo, è ora stranamente apatico, come se in lui un bullone si sia allentato. Ha una storia con la languorosa Ljudmila che sospira al cinema e chiede con insistenza “Ma mi ami?”, e lui non la ama ma non ha il coraggio di lasciarla. Dovrebbe partire, annuncia ogni settimana che sabato se ne andrà, ma finisce sempre per rinviare. La sua vita sospesa ha una scossa quando apprende che la moglie attesa da Alferov con gioia febbrile è Mašen’ka, la giovinetta che lui, sedicenne convalescente dal tifo, conobbe e amò in campagna, a cui fu legato per qualche anno a San Pietroburgo e alla quale ancora scriveva soldato. Le pagine dedicate a quel primo amore sono vivide, magnifiche, trepidanti, e fanno tenerezza nelle loro goffe accensioni (ma gli scrittori, anche i grandi, il più delle volte incespicano alle prese con l’eros).
Ganin dunque la rivedrà, trova il coraggio di lasciare Ljudmila e trascorre i giorni che lo separano dalla mattina del sabato rievocando quell’amore e fantasticando sulla gioia del ritrovarsi. La sera prima che il treno arrivi giunge a fare ubriacare il marito e a manomettergli la sveglia, per precederlo. Ma non andrà alla stazione, prenderà a sua volta un treno in un’altra stazione, abbandonando Berlino. Perché il passato è una terra straniera. Tutto qui? Tutto qui, e scusate se è poco. Come se fosse facile prendere congedo dalla gioventù.
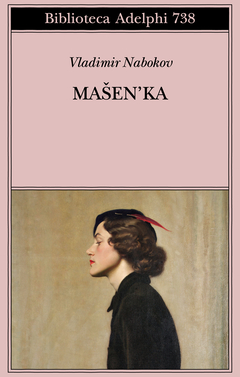
Pamela Paul, 100 cose che abbiamo perso per colpa di Internet, trad. Fabio Galimberti, il Saggiatore, 2022
Un garbato e spesso acuto equivalente americano dei Dizionari delle cose perdute di Francesco Guccini. Con un retrogusto nostalgico meno accentuato e un passato meno lontano di quello evocato dal Maestrone. Il pre-internettiano, grosso modo dagli anni ’80 a oggi, farebbero pur sempre più di quarant’anni e non ce ne siamo quasi accorti. L’autrice è editor della New York Times Review of Books e la sua compilazione, pur accattivante, è più ingegnosa che memorabile: cento brevi testi che da noi si sarebbero chiamati elzeviri.
Non so se conserverò il libro, per il momento conservo quel che secondo Pamela Paul si è perso, anche se non sono sicuro che tutto quel che lei elenca sia davvero andato. Dunque: la noia, il punto, quello che sa tutto, perdersi, perdere il biglietto, trovare per caso l’anima gemella, le foto venute male, archiviare i documenti, gli ex fidanzati, essere in ritardo, la libertà di non avere i genitori sempre addosso, il guidatore designato, la telefonata, i formulari sanitari, non doversi preoccupare sempre di come ci vedono gli altri, la biblioteca scolastica, scovare delle chicche nei mercatini delle pulci, le rimpatriate del liceo, nessuno si è ricordato del mio compleanno, il telefono in cucina, il pasto in famiglia, l’umiliazione privata, il topo di biblioteca, girare per vetrine, rimanere soli con sé stessi, la produttività, le lettere al direttore, immergersi in uno spettacolo, il Rolodex, affidarsi al dottore, essere i primi, essere gli unici, i biglietti di auguri di compleanno, una buona notte di sonno, conoscere a memoria i numeri di telefono, il giornale, le opinioni impopolari, i viaggi in solitario, le scartoffie, le telefonate perse, il dizionario spagnolo-inglese, la pazienza, ignorare le persone, le schede didattiche, l’anzianità di servizio, guardare fuori dal finestrino, la guida tv, la cortesia, le receptionist, le feste in famiglia, lasciare un messaggio, giochi e giocattoli, le mappe, l’empatia, le lettere scritte a mano, le tecnologie superate, vivere il momento, l’ortografia, i dischi, non sapere che tempo farà, leggere prima di addormentarsi, l’interruzione di chiamata, l’intervallo di attenzione, il campo estivo, i RSVP, i libri di testo, la vacanza, l’agenda, guardare la gente negli occhi, lavorare da soli, le riviste patinate, chiedere educatamente, chiacchierare con sconosciuti sull’aereo, il libretto degli assegni, non sapere che vi siete persi, la calligrafia, mi scusi, le letterine di Natale, ricordarsi chi è quell’attore, passarsi i bigliettini, il giorno di malattia, i segreti, gli schedari a cassetti delle biblioteche, la lezione universitaria, la memoria, le sale cinematografiche, perdere il manuale delle istruzioni, l’appuntamento al buio, l’enciclopedia, quello nuovo, il panorama, le tesserine dello Scarabeo, l’umiltà, i bignami, l’attenzione esclusiva di mamma e papà, la tastiera cieca, gli album di foto, dimenticare le cose, i segnali sociali, mettere la parola fine.

Gaia Servadio, La cucina in valigia, Neri Pozza, 2022
«Secondo me è molto più facile essere una brava cuoca che una cattiva cuoca. La buona cuoca fa sue le nozioni base, il resto viene da sé». La cucina in valigia, memorie e ricette della giornalista, scrittrice e giramondo Gaia Servadio (1938-2021), è uno dei libri più vivaci e divertenti degli ultimi anni.
Anche per i giudizi affilati. Questo, per esempio: «Gli inglesi, è noto, non sanno cucinare né mangiare… Adesso sono diventati cuochi italianizzati, ti consigliano di aggiungere olio all’acqua bollente quando cuoci gli spaghetti e altre sciocchezze del genere. I puntarelli non hanno nulla a che vedere con le puntarelle romane, i linguini sono le linguine, massacrate; il cappuccino, per loro, accompagna il piatto forte».
Lei, che dal 1956 ha vissuto tra Londra e l’Italia, gli inglesi li ha conosciuti bene. Erano inglesi i suoi due mariti, per qualche anno è stata anche suocera di Boris Johnson che sua figlia Allegra aveva sposato giovanissima: lei lo considerava bugiardo e inaffidabile e cercò di mandare all’aria il matrimonio con la complicità di Philip Roth.
Io Gaia Servadio l’ho conosciuta nel 1988. Mi venne a trovare in redazione, lavoravo allora in un femminile, un ciclone biondo con le calze smagliate. Stava promuovendo il memoir Un’infanzia diversa: lei e la sorella Pucci figlie dell’ebreo Luxardo, un chimico amico di Primo Levi, costrette a nascondersi e a tremare a ogni sparo, la nonna paterna denunciata (e spedita ad Auschwitz, dove morì) da una telefonata anonima.
Ritrovo il clima atroce di quegli anni anche in un paio di ricette. Cucina di guerra, cucina della fame. «Eravamo sfollati a Osimo e prima del coprifuoco si andava sotto le mura, già campagna, a cercare la vitalba, detta anche “erba dei pezzenti”. Facilissima da trovare, la vitalba è una clematide, infestante, piuttosto bella, ti fa fuori una boscaglia in men che non si dica. Ma allora per noi era cibo. Raccoglievamo i germogli, ne facevamo una saccocciata e, via, a casa. Quella sera si mangiava».
Servadio la vitalba la cucinava in brodo con il riso, oppure con i fagioli, o ancora con le uova fritte. Tra le ricette di questo libro ci sono anche la cicorietta selvatica ripassata in padella con aglio, olio, peperoncino e acciughe (peccato, non c’è fave e cicoria) come gli agretti o barba di frate. Mancano tarassaco e borragine, ortica e crescione, malva e bardana, silene e portulaca, papavero e rucola. Potete andarvele a raccogliere nei prati facendo foraging, così fate del moto, risparmiate e vi ricordate che c’è di nuovo, come allora, aria di guerra.

Hans von Trotha, Le ultime ore di Ludwig Pollak, traduzione di Matteo Galli, Sellerio, 2022
Poche ore prima del rastrellamento che il 16 ottobre 1943 avrebbe svuotato il Ghetto di Roma, portando più di mille ebrei a morire ad Auschwitz, un’auto nera si avvicina a Palazzo Odescalchi. Dentro c’è un professore tedesco che ha lasciato l’insegnamento e la patria. Deve convincere l’anziano Ludwig Pollak che ci abita a rifugiarsi in Vaticano con la famiglia, sfuggendo alla cattura e alla deportazione certe. Pollak, che è persona realmente esistita (1868-1943, è stato archeologo, collezionista e mercante d’arte), tergiversa, trattiene l’ospite per ore con il racconto fluviale della sua vita. La misera Praga ebraica che ha lasciato, attraversata dai nazionalismi. La Belle Epoque e il caso Dreyfus. La scoperta di Roma, che diventerà la città della vita e dell’anima. Il culto della bellezza, dell’armonia, di Goethe. L’occhio infallibile che scova capolavori persi (il suo nome è associato per sempre al rinvenimento del braccio destro mancante al gruppo marmoreo di Laocoonte stritolato dai serpenti assieme ai figli: è il braccio ripegato di un uomo sconfitto, non il braccio eroicamente teso verso il cielo delle ricostruzioni rinascimentali). Lo studioso-mercante che costruisce cataloghi meticolosi e filologicamente impeccabili, che ha per clienti grandi artisti (Richard Strauss, Gerhard Hauptmann, Auguste Rodin), miliardari come J. P. Morgan, teste coronate e capi di governo. L’archeologo che ha reso grandi servigi al Vaticano, ritrovando e regalando tesori trafugati. L’uomo che ha già capito di essere al finale della partita: i meriti di una vita non contano più, il cerchio si chiude, da qualche anno è diventato invisibile e non viene più ricevuto dove prima il suo sapere era indispensabile. E allora è meglio srotolare il nastro della propria vita perché «bisogna lasciare testimonianza. Proprio quando tutto finisce. Bisogna raccontare». E allora forse bisogna assecondare il proprio destino, perché a che serve scampare se anche il suo popolo non scampa? Un romanzo-monologo che prende posto, nella mia collezione di eminenti ebrei spazzati via dalla bestialità nazista, accanto ai Camondo di Edmund De Waal e ai Reinach di Filippo Tuena.
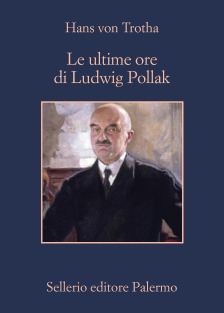
LIBRI CHE PARLANO DI LIBRI
Aa. Vv., A proposito di Libri, Il Post/Iperborea, 2021
Utile quasi mai è dilettevole, e viceversa. Questo è un libro utile e dilettevole, il primo di una serie. Anzi, il primo numero di una rivista-libro, “Cose spiegate bene”. La fa Il Post, giornale online fondato undici anni fa da Luca Sofri, la pubblica la casa editrice Iperborea specializzata in letteratura nordica, dall’Olanda ai paesi baltici passando per la Scandinavia. Si legge con piacere, insegna un sacco di cose. Tutto quello che c’è da sapere sui libri, dalla carta (se le pagine ingialliscono c’è troppa lignite nella cellulosa) ai caratteri (quasi tutti i volumi pubblicati in Italia sono in Garamond: Einaudi ne ha uno suo, disegnato nel 1957, con il vezzo snob e scorretto degli accenti acuti sulla í e sulla ú, mentre Adelphi usa il Baskerville e Franco Maria Ricci era devoto al Bodoni). Dai mestieri dell’editoria ai tempi necessari per fare un libro, dai conti economici (di editori, distributori, librai) alle retribuzioni (di autori, traduttori, lettori, consulenti e ghost writer). Dalle proprietà alle copertine agli illustrati, dai titoli stranieri tradotti e traditi ai tempi necessari perché un titolo straniero arrivi nelle nostre librerie, dagli audiolibri alle attuali tipografie. In mezzo tanto altro, dulcis in fundo i ladri di libri. La maggior parte dei testi sono di Giacomo Papi, che con la sua scrittura elegante e precisa è una garanzia assoluta. Illustrazioni deliziose di Giacomo Gambineri. Interventi di scrittori che non aggiungono quasi niente ma almeno non fanno danni, i migliori sono quelli di Francesco Piccolo e di Giacomo Papi.

Mario Andreose, Voglia di libri, La Nave di Teseo, 2020
Garbata e succosa, una raccolta di articoli soprattutto per il Sole 24 Ore che compone un affresco, quasi un’autobiografia intellettuale. L’autore è Mario Andreose (Venezia, 1934), grande vecchio dell’editoria italiana e oggi presidente della Nave di Teseo. Arrivato a Milano nel 1958 per fare il giornalista, debutta invece come correttore di bozze per il neonato Saggiatore («Ben presto mi sono accorto che, più che lavorare, era come partecipare a un master multidisciplinare permanente»). In quegli anni di apprendistato molti sono i personaggi memorabili con cui lavora, primo fra tutti Giacomo Debenedetti, ma anche Enzo Paci, Remo Cantoni, Ernesto De Martino, Fedele d’Amico, Carlo Giulio Argan e l’outsider Bruno Maffi padre dell’anglista e amerucanista Mario, comunista bordighista, grande traduttore e uomo coltissimo.
Partito correttore, Andreose terminerà come direttore editoriale (intanto, ha tradotto fra l’altro Il secondo sesso di Simone de Beauvoir). Dura undici anni, fino al 1968, l’avventura del primo Saggiatore, tra genio e dissipazione di Alberto Mondadori. Andreose trasloca alle Officine Grafiche Mondadori di Verona, dove curerà l’editoria per ragazzi, la saggistica divulgativa e le coedizioni internazionali d’arte. Ci resta fino al 1979, quando una segnalazione di Erich Linder, princeps degli agenti letterari, lo fa approdare alla Fabbri. Entrata nella galassia Fiat, come in seguito Bompiani, Sonzogno, Etas e Rizzoli, Fabbri è il trampolino di lancio per Andreose che diventa direttore generale del gruppo. Fino allo ‘spezzatino’ di testate e sigle editoriali del Gruppo Rcs deciso, a partire dal 2015, da John Elkann e realizzato (è di quegli anni anche la sciagurata vendita della sede del Corriere in via Solferino) da Pietro Scott Jovane.
Contrari a quella politica di dismissioni (in quegli anni viene ceduto anche Palazzo Grassi a Venezia che, annota pungente Andreose, aveva spese di gestione inferiori allo stipendio di Bobo Vieri) sono soltanto il notaio Pier Gaetano Marchetti e l’azionista (allora) di minoranza Urbano Cairo. Bompiani, come Rizzoli, dovrebbe finire alla Mondadori ma Andreose, con Umberto Eco, Elisabetta Sgarbi e altri, non ci stanno. Tentano di rilevare la casa editrice e, il resto è storia d’oggi, daranno vita alla Nave di Teseo. Lunga vita…
Sono stato alla Rcs dal 1987 al 2006, negli anni di Andreose, caposervizio ad Amica e caporedattore a Io donna. E con Bompiani e Rizzoli ho pubblicato due libri più alcune prefazioni e una dozzina di traduzioni. Per dire che c’ero e condivido il resoconto asciutto, privo di rancori ma assai netto, che fa Andreose: l’eccellenza editoriale spesso e volentieri vanificata dai repentini cambi di gestione e da una mancanza di visione strategica a medio e lungo termine. Per i libri si trattava di direttori editoriali che andavano e venivano, fino al suo lungo regno, e di piani di pubblicazione contraddittori (Andreose racconta come Bompiani perse Stephen King a vantaggio della Sperling & Kupfer, io ricordo autori di primo piano lanciati e lasciati andare come Milan Kundera, Paul Auster e Mario Vargas Llosa).
Per quotidiani e periodici, di amministratori delegati che cambiavano ogni due tre anni e di prospettive periodicamente azzerate. Ci furono gli anni delle quasi intese con i tedeschi di Burda, dei flirt con i francesi (nello ‘spezzatino’, la Flammarion acquistata e rilanciata che, nelle intenzioni sensate di Colao, doveva essere, con acquisizioni mirate, il perno di un gruppo in grado di fare concorrenza ad Hachette, finì alla Gallimard) e dell’attrazione ‘fatale’ per gli spagnoli (l’acquisto a prezzi esorbitanti di Recoletos, avversato da Colao che a causa di questa scelta lasciò il gruppo, e che pesò come un macigno sui bilanci futuri).
Ma in realtà al gruppo Fiat diventato dominus nei libri (Fabbri rilevata dai fratelli fondatori per crediti inesigibili, Bompiani Sonzogno Etas cedute da Carlo Caracciolo) e nei giornali (Corriere e galassia periodica in seguito al dissesto causato dal piduista Bruno Tassan Din) l’editoria interessava poco. Nella logica di quegli anni, contava soprattutto (tentare di) orientare l’opinione pubblica con il quotidiano di via Solferino, il resto era minutaglia buona al più per le private vanità degli Agnelli.
Restano tuttavia, di quegli anni, imprese affascinanti. Il successo mondiale per niente scontato di Umberto Eco che era stato per diciassette anni redattore e dirigente di Bompiani, con il suo esordio narrativo Il nome della rosa. E infatti, agli inizi, l’editore francese Seuil lo rifiutò (il romanzo finì a Grasset) e, a New York, David Rieff figlio di Susan Sontag gli preferì Il giorno del giudizio di Salvatore Satta (prese Il nome della rosa Harcourt Brace Jovanovich con un anticipo di 6000 dollari, qualche settimana dopo era al primo posto nella classifica dei libri più venduti del New York Times).
Restano le collane di classici (bello il racconto di Leonardo Sciascia anche suggeritore, dopo la rottura con Sellerio). Resta la straordinaria impresa di Giovanni Reale, che propose e quasi impose una meravigliosa collana di Classici della filosofia (in quindici anni sarebbe arrivata a trecento titoli) proponendo che lui e i suoi collaboratori fossero pagati soltanto in base ai diritti d’autore e impegnandosi a consegnare i file dei volumi pronti per la stampa.
Assieme al resoconto appassionato di oltre mezzo secolo di lavoro editoriale, c’è la sezione scoppiettante di aneddoti dei ritratti. T. S. Eliot “monarchico, cattolico e conservatore” che, alla Faber & Faber, rifiuta nel 1944 La fattoria degli animali di Orwell: è in odore di trotzkismo e l’alleanza con Stalin è sacra. Comma 22 di Joseph Heller stroncato da Evelyn Waugh. Saul Bellow tombeur de femmes e padre a 85 anni (e l’altrettanto tombeur, geniale quanto sregolato, Enrico “Nani” Filippini), Inge Feltrinelli e Luciano Foà, il multiforme e a me molto caro Alberto Vigevani, narratore squisito, piccolo editore e libraio antiquario raffinato (Il Polifilo), che cura per Raffaele Mattioli la Ricciardi e che nel 1943 Arnoldo Mondadori manda in Svizzera per assicurarsi, a guerra ultimata, Ernest Hemingway (Andreose annota, perfido: chissà quanto avrà pagato per assicurarsi la produzione del dopoguerra, quasi tutta mediocre).
C’è anche il vecchio Arnoldo: che corteggia i mostri sacri come Thomas Mann invitandoli nella sua villa di Stresa ma, quando qualcuno degli autori alza il prezzo, lo porta a fare un giro a Verona, dove oltre alla tipografia c’è il magazzino della casa editrice. E, di fronte alle navate di libri invenduti, batte il bastone contro il pavimento e lancia un bestemmione. Capiscono quasi tutti il messaggio, e calano le pretese.
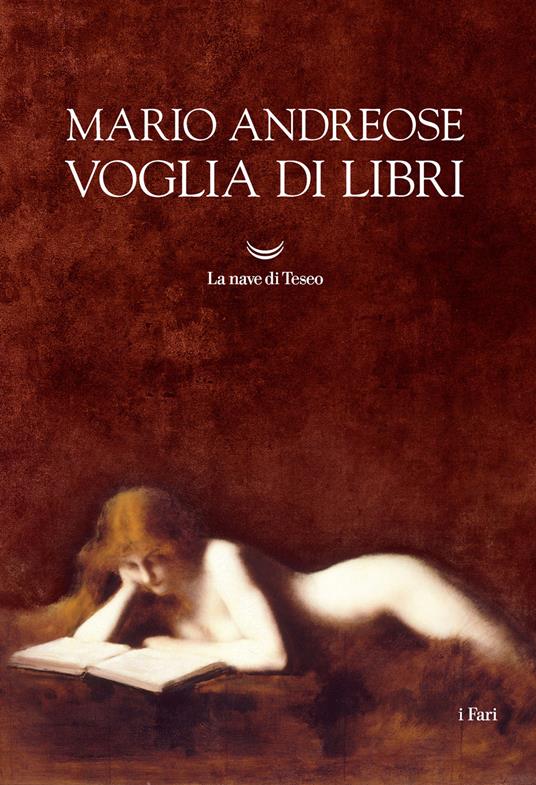
Alfonso Berardinelli, Leggere è un rischio, Nottetempo, 2012
«L’atto della lettura è a rischio. Leggere, voler leggere e saper leggere, sono sempre meno comportamenti garantiti. Leggere libri non è naturale e necessario come camminare, mangiare, parlare o esercitare i cinque sensi. Non è un’attività primaria, né fisiologicamente né socialmente. Viene dopo, implica una razionale e volontaria cura di sé. Leggere letteratura, filosofia e scienza, se non lo si fa per professione, è un lusso, una passione virtuosa o leggermente perversa, un vizio che la società non censura. È sia un piacere che un proposito di automiglioramento. Richiede un certo grado e capacità di introversione concentrata. È un modo per uscire da sé e dall’ambiente circostante, ma anche un modo per frequentare più consapevolmente se stessi, il proprio ordine e disordine mentale». La plaquette di Alfonso Berardinelli (quattro interventi: uno sulla lettura, uno sulla critica, due sulla poesia) ha un incipit bello e condivisibile ma, a voler cercare il pelo nell’uovo, imperfetto: leggere è anche esercitare uno dei cinque sensi, spesso più d’uno.
La lettura è minacciata, oltre e prima ancora che dal “multitasking” e dalle infinite distrazioni della quotidianità, dal suo porsi come pratica culturale al confine tra individualità e socialità, fra singolarità e uguaglianza, due pulsioni fondanti della modernità che non sempre si amalgamano e si conciliano. Altri rischi per chi non sia uno specialista sono secondo Berardinelli la lettura dei classici premoderni e quella degli “articoli di fede” (i testi classici del marxismo e i Vangeli, per intenderci). Sono osservazioni stimolanti ma non mi trovano d’accordo.
Vediamo un po’: sostiene Berardinelli che, dopo la rifondazione dei generi letterari ad opera di Montaigne, Cervantes e Shakespeare (la prosa di pensiero, l’epica, il teatro con la commistione fra tragedia e commedia), è impossibile ritornare agli antichi. «Se è vero che per leggere, capire e interessarsi a un autore c’è bisogno di Einfühlung, di immedesimazione, anche se si tratta di Parmenide o Virgilio, è altrettanto vero che sentirsi contemporanei dei sapienti presocratici o di un classico latino può indurre una certa dose di follia anacronistica: almeno in Occidente, la cui storia ci ha spinto a elaborare e idolatrare appunto un’idea di storia come progresso e rivoluzione, superamento incessante di condizioni precedenti e interruzione periodica di continuità».
Un ragionamento suggestivo ma viziato da un falso sillogismo: che immedesimarsi equivalga a sentirsi contemporanei di un autore. Quando, da ragazzi, tenevamo per Ettore e non per Achille studiando l’Iliade, credo che provassimo semplicemente simpatia per l’eroe valoroso e sfortunato, contro l’arroganza dell’invincibile: lo stesso sentimento che ci portava a preferire, in letture più frivole ma altrettanto formative, Paperino a Gastone.
E poi, non sempre leggere è immedesimarsi: spesso lo è, scavalcando secoli e millenni (parlavano non a torto, i miei antichi professori di liceo, dell’universalità dei classici: si pensi all’ombra lunga che hanno gettato su tutta l’arte occidentale Ulisse e Antigone. Creature di Omero e Sofocle, certo, ma anche di Dante, Joyce, Brecht e Anouilh, per citarne soltanto qualcuno). Viene in soccorso lo stesso Berardinelli quando ricorda che una delle modalità della lettura è «mettere il testo al servizio della propria autobiografia più o meno esplicita», cioè attualizzarlo o “presentificarlo”.
Ma spesso leggere i classici è “mettersi nei panni di” dopo avere accertato una distanza. Non occorrerà essere specialisti o eruditi, basterà essere profani curiosi e appena un po’ informati, per farsi irretire dalla grande lirica amorosa stilnovista o petrarchesca: pur sapendo che Beatrice e Laura erano “fantasmi d’amore”, pretesti per il dispiegamento di una recita in codice. Pur sapendo che Dante si era sposato con Gemma Donati e che Petrarca aveva avuto figli da più donne. E se follia anacronistica c’è, ben venga. È la stessa che manifesta un giovane autore americano, Daniel Mendelsohn, quando scrive: «Per quanto mi riguarda la più struggente espressione letteraria sull’amore è la Vita Nova di Dante: è la mia opera letteraria preferita, e mi commuovo ogni volta che la leggo. Non riesco a pensare a un testo che racconti con tanta generosità di sentimento e tanta nuda ingenuità cosa sia l’amore, e cosa significa perderlo. Un tipo di esperienza che prima o poi viviamo tutti».
Quanto al canone cristiano e marxista, scrive Berardinelli che «l’attribuzione di valore che una comunità e una società compiono nella scelta di certi testi, nel modo di leggerli e di rispondere alla lettura, fa di alcune opere qualcosa di intoccabile, sottratto alla critica e alla discussione». E aggiunge che spesso sono diventati «dogmi imposti e difesi con il ricatto, le minacce, la coercizione». Vero, e al tempo stesso non così vero. Vero, nel senso che gli orrori del modello sovietico, dei processi staliniani, dei gulag sono ancora presenti e vividi nella memoria. Così come lo sono in ambito cattolico l’Inquisizione e i suoi delitti, le scomuniche anche non lontanissime (quella contro il modernismo, per esempio, o in tempi più recenti il pugno di ferro di Wojtyla contro la teologia della liberazione).
E falso, nel senso che la stessa presenza delle ‘eresie’ (o più semplicemente, di letture fortemente divergenti di uno stesso testo) testimonia che l’erezione dei dogmi è un processo non lineare. Il marxismo, per quanto si sia atrocemente inverato nel socialismo reale, ha avuto robuste e popolari ‘letture’ socialdemocratiche e liberal-libertarie. E nel cristianesimo, che cosa accomuna De Maistre e Simone Weil, i falangisti spagnoli e appunto i teologi della liberazione? Ogni testo, lo spiega bene Berardinelli altrove, ha una sua ermeneutica e una sua ricezione: si costruisce e vive nel dialogo con il lettore. Vale anche per i “testi sacri”.
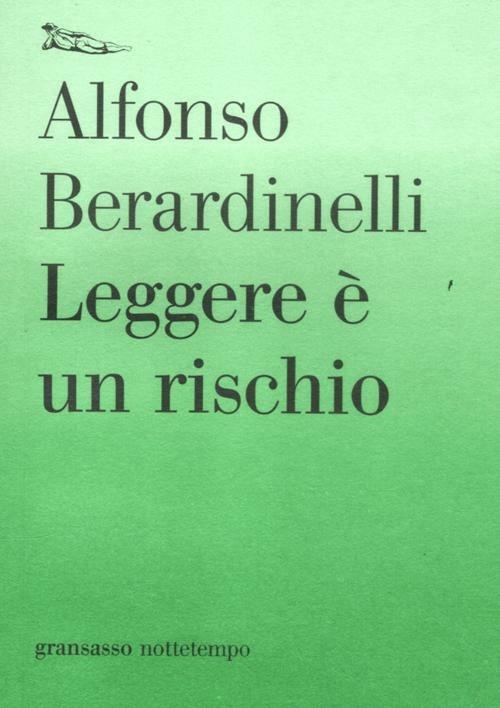
Jacques Bonnet, I fantasmi delle biblioteche, traduzione di Roberta Ferrara, Sellerio, 2009
«”Li avete letti tutti?”. Certo che no. O meglio, forse. In realtà non lo so, è complicato. Ci sono libri che ho letto e dimenticato (e sono molti) e libri ai quali ho dato solo una scorsa e che ricordo benissimo. Insomma non sempre li ho letti, ma li ho sempre sfogliati, annusati, soppesati. Dopo, l’opera può prendere tre direzioni (parlo dei libri scelti e comprati da me, e quindi già ‘selezionati’, e non di quelli che ho ricevuto da altri): lettura immediata o a breve termine; lettura fra qualche tempo (può trattarsi di settimane, di mesi e anche di anni se le circostanze sono particolarmente avverse e l’afflusso eccessivo: sono le famose “pile di libri da leggere”) e infine libri da mettere nella libreria. In un certo senso sono stati ‘letti’ anche quelli: sono classificati da qualche parte nella mia mente come nella mia biblioteca. Prima o poi serviranno, anche se non so dire a che né quando; comunque non sono là per caso».
Jacques Bonnet, scrittore-editore francese che firma questo delizioso libro, risponde così alla prima domanda che il proprietario di una grande biblioteca (la sua supera i 20mila volumi, il doppio della mia) si sente immancabilmente rivolgere: ma li hai letti tutti?
La seconda, altrettanto ineluttabile, è: ma come fai a trovarli? Ovvero, come li cataloghi? I metodi sono tanti, almeno quante sono le grandi biblioteche: per ordine alfabetico, per nazione, per collana, per colore del dorso e così via. Ognuno ha controindicazioni.
Il ‘metodo Bonnet’ prevede due grandi aree: letteratura e saggistica. All’interno delle aree scattano le suddivisioni (letteratura italiana, francese, inglese, ecc. storia, filosofia, psicologia, critica letteraria, ecc.) e, all’interno delle suddivisione, un ordine alfabetico per autori. Raccontato così, il libro di Bonnet può sembrare noioso da morire mentre invece, giuro, è amichevole e cordiale.
Partendo dalla croce e delizia di possedere tanti libri, e chiedendosi come si arrivi ad esserne sommersi (di queste parti non dico niente, sono il tessuto connettivo), Bonnet divaga. Dirigendosi di volta in volta nei paraggi del sublime e dell’aneddotico, del prosaico e del maniacale (come classificare un autore jugoslavo? oppure uno delle repubbliche ex sovietiche?).
Ecco, gli aneddoti. Sono tanti e tutti godibili: dalla raccomandazione di mettere i libri ovunque risparmiando però la parete che sovrasta il letto (il compositore Charles-Valentin Alkan, detto “il Berlioz del pianoforte”, morì nel sonno schiacciato dal crollo di una libreria) al proprietario più mirabolante (Boulard, sindaco dell’VIII Arrondissement parigino sotto Napoleone, che aveva 600mila libri stipati in dieci stabili: quando morì e gli eredi misero in vendita la sua biblioteca, tra il 1828 e il 1832, il prezzo dei libri usati crollò per un decennio).
Dal bibliofilo che collocava distanti tra loro i libri di autori fra i quali c’erano stati screzi o era sorta inimicizia (Borges distante da Lorca, Garcia Marquez da Vargas Llosa, Shakespeare da Marlowe, Martin Amis da Julian Barnes) al sarto Karl Lagerfeld che avrebbe accumulato 300mila libri.
Se gli aneddoti sono piacevoli, le divagazioni lo sono ancora di più. Qual è la giusta velocità di lettura? I libri vanno sottolineati e annotati? (Risposta: sì). Vanno prestati? Come si fa, in caso di separazione o divorzio, se si possiede una biblioteca coniugale?
I libri cambiano nel corso della vita? Cambiano, risponde Bonnet: un autore che da giovani ci aveva affascinato da adulti può risultare insopportabile, lui cita Paul Morand; un libro che ricordavamo imponente si scopre piccolo nelle dimensioni, lui cita Casa d’altri di Silvio D’Arzo; un personaggio che ci aveva appassionato ieri oggi viene soppiantato: per esempio in Anna Karenina Bonnet da giovane era commosso dalla passione che legava Anna a Vronskij, mentre oggi s’intenerisce per la sorte del marito di lei.
E ancora: i personaggi sono autonomi dagli autori? Perché Benjamin Constant e Victor Hugo tenevano una contabilità della loro vita sessuale? Si potrebbe proseguire citando il libro per intero.
Lo evito, e termino con tre frasi: «È molto raro che un uomo istruito non trovi qualcosa da apprezzare in un brutto libro». (Plinio il Vecchio). «Le migliori frittate con il lardo le ho mangiate da Alexandre Dumas». (Jacques Laurent). E infine, perfetta per i lettori bibliofili: «Dopo il piacere di possedere libri, nessun altro eguaglia quello di parlarne». (Charles Nodier).
Come mai questo titolo? La parola al Petit Larousse: «Fantasma: foglio o cartoncino che si mette al posto di un libro tolto da uno scaffale di biblioteca o di un documento preso in prestito».

Carlos Maria Dominguez, La casa di carta, traduzione di Maria Nicola, Sellerio, 2011
«Nella primavera del 1998 Bluma Lennon comprò in una libreria di Soho una vecchia edizione delle poesie di Emily Dickinson e, arrivata alla seconda poesia, al primo incrocio, fu investita da un’automobile. I libri cambiano il destino delle persone». È l’incipit di La casa di carta di Carlos Maria Dominguez, apparso nel 2002 in Argentina. Del libro, storia di bibliofilia e follia, avevo già letto in un altro splendido libro sui libri, I fantasmi delle biblioteche di Jacques Bonnet: il protagonista Carlos Brauer, nell’impresa titanica e insana di creare una classificazione diversa da tutte le altre per la sua sterminata biblioteca, impresa che lo porta anche a studiare la teoria dei frattali, considera tra i criteri di catalogazione quello delle affinità e delle inimicizie tra gli autori. Borges, così, non può figurare accanto a Garcia Lorca, che ha definito “andaluso di professione”. Né Garcia Marquez accanto a Vargas Llosa che lo ha preso a pugni per un affare di donne. Né Shakespeare accanto a Marlowe, dopo le reciproche accuse di plagio. Per la stessa ragione, l’argentino Roberto Arlt non andrà messo nello scaffale dei latinoamericani ma al fianco di Dostoevskij.B
luma Lennon, ispanista a Cambridge, muore falciata sulle strisce mentre si sta immergendo nella Dickinson. E il professore che prende il suo posto, un argentino che narra la storia in prima persona, qualche settimana dopo riceve per posta un libro destinato a lei: una copia della Linea d’ombra di Conrad impastata di cemento. Sulla copertina c’è la dedica della donna a un misterioso Carlos che a Monterey, nel corso di una fugace avventura in margine a un congresso di accademici, non è riuscito a stupirla. Incuriosito, il narratore torna a Buenos Aires per le vacanze. Trova una città globalizzata. «L’avenida Santa Fe aveva soppiantato Corrientes. Ora vi aprivano grandi librerie pretenziose, megastores di dischi, stereofonia e libri, vasti caffè, cinema e teatri, davanti ai quali si accasciavano file di mendicanti. La gente camminava col cellulare all’orecchio e guidava con l’apparecchio pinzato contro la spalla, tutti parlavano al telefono, sugli autobus, nei supermercati, mentre spazzavano i marciapiedi, come se una febbre verbale si fosse impossessata delle loro vite». Sulle tracce di Carlos approda in Uruguay, in una Montevideo «discretamente sporca, discretamente antica, discreta perfino nell’indole dei suoi abitanti».
Carlos Brauer, il narratore apprende dal raffinato collezionista Delgado, è stato un bibliofilo in preda a un desiderio senza limiti, un grande appassionato di Ottocento e di francesi, proprietario di oltre 20mila volumi compulsati e annotati – ‘scopati’ diceva lui, riferisce l’inorridito amico – al quale la biblioteca era sfuggita di mano. Prima invadendo la sua casa e costringendolo a mutare abitudini (aveva ceduto l’auto per riempire di scaffali il garage, faceva la doccia soltanto con l’acqua fredda per evitare che il vapore rovinasse i volumi che affollavano il bagno, si era ridotto a dormire in soffitta per destinare a biblioteca anche la camera da letto), poi diventando ingovernabile.
Carlos si era messo allora a stilare un minuzioso catalogo, ma un incendio gliel’aveva distrutto. A quel punto, varcata la sua personale linea d’ombra, aveva venduto la casa ed era scomparso con i suoi libri. Era andato a rifugiarsi in una spiaggia sperduta davanti alla quale passavano le balene e lì, solo con l’Atlantico, aveva usato tutti i suoi libri come mattoni, regolarmente intonacati, per costruire una casa di carta. Che aveva fatto franare, prima di scomparire definitivamente, per estrarre dalle pareti quella Linea d’ombra che aveva restituito alla professoressa inglese sul conto della quale aveva, peraltro, formulato una profezia di un’esattezza agghiacciante.
I libri come ragione di vita e la bibliofilia come passione e delirio. Nipotino di Borges, Dominguez è tuttavia un postmoderno con l’accorato sentimento che l’era delle grandi biblioteche (e delle grandi narrazioni) è finita. E che i libri non dicono e non forniscono l’ordine del mondo. E tuttavia, «da quando ho memoria, non ho mai smesso di comprare libri. La biblioteca che si mette insieme è una vita. Non è mai una somma di libri». E «il lettore è un viaggiatore che si muove in un paesaggio già scritto. Un paesaggio infinito. L’albero è già stato scritto, e la pietra, e il vento fra i rami, e la nostalgia di quei rami e l’amore cui prestarono la loro ombra. E non conosco gioia più grande che percorrere, in poche ore, un tempo umano che altrimenti mi sarebbe estraneo. Non basta una vita. Rubo a Borges la metà di una frase: una biblioteca è una porta nel tempo».
Il tempo del più giovane Dominguez (nato nel 1955) è stato quello della giunta militare di Videla. Per lui il libro diventa anche apologia della libertà. «Un vaso si rompe, una caffettiera o un televisore si guastano molto prima di un libro. Un libro non si rompe, a meno che qualcuno non voglia distruggerlo, strappandone le pagine, dandogli fuoco. Negli anni dell’ultima dittatura militare argentina, molta gente bruciò i libri nel water, nella vasca, intere raccolte nel cortiletto di casa. I libri erano diventati pericolosi. Dovendo scegliere fra i libri e la vita, la gente sceglieva, e si trasformava nel proprio carnefice. Libri che erano stati lungamente studiati, libri che avevano risvegliato passioni, vocazioni irrinunciabili e allontanato gli amici dagli amici, salivano al cielo trasformati in cenere che si disperdeva nell’aria. Io non ne ebbi il coraggio. Arrotolavo le riviste e le introducevo nel tubo della tenda del bagno, nascondevo i libri più temibili nell’ultimo recesso degli armadi, nella seconda fila degli scaffali della libreria, pur sapendo che in una perquisizione a sorpresa sarebbero stati scoperti. A quel tempo i libri accusarono molta gente. Spezzarono delle vite».
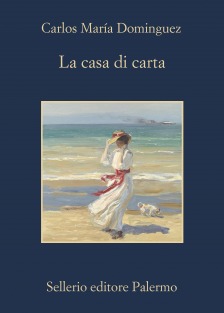
Leo Lowenthal, I roghi dei libri, traduzione di Marilla Boffito, Il Melangolo, 1991
La barbarie del nazismo, che sarebbe sfociata nella guerra al mondo e nella politica dello sterminio, ebbe tra le sue prime sinistre manifestazioni il rogo pubblico dei libri con cui, nel 1933, Hitler e Goebbels celebrarono la presa del potere. Leo Lowenthal (1900-1993), che di lì a poco avrebbe lasciato la Germania, aveva fondato nel 1926 l’Istituto di Studi Sociali – la celebre Scuola di Francoforte – con Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. Cinquant’anni dopo, parlando a un convegno della Libera università di Berlino, avrebbe ricordato la profezia di un grande scrittore tedesco, Heinrich Heine: «Là dove si danno alle fiamme i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini».
ll rogo nazista del ’33 è il culmine di molte atrocità specificamente tedesche (la festa della Wartburg del 1818, condannata da Goethe ed Hegel, in cui vennero dati alle fiamme testi ebraici) ma la storia dei roghi dei libri è antica più o meno quanto la storia umana. Dall’imperatore cinese Shih Huang-ti, costruttore della Grande Muraglia, che nel 220 a. C. dà l’ordine di incenerire le opere di Confucio e i testi storici – e di seppellire vivi i possessori di libri proibiti – alla distruzione della biblioteca ebraica durante l’insurrezione dei Maccabei del 168 a. C. Dalla soppressione di testi cristiani – e poi pagani – voluta da Diocleziano e Costantino, agli innumerevoli fuochi purificatori accesi dai cristiani contro ebrei ed eretici, fin quasi all’800. «In Francia, durante le guerre di religione fra cattolici e protestanti», ricorda Lowenthal, «fu mandato al rogo un libraio evangelico: a una forca innalzata lì vicino erano appesi la Bibbia e il Nuovo Testamento, che vennero poi bruciati a loro volta. Sotto l’Ancien Régime sono numerosi i casi in cui il parlamento ordina che un libro condannato sia bruciato dal boia ufficiale: a questa, naturalmente, si aggiunge la pena inflitta al suo autore. Un esempio particolarmente spaventoso della simultanea distruzione di un libro e di un essere umano è costituito dalla pratica non rara al tempo delle guerre di religione, di conficcare in bocca e nelle ferite del protestante ucciso pagine della Bibbia proibita».
L’avversione ai libri accomuna assolutismi religiosi e terreni, chiese ed imperi, nazismo e stalinismo. I portatori di assoluto vogliono cancellare la storia e ripartire da un eterno presente, il loro: e il fuoco cancella tutto, non lascia tracce. I libri come le streghe, come gli eretici. In definitiva (è la tesi di George L. Mosse sui roghi nazisti) come metafora del demonio.
Se il passato, il pensiero critico, l’alterità vanno cancellati o almeno interdetti (è tutto cattolico, e data al 1564 con Gregorio XVI, un mostro come l’Index librorum prohibitorum, abolito soltanto nel 1965), nel presente i distruttori di libri cercano i portatori di malattie, di infezioni che il potere non tollera. L’equivalenza tra i libri proibiti e la peste è ancora cattolica: «Agli umanisti di Firenze e Venezia, i quali tentavano di convincerlo a impedire i roghi dei libri, il cardinale Ghislieri rispose che nella città colpita dalla peste, i principi ordinavano di bruciare le suppellettili dove vi era pericolo di contagio e la gente era disposta a sopportare questa perdita per salvare la città. Lo stesso doveva valere per la peste dell’eresia, propagata dai libri».
La peste degli ecclesiastici è, per Stalin, «delitto di controrivoluzione individuale» per chi vende, produce o conserva letteratura non ortodossa (articolo 58 del codice penale dell’Urss). «Più specificamente, sia detto questo in termini teorici: in nome di una cattiva soggettività che ricorre al mito del capo carismatico e, insieme, al sentimento popolare tenuto sotto tutela … si deve porre fine a tutte le testimonianze e a tutti i testimoni che hanno arricchito la storia umana di opere e di valori permanenti. È significativo che questa magica orgia di distruzione ruoti intorno al libro e perciò anche a quello che la tradizione rappresenta come il popolo del libro, gli ebrei, la cui liquidazione sta per la liquidazione totale di tutta l’intellighentzia… L’ostilità verso ciò che è scritto, verso la scrittura, è diretta contro la libertà di un’interpretazione pluralistica, ermeneutica e dunque individuale. Non la parola scritta bensì l’urlo costituisce il carisma di un’immediatezza insofferente di qualsiasi discorso tra soggetti autonomi».