Dove si parla di uomini illustri – Di Vittorio per esempio o Calvino e Lucentini – di altri assai avventurosi oppure curiosi della vita degli altri. E soprattutto si commentano e si consigliano, vigilia del 25 aprile, le straordinarie lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana
Nel menu di aprile libri recenti, qualche volta appena usciti. Qualche recupero di opere sfuggite in passato alla lettura, due gialli che mi hanno svagato nel torpore della convalescenza. E un omaggio alla Resistenza, nel più crudele dei mesi.
Aa. Vv., Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana, Einaudi, 1952

Questa celebre raccolta di Piero Malvezzi (1916-1987) e Giovanni Pirelli (1918-1973) va tenuta a portata di mano, letta e riletta, anche soltanto per piccoli assaggi. Perché testimonia non soltanto che cosa fu la Resistenza ma quanto, negli anni della lotta all’invasore hitleriano e al feroce e moribondo fascismo, nei partigiani condannati, l’amor di patria fosse di gran lunga il sentimento dominante.
In questa Spoon River della dedizione e del sacrificio, che ha per scenario di guerra soprattutto il Centro-Nord, le vittime provengono tuttavia da ogni regione, da tutti i ceti sociali: legioni di operai e contadini, ma anche commercianti, impiegati, casalinghe, intellettuali, religiosi, dirigenti, industriali e proprietari terrieri.
Sfumata a volte la fede politica, che è più netta nei comunisti e negli azionisti, comune a tutti il pudore e la dignità di chi ha fatto una scelta disinteressata: per il bene dell’Italia, per più alti ideali, per fedeltà a se stessi, per onore militare (notevolissime le lettere di alcuni generali che riscattarono con il loro sangue la vigliaccheria di casa Savoia).
Si possono leggere queste lettere anche come “finzioni”, nel senso più nobile del termine: come rappresentazioni composte e pacate di se stessi a consolazione dei familiari. Importa comunque sottolineare che, nello sforzo di mettere a tacere le paure e di soffocare le meschinità, rari sono gli sfoghi, le esplosioni di sconforto, i dettagli atroci (pochissimi raccontano o soltanto accennano alle torture subite, e oltre metà dei condannati subirono sevizie terribili), scarsi risultano gli appelli alla vendetta e più frequenti si levano le voci che spingono alla riconciliazione e a una giustizia serena: per mansuetudine cristiana, ma anche per nobile riflessione etica e politica.
Scrive per esempio, in una lettera che resta a lungo impressa nella memoria, l’azionista Pedro Ferreira, tenente di fanteria ventitreenne, genovese: «Poche ore prima di morire formulo a voi tutti gli appartenenti al Partito a cui io pure appartengo, i migliori auguri affinché possiate apportare alla nuova Italia di domani quelle masse di energie sane e libere, tanto necessarie per la rigenerazione del Paese. Ma la calma e la serenità che io provo in questo momento tragico derivano anche e soprattutto dal fatto che non sento di nutrire nessun rancore, che non mi sento animato da nessun senso di impotente vendetta contro nessuno, quantunque la mia cattura, e conseguentemente la mia morte siano avvenute solo ad opera di un vile agente provocatore.
Egli però sarà domani serenamente giudicato dalla giustizia umana, e, se non da questa, certamente da quella dell’al di là. Dico “serenamente”, perché la nuova Italia di domani non dovrà macchiarsi dei crimini di cui oggi si macchia la repubblica sociale italiana con giudicare affrettatamente e in massa, senza tenere in alcun conto l’uomo e vedendo solo il nemico da sopprimere. Anche tra le personalità ed i funzionari repubblicani, vi sono degli elementi che, pur considerati nemici, dovranno esser domani trattati con la massima considerazione ed il massimo rispetto, esaminando il bene che hanno fatto come uomini, in contrapposizione al male che gli potrete attribuire per il fatto che essi hanno appartenuto ad organizzazioni o enti della repubblica sociale».
Non tutto ed anzi molto poco, ovviamente, nella battaglia contro Brigate Nere ed SS è tenzone cavalleresca. Tuttavia, più delle sevizie e della morte tormenta i condannati il senso di colpa nei confronti delle famiglie. Per i disagi materiali ai quali sono esposte dai partigiani più poveri, che privano spesso mogli e genitori dell’unica fonte di sostentamento. E per le sofferenze, per il carico di dolore che sopporteranno. Anche – e molto – perché i partigiani hanno compiuto una doppia ribellione: al nazifascismo, ma anche al codice familista che imponeva ai figli di obbedire ai genitori, di pensare soltanto alle faccende familiari e di stare lontani dalle tentazioni del mondo (soprattutto da quelle politiche: e colpisce il fatto che, nelle lettere, le ragioni della scelta che ha condotto alla morte siano spesso taciute).
Si sottraggono a questa logica i militanti più consapevoli. Come il diciannovenne Ferruccio Ulivi che invita gli amici a meditare sul futuro dell’Italia e su un rinnovato senso del bene comune che riaccosti la gente alla politica. Come lo studente comunista Walter Fillak:
«Mio caro papà,
per disgraziate circostanze sono caduto prigioniero dei tedeschi.
Quasi sicuramente sarò fucilato.
Sono tranquillo e sereno perché pienamente consapevole d’aver fatto tutto il mio dovere d’italiano e di comunista.
Ho amato sopra tutto i miei ideali, pienamente cosciente che avrei dovuto tutto dare, anche la vita; e questa mia decisa volontà fa sì che io affronti la morte con la calma dei forti.
Non so che altro dire.
Il mio ultimo abbraccio
Walter».
Colpisce, nella raccolta, la maturità emotiva e la purezza senza sbavature dei più giovani. È impossibile e sarebbe inopportuno fare graduatorie in una raccolta come questa, ma ho particolarmente cara la lettera di Giordano Cavestro (Mirko), studente di Parma che nel 1940, quindicenne, dà vita a un bollettino antifascista e, nel 1943, costituisce le prime formazioni partigiane della zona. Condannato a morte dal tribunale militare e fucilato nel 1944, scrive:
«Cari compagni,
ora tocca a noi.
Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d’Italia.
Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella.
Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuole fare più vittime possibile.
Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care.
La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esempio.
Sui nostri corpi si farà il grande faro della Libertà».
Un’ultima annotazione: di fronte alla parte migliore dell’Italia stanno non soltanto la tirannide e gli invasori, ma anche un’orrida zona grigia. Metà dei condannati a morte che scrivono l’ultima lettera (tacciono soltanto le vittime dei grandi massacri, da Marzabotto a Sant’Anna di Stazzema a Cefalonia, e l’elenco degli eccidi, che i curatori hanno premesso alla raccolta, gela il sangue) sono stati venduti ai tedeschi o alle brigate nere da infiltrati, spie, provocatori, funzionari zelanti. Il più delle volte da delatori anonimi: i vicini di casa che correvano ad avvisare la milizia, la squadraccia, il presidio tedesco se un partigiano circolava in piazza, se andava di nascosto a trovare la famiglia, se si rifugiava ammalato da amici, se varcava la soglia di una sagrestia per tenere una riunione clandestina.
Domenico Moriani detto “Pastissu”, diciott’anni, impiegato alla Camera di commercio di Imperia, scrive alla nonna:
«Non piangere, sono condannato a morte, tu non devi farci caso, fatti coraggio.
Io vado a trovare mia madre che è tanto tempo che non vedo. Quel che ho potuto fare ho fatto. Tu non disperarti perché un giorno ci rivedremo e ci troveremo tutti assieme al di là. Anche gli altri si calmino e non pensino a me, io non ci faccio neanche caso, anzi sono quasi contento.
Tanti saluti a tutti e un pensiero a mio fratello.
Per sempre addio».
È stato catturato in montagna, al confine tra il Piemonte e la Francia, da militari tedeschi che lo hanno costretto a scavarsi la fossa e lo hanno finito con un colpo alla nuca. Dormiva con un compagno in un pagliaio e i tedeschi che li hanno presi erano guidati da un gruppo di bambini. Che uomini saranno diventati, quei bambini?
Paul Auster, Baumgartner, trad. Cristiana Mennella, Einaudi, 2023

«Non faccio la vittima, né mi piango addosso né alzo lamenti al cielo: perché proprio a me? Perché a me no? Le persone muoiono». A Sy Baumgartner, settantenne professore di filosofia in pensione, dieci anni prima è morta la moglie Anna, falciata da un’onda anomala mentre faceva un’ultima nuotata a Cape Cod. «Per i primi sei mesi aveva vissuto in uno stato di confusione cosí profonda che a volte si svegliava al mattino senza ricordare che Anna era morta». Però sceglie di vivere, di “inventarsi una solitudine” fatta di piccole cose, di amicizie tenaci, di un nuovo amore affrontato con una goffaggine che fa tenerezza e presto finito. Sceglie di vivere tenendo viva la memoria della moglie, che in vita era stata soprattutto traduttrice, facendo pubblicare le sue buffe poesie inedite e da ultimo offrendo ospitalità a una studentessa che si accinge a scrivere la tesi di laurea su di lei. «Mi manca, tutto qui. Era l’unica persona al mondo che io abbia mai amato, e ora devo trovare un modo per continuare a vivere senza di lei».
Sy Baumgartner è personaggio al quale ci si affeziona fin dalle prime pagine. Entra nella storia con un’irresistibile sequenza slapstick che lo stesso Auster definisce “alla Buster Keaton”: non riesce a prendere la telefonata della sorella rompiscatole, e in rapida successione si ustiona con il padellino lasciato sul fuoco dopo avete aperto la porta, ruzzola nelle scale che portano al seminterrato. E prosegue, malgrado il carico di dolore che ha accumulato, con generosità e senza querimonie, aperto al prossimo e al mondo. Nel procedere erratico e divagatorio che gli conosciamo, Auster fa parlare al telefono il protagonista con la moglie morta, gli fa acquistare libri in maniera compulsiva per poter salutare la fattorina che glieli recapita, gli fa stringere amicizia che un giovanotto tontolone che lo soccorre e più avanti gli sistemerà il giardino, gli fa avere un incidente d’auto con un cervo, lo mette al centro di mille piccoli e grandi accadimenti.
In questo romanzo che potrebbe essere il suo ultimo – Auster è in chemioterapia – l’autore svela anche qualcosa della sua schiatta di ebrei emigrati negli Stati Uniti da un’Ucraina terra di lupi. Il padre di Baumgartner sarto, la madre – una Auster – che prosegue l’attività del marito e non vuole chiudere bottega anche quando è anziana: «E come la mettiamo con me? Che dovrei fare dentro un villone fuori città? Aspettare che Naomi torni da scuola? Passare il battitappeto? Giocare a solitario? Attaccarmi alla bottiglia e diventare un’alcolizzata? Ho sempre lavorato, Sy, da quando ho sedici o diciassette anni, e questo negozio è tutta la mia vita. Lo so che per te non vale una cicca, e so pure che tuo padre l’ha sempre odiato, ma anche se Trocadero Fashions è un negozio un po’ andante per donne fuori moda, quelle donne sono esseri in carne ed ossa, e quando vanno in giro meritano di stare bene con se stesse. Ecco cosa faccio da anni, prendo dei vestiti un po’ andanti e li modifico, così cadono bene e hanno il taglio giusto, e allora quelle donne si sentiranno belle, e se una si sente bella sta bene con se stessa, e riuscire a far star bene con se stesse quelle donne non più giovani, appesantite, è un servizio, lo definirei un mitzvah, per cui sono orgogliosa di quello che ho fatto qui, Sy, e non penso di aver sprecato il mio talento e che non ne valesse la pena, perché vale sempre la pena, per chiunque, nessuno escluso». Servire, essere utili. La vita è tutta qui, è provare a vivere.
Mario Baudino, Il gran rifiuto. Storie di autori e di libri rifiutati dagli editori, Passigli, 2009

La valutazione di chi accogliere e stampare non è scienza esatta e le case editrici non sono il Cern di Ginevra. Nel catalogo Einaudi, mutati i tempi, figura Antonino Cannavacciuolo e non trovò posto, nell’età aurea della casa editrice, La milleduesima notte di Joseph Roth caldeggiato da Bobi Bazlen e Cesare Cases e stroncato da Italo Calvino. Di ripulse spesso feroci è costellata la lunga corsa di molte opere verso il traguardo della classicità o, più semplicemente, verso il successo commerciale. «Sono rimasta confusa, annoiata, irritata e delusa da questo liceale a disagio che si gratta i foruncoli» annota nel suo diario Virginia Woolf. Sta parlando dell’Ulisse di James Joyce, che ha respinto per la sua Hogarth Press. «Non riesco a capire come si possano impiegare trenta pagine per descrivere come ci si gira e rigira nel letto prima di trovare il sonno» scrivono a Marcel Proust dalla casa editrice Ollendorff. È uno dei tanti rifiuti ricevuti dalla Recherche, dirà no per Gallimard anche André Gide senza averlo neppure letto, e avrà modo di pentirsene. A Dostoevskij respingono senza appello il quarto capitolo di Delitto e castigo, sarà costretto a riscriverlo. A Conan Doyle fanno sapere che Uno studio in rosso, il primo libro di Sherlock Holmes, è «troppo lungo e troppo breve» e lo scrittore racconterà nell’autobiografia: «Il manoscritto tornava indietro con la precisione di un piccione viaggiatore».
Susanna Tamaro invece la liquidano con un secco: «Cara signorina, l’unico talento che lei dimostra è la pervicacia nel ritenersi una scrittrice». Stanno bocciando Va’ dove ti porta il cuore, che accettato da Baldini & Castoldi avrà vendite milionarie. Siamo all’incrocio tra “l’opera” e il bestseller, e anche a non amare la scrittrice triestina viene da chiedersi: ma chi l’ha valutata davvero era convinto che non vendesse neppure una copia? Perché sono accompagnati da rifiuti plurimi i primi passi di autori che avranno vertiginosa fortuna: Irving Stone («Non c’è proprio nessuna possibilità di vendere un libro che parla di un pittore olandese sconosciuto», e stanno cassando Brama di viverededicato a Van Gogh, nel 1956 Minnelli ne ricaverà un film con Kirk Douglas e Anthony Quinn); Grace Metalious (I peccati di Peyton Place, 14 rifiuti); Giulio Bedeschi (Centomila gavette di ghiaccio, due milioni di copie con Mursia, ma prima 15 rifiuti); Richard Bach (Il gabbiano Jonathan Livingston, 20 rifiuti); Frederick Forsyth (Il giorno dello sciacallo, 10 milioni di copie, ma nel 1970 la W. H. Allen & Company di Londra scrive all’autore: «Il suo libro non interessa a nessuno»); George Segal (Love story, il grande agente letterario Erich Linder non riesce a piazzarlo a nessuno in Italia, troppo zuccheroso, lo prende Garzanti per due lire e vende 800mila copie); Mario Puzo (dice no al Padrino Garzanti perché il libro è volgare e il cognome dell’autore impresentabile, anche Sergio Leone rifiuta di farne un film, ci penserà Coppola); Stephen King (gli rimandano indietro Carrie con il verdetto «Non siamo interessati alla fantascienza che mette in campo utopie negative. Non vendono»); per concludere con le tante porte che J. K. Rowling si vede sbarrare prima che la saga di Harry Potter decolli.
Si boccia a volte per pregiudizio ideologico, a volte per pruderie, a volte per singolare miopia anche dei molto avvertiti (Livio Garzanti, a proposito dell’Insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera: «Non voglio dei minori, e per giunta cecoslovacchi»). T. S. Eliot, grande poeta e grande conservatore, non accetta di pubblicare La fattoria degli animalidi Orwell perché mette alla berlina lo stalinismo e Stalin è alleato di guerra. Elio Vittorini respinge per Einaudi e per Mondadori Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa perché lo considera passatista e nostalgico (sulle travagliate vicende del romanzo hanno scritto Gian Carlo Ferretti e, di recente, Francesco Piccolo nell’ottimo La bella confusione). Alla Einaudi rifiutano nel 1946 Se questo è un uomo di Primo Levi (lo pubblica De Silva, Einaudi ci ripenserà nel 1957) perché a guerra appena conclusa affronta un tema troppo doloroso. E Natalia Ginzburg, che lo ha avuto in lettura, lo sottovaluta per una singolare forma di pudore: è ebrea anche lei, potrebbe giudicare per “fatto personale”. Un coro unanime di no riceve Lolita di Nabokov, che in prima edizione esce per la pornografica Olympia Press, e le furenti masturbazioni del protagonista del Lamento di Portnoy di Philip Roth fanno sobbalzare sulla sedia i lettori della Rizzoli, che lo bocciano all’unanimità. Il caso più celebre di bigotteria censoria è L’amante di Lady Chatterley di D. H. Lawrence, stampato privatamente a Firenze nel 1928 e apparso in edizione integrale nei paesi anglosassoni soltanto tra il 1959 e il 1960: affronterà più di un processo per oscenità.
In Italia i grandi censori, non sempre nel giusto, sono Italo Calvino, Elio Vittorini – Tomasi di Lampedusa a parte, sua è l’ostilità al grande Beppe Fenoglio – e Cesare Pavese: nel libro di Baudino non se ne parla, ma la lettera con cui rispedisce al mittente il capolavoro Casa d’altri di Silvio D’Arzo è una cantonata pomposa e supponente.
Come reagiscono gli autori rifiutati? A volte con furore – Alberto Savinio non perdonerà mai Prezzolini che gli ha bocciato Hermaphrodito – e a volte con disperazione: Guido Morselli, che diventerà postumo una delle grandi scoperte di Adelphi, si suiciderà per i rifiuti accumulati in più di vent’anni. Qualche volta con raffinate vendette: e. e. cummings, un grande della poesia novecentesca americana, intitolerà No thanks il suo primo libro di versi del 1935, approdato ai torchi dopo anni di forche caudine, e lo farà precedere dalla dedica: «Nessun ringraziamento a Farrar & Rinehart, Simon & Schuster, Coward-McCann, Harcourt, Brace, Random House, Equinox Press, Smith & Haas, Viking Press, Knopf, Dutton, Harper’s, Scribner’s, Covici, Friede».
Giorgio Caponetti, Il grande Gualino, Utet, 2023
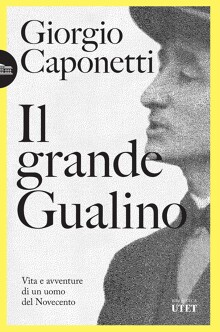
«Gualino offre il braccio alla moglie con un gesto degno di Fred Astaire. “Anduma, baby?” le dice sorridendo. Cesarina, ricambiando il sorriso, accetta il braccio con un gesto degno di Anna Pavlova. “Puduma andé, grassie”».
Il 24 maggio 1959 Riccardo Gualino ha ottant’anni. È tornato a Torino perché alla Galleria Sabauda aprono al pubblico la preziosa collezione che il fascismo gli aveva confiscato e disperso nel 1931: Giotto e Cimabue, Duccio da Boninsegna e Botticelli, Mantegna e Veronese, Filippo Lippi e Tiziano. E gli amati moderni: tra gli altri Picasso e Braque, Modigliani e Casorati. Gualino ha donato la collezione al comune di Torino e si è adoperato perché le opere venissero recuperate: ha fatto intervenire il governo presso l’ambasciata italiana a Londra, perché restituissero i quadri trafugati a suo tempo dal gerarca Dino Grandi per adornare i suoi uffici, e ha pagato di tasca propria le opere che l’ambasciata ha preteso per rimpiazzare il maltolto.
Si apre con il ritorno a Torino questa scintillante biografia romanzata di Riccardo Gualino (1879-1964), industriale e finanziere, collezionista e mecenate. Vita più che romanzesca la sua: uno, più d’uno, quasi centomila. Biellese, figlio di orafi, dodicesimo di dodici figli, Gualino non resta nell’impresa di famiglia e, dopo la laurea in legge, si mette in proprio. Agente di commercio di legname e materiali per l‘edilizia, diventa presto ricco. Nel 1907 ha sposato Cesarina Gurgo Salice di Casale Monferrato, cugina prima di vent’anni più giovane: staranno insieme tutta la vita e, pur colti e poliglotti, fra loro parleranno sempre in piemontese.
Il ricco agente intanto è diventato costruttore: edifica numerosi edifici intorno agli Champs-Elysées, il legname – ha costruito una segheria avveniristica nei Carpazi che rivenderà a Neville Chamberlain futuro premier inglese – gli consente di mettere mano all’espansione di San Pietroburgo. Quando scoppia la rivoluzione d’ottobre, riuscirà a scappare avventurosamente dalla Russia con la moglie, avendo avuto l’accortezza di rivendere le proprietà pietroburghesi a russi che si troveranno con il cerino in mano.
Gualino è incapace di stare fermo: ha fondato una società di navigazione, la Snia, che con Giovanni Agnelli importa carbone americano durante la prima guerra mondiale. È entrato nella chimica (la Snia diventa Viscosa, nasce la Rumianca che produrrà anche l’iprite usata in guerra contro l’Etiopia) accaparrandosi il brevetto per il rayon, la seta artificiale; nell’alimentare (il cioccolato della Unica, rilevato in seguito dalla Venchi); nella radiofonia in società con Marconi, prima che arrivi l’Eiar; in molteplici attività, ha persino uno stabilimento per la lavorazione del merluzzo a Terranova.
Industriale e finanziere, Gualino rastrella azioni che mette a disposizione di Agnelli senior al quale ha spalancato anche le porte della Stampa, consentendogli di diventare azionista di maggioranza della Fiat. Diventa vicepresidente della casa automobilistica ma, quando attacca la politica economica del regime che ha rivalutato la lira con conseguenze infauste per l’export, il senatore Agnelli lo scarica.
È arrivato il 1929 con la grande crisi mondiale e Gualino, indebitato con le banche – con mossa spregiudicata, acquista quelle che lo sovvenzionano – è in difficoltà e la bancarotta di un socio francese lo mette in ginocchio. Il regime non soltanto non fa niente per salvarlo, ma lo condanna nel 1931 a cinque anni di confino a Lipari come “filibustiere della finanza”, sequestrandogli aziende, uffici e case e vietandogli di fare l’industriale.
Gualino resterà in realtà al confino per due anni e, riparato in Francia dove possiede ancora numerose attività – immobili, ristoranti e bistrot, grandi magazzini – si riorganizza tenendo un basso profilo. È riuscito a salvare la Rumianca intestandola a prestanome, la rilancia: nel dopoguerra introdurrà in Italia il pvc. Senza ricorrere più a prestiti – ha un cospicuo patrimonio in conti svizzeri e inglesi – entra nel mondo del cinema. L’amicizia con Joe Kennedy, padre del futuro presidente, gli ha fatto ottenere nel 1927 la licenza europea per i film della Rko. Ma Gualino non si accontenta di distribuire: apre, anche in Italia, catene di sale cinematografiche; crea una società di produzione, la Lux Film dove si faranno le ossa Ponti e De Laurentiis, e la prima società di doppiaggio. Nel secondo dopoguerra porteranno anche la sua firma, fra i tanti, Riso amaro, Non c’è pace tra gli ulivi, Senso e I soliti ignoti. Cinema abbinato alla chimica, per dire dell’uomo: è lui a inventarsi le saponette Lux, con i volti delle dive, dalla Loren a Liz Taylor.
L’imprenditore che non sta mai fermo è anche collezionista di gran gusto – lo assiste l’amico fraterno Lionello Venturi – e finanziatore di pittori, musicisti, ballerini e teatranti e costruttore di case e uffici affidate agli architetti del razionalismo. A Torino, prima di incappare nei fulmini di Mussolini, ha finanziato Casorati, a Roma finanzierà Mafai e altri. In casa si è fatto costruire un teatro privato, ha aperto un teatro pubblico di gusto modernista dove farà mettere in scena fra scandali e mal di pancia il Brecht dell’Opera da tre soldi(negli anni ‘20), Pirandello e i balletti russi, ed eseguire Stravinskij. E a Parigi frequenterà con la moglie la crema dell’intellettualità. Frondista del fascismo, aiuterà la Resistenza e otterrà per questo ringraziamenti ufficiali.
Aperto dal ritorno trionfale a Torino nel 1959, il libro di Caponetti si chiude con Gualino che nel 1958 si sganascia mentre girano I soliti ignoti. Gassmann e Mastroianni spesso devono rifare le scene perché scoppiano a ridere a sproposito mentre Mario Monicelli gli grida dietro: “Ma cercate di stare seri, cazzo”, e intanto scoppia a ridere anche lui.
Cristina Cassar Scalia, Il re del gelato, Einaudi, 2023

Prequel per Vanina Guarrasi, vicequestore, palermitana trapiantata a Catania e qui ai suoi primi passi nella Squadra Mobile. Hanno ucciso Agostino Lomonaco, titolare di quattro gelaterie, sfondandogli il cranio. Prima di ucciderlo, mani sconosciute avevano messo delle pastiglie nelle vaschette dei suoi gelati, seminando il panico tra i clienti. Storie di famiglia complicate: Agostino Lomonaco aveva avviato la pratica di disconoscimento della figlia Corinna, accusando la moglie di averla avuta da una storia con l’ex socio Ruggero Cammarata da cui si era diviso tanti anni prima in maniera fraudolenta. Cammarata viene trovato anche lui con il cranio sfondato, il corpo semicarbonizzato e il suo laboratorio divorato dalle fiamme a simulare un incidente o un suicidio. Si sospetta un giro di estorsione, si sospetta la vendetta della figlia Corinna, il finale arriva inaspettato. Vanina Guarrasi concentra i tratti di molti protagonisti del poliziesco recente: incapace di cucinare ma golosa come Montalbano, brusca e spiccia come Imma Tataranni e Petra Delicado, con fantasmi del passato che non se ne vanno come Rocco Schiavone. Così diventa subito familiare: effetto della serialità con piccole progressioni che asseconda la parte conservatrice di noi lettori, in cerca di conferme più che di sorprese. Di suo Cristina Cassar Scalia ci mette una scrittura piena di brio e un’abile caratterizzazione dei personaggi di contorno. Le storie di Vanina Guarrasi, qui al settimo episodio, sembravano fatta apposta per una serie tv, e la serie è arrivata. La produce per Canale 5 Carlo Degli Esposti di Palomar, lo stesso di Montalbano, e la protagonista è Giusy Buscemi.
Antonio Del Giudice, Figlio della terra, Castelvecchi, 2024
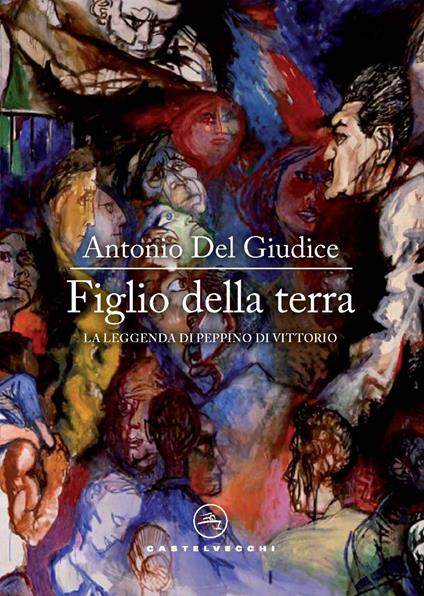
La polizia spara contro una manifestazione di braccianti a Cerignola, sono i primi anni del ‘900 in Puglia, e un amico del giovanissimo Giuseppe Di Vittorio cade a terra, colpito a morte. «Ambrogio è stato, come mio padre, vittima di una ferocia cieca. Non è morto per una colpa, non aveva fatto male a nessuno. È stato fucilato, come briganti che vengono messi al muro. Mio padre non è stato fucilato, ma costretto dalla miseria, per un pezzo di pane da portare a casa, a morire per salvare dall’annegamento gli animali del padrone. Per tutti e due ho provato la stessa rabbia che la povera gente sente quando non riesce a dar da mangiare ai bambini». Il padre del futuro segretario della Cgil muore nel 1904 di polmonite, dopo aver salvato il bestiame altrui a scapito della sua vita. Peppino di Vittorio lascia la scuola a 12 anni e comincia a lavorare: è diventato il capo della famiglia, deve provvedere alla madre e alla sorella. Lavoro duro, nelle campagne i latifondisti sono ancora signori feudali e il lavoro dei braccianti, intermediati e comandati a frustate dai caporali, è lavoro schiavile. Lavoro e politica, da subito, con i socialisti e con il sindacato. E slancio per la gente e per il mondo, voglia di coltivarsi studiando di notte, di conoscere la storia, di apprendere a parlare e scrivere compulsando il vocabolario Zingarelli acquistato in una bancarella (Nicola Zingarelli, ed è una delle tante piccole sorprese che rendono memorabile il romanzo-biografia scritto da Antonio Del Giudice, era di Cerignola come Di Vittorio).
C’è nel Sol dell’avvenire di Nanni Moretti, che Del Giudice richiama, la scena in cui i militanti del Pci nel 1956 assediano Botteghe Oscure chiedendo al partito di prendere parte per gli operai insorti a Budapest e non per Mosca, e Togliatti accoglie la loro richiesta. Non andò così, Di Vittorio che schierò il sindacato con gli insorti venne isolato e costretto ad allinearsi pena la scomunica. Ne soffrì e forse anche questa cocente sconfessione lo portò a prematura morte nel 1957. Il crepacuore di un combattente.
Ci hanno sempre detto che la storia non si fa con i se, ma proviamo a ignorare l’avvertimento. Se Di Vittorio avesse vinto avremmo conosciuto una sinistra diversa, combattiva e umana, protagonista della sua storia e non vassalla di un impero, salda nei valori ma tollerante e rispettosa delle diversità e delle fedi. Soprattutto, dalla parte degli umili, degli ultimi, dei vinti con la testa e con il cuore.
Giuseppe Di Vittorio (1892-1957), socialista e poi comunista, perseguitato dal fascismo – il carcere, l’esilio, il confino a Ventotene –, combattente in Spagna, grande sindacalista, è stato un dirigente politico della sinistra in cui idealità e vita concreta hanno marciato assieme.
Intransigente e pacato, sembra un ossimoro e non lo è. Capace di combattere gli avversari e di rispettarli – ed esserne rispettato a sua volta – e di ringraziare per i doni di un padrone che lo stimava ma di rifiutarli garbatamente perché si può essere oggetto di chiacchiere per molto meno. Attratto dalla bellezza e capace di tradurla in aspirazione alla giustizia: il giovane socialista in visita a Firenze, ammaliato dalle chiese, dal Rinascimento e dalle fontane, e pronto a tradurre quell’acqua in abbondanza in dighe per le sue campagne assetate. L’esule che dovunque andasse cercava di impiantare un orto e un vigneto. Il marito e il padre tenero. Il santo laico dei contadini che sfidava la popolarità di Padre Pio.
Invecchio, sono più facile di un tempo alla commozione e Di Vittorio mi commuove e mi inorgoglisce. Mio padre è stato bracciante e dagli uomini come lui è stato difeso. Alessandro Natta disse che se il partito comunista avesse insegnato a un solo contadino del Sud a non levarsi il cappello davanti a un possidente, la sua esistenza sarebbe stata pienamente giustificata. Di Vittorio insegnò ai suoi contadini pugliesi a portare il cappello abbandonando la coppola dei banditi. E a non scappellarsi. Grazie ad Antonio Del Giudice – il ragazzino Riccardo che nel 1957 è impressionato dalla fiumana di popolo che lo piange, che esordisce come giornalista ricordandolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno– per avere restituito l’umanità e la grandezza di un gigante gentile.
Jenny Erpenbeck, Voci del verbo andare, trad. Ada Vigliani, Sellerio, 2016

Gehen, ging, gegangen. Voci del verbo andare, gli immigrati le imparano nelle lezioni di tedesco che vengono loro impartite a Berlino. Serviranno a poco, perché molti non avranno una nuova patria e le autorità della prospera e civile Germania, applicando il trattato di Dublino, li rimanderanno in Italia dove sono sbarcati. Saranno loro, i richiedenti asilo accolti con educato fastidio, le vere voci del verbo andare. Gli africani nel presidio di Alexanderplatz che viene sgomberato. Gli africani nell’ex scuola di Kreutzberg attrezzata a dormitorio, dove passano le giornate a ciondolare perché è fatto loro divieto di lavorare benché lo chiedano.
Degli africani si accorge Richard, filologo classico in pensione che vive in un sobborgo berlinese, sulle sponde di un lago dove qualche settimana prima è annegato un uomo il cui corpo le acque non hanno restituito. Se ne accorge soltanto quando ne sente parlare al telegiornale, perché qualche giorno prima ad Alexanderplatz è passato accanto alle loro tende senza farci caso.
La prima reazione di Richard è un “progetto” professorale malato di astrattezza perbene: raccogliere informazioni sull’Africa, farsi un’idea degli stati e delle capitali – dell’Africa ricorda soltanto la filastrocca su un negretto cannibale che sua madre gli recitava quando era bambino – e preparare un questionario accurato e pedante per intervistarli: «Lei dove è cresciuto? Qual è la sua lingua materna? In quanti eravate in famiglia? Come si sono conosciuti i suoi genitori? C’era la televisione? Dove dormiva lei? Che cosa c’era da mangiare? Da bambino qual era il suo nascondiglio preferito?» e via e via. Gli africani non hanno idea di chi fosse Adolf Hitler, non sanno che fino a qualche anno prima Berlino era tagliata in due da un muro. Ma anche Richard, privilegiato bianco e tuttavia cittadino di serie B nella Germania riunificata perché ha vissuto gran parte dell’esistenza nella Ddr, sa ben poco del mondo. «Richard ha letto Foucault e Baudrillard e anche Hegel e Nietzsche. Ma che cosa si mangia quando non si hanno i soldi per comprarsi da mangiare, questo nemmeno lui lo sa».
Due mondi che si sfiorano, che cercano di conoscersi e ci riescono solo fino a un certo punto. L’accademico Richard che ribattezza gli africani con nomi mitologici o aulici – Apollo, Ermes, Tristano – per poi arrendersi ai loro veri nomi ed entrare sempre più nel loro mondo. Che regala maglioni e giacconi, offre lezioni di pianoforte, li aiuta nel disbrigo delle pratiche, quando li cacciano anche dall’ex scuola se ne porta in casa dodici e mobilita gli amici perché offrano alloggi. Fino a comprare un appezzamento di terra in Ghana per uno di loro. E i giovani e gli anziani che sognavano un’altra vita pronti a raccontare, per squarci dolorosi, le stragi di Boko Haram in Nigeria, la persecuzione dei tuareg in tutta la fascia subsahariana, le nefandezze dei libici.
Ho scoperto Jenny Erpenbeck grazie al critico anglo-americano James Wood, che loda la sua compostezza classica, il suo lavorare quasi attuariale per informazioni asciutte, tenendo a bada il lirismo ed evitando di servire ai lettori, anime belle di un Occidente sazio, una consolazione a buon mercato. Nata nel 1967 a Berlino Est da padre di origini russe e madre polacca, Erpenback possiede per Wood il nitore di Coetzee, Naipaul e Teju Cole, altro autore che mi andrò a recuperare (Einaudi ha appena publicato Tremore, ne parliamo il prossimo mese).
Ma anche la sua prosa sorvegliata si spezza, mentre la narrazione va a concludersi, in un urlo che occupa, ripetuto due volte, un’intera pagina: «Dove va un uomo, quando non sa dove andare?». Perché stiamo parlando di uomini. «Va forse ascritto a questi lunghi anni di pace il fatto che una nuova generazione di politici sembra credere nell’imminente fine della storia e nella possibilità di troncare con la violenza tutto quanto sfocia nel movimento? Oppure l’essere così lontani nello spazio dalle guerre degli altri ha provocato penuria di esperienza in coloro che non ne sono stati disturbati, così come altri soffrono di penuria di globuli rossi? La pace, che è sempre stata la massima aspirazione dll’uomo e che finora si è realizzata in così poche regioni del globo, ci impedisce dunque di farne oggetto di condivisione con coloro che da noi cercano rifugio e ci spinge a difenderla in modo così aggressivo da farla sembrare già quasi una guerra?». Un romanzo bello e importante.
Ernesto Ferrero, Italo, Einaudi, 2023
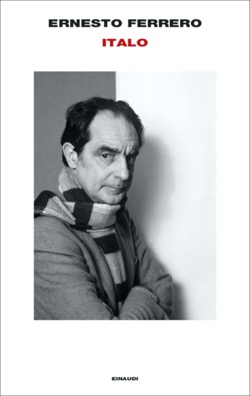
Nel centenario della nascita, il garbato Ernesto Ferrero licenzia una biografia dell’uomo e dello scrittore Calvino. Gli accadimenti biografici: la Liguria, il padre e la madre botanici; la guerra partigiana; la lunga milizia einaudiana e, fino agli anni ‘50, l’adesione al Pci; l’amicizia con Eugenio Scalfari; la storia con la diva Elsa De’ Giorgi e il matrimonio con Chichita Singer; il viaggio in America e l’innamoramento per Parigi; la nascita della figlia Giovanna; l’approdo a Roma e a Roccamare. E la biografia intellettuale, dal realismo quasi picaresco degli esordi alle “favole” illuministiche dei Nostri antenati, fino alla fascinazione strutturalista con innesti scientifici e fantascientifici e borgesiani che cristallizza e astrattizza la sua prosa della cosiddetta seconda fase, fino al pessimismo (quasi) radicale delle ultime opere. Assieme all’immensa mole di lavoro editoriale dedicato ai “libri degli altri“.
Ho amato tutto il Calvino fino ai primi anni ‘60 e qualcosa dell’estremo (Palomar, soprattutto Le città invisibili), meno i giochi di prestigio Se una notte d’inverno un viaggiatore e Il castello dei destini incrociati (mio limite e mea culpa, i tarocchi mi danno l’orticaria), per non dire che ho colpevolmente ignorato Le cosmicomiche e Ti con zero, e sarei ancora in tempo per fare ammenda. Non sono tuttavia certo che ci sia una cesura netta tra la prima e la seconda fase di Calvino. Nelle Fiabe italiane (1954-1956) che sto rileggendo a piccoli sorsi, una ogni tanto, in quelle riscritture della tradizione dove i prodigi convivono con re da pagliaio e odore di minestrone, Calvino mette già alla prova gli attrezzi dello scrivere (i doni fatati), chiedendosi se davvero funzionino, come usarli e come combinarli tra loro.
In una fiaba ligure Giuanin deve ritrovare la figlia del re rapita dal mago Corpo-senza-l’anima. Buon giudice tra un leone, un cane, un’aquila e una formica che devono spartirsi la carcassa di un asino morto, riceve da loro una grinfia di leone, un baffo di cane, una penna d’aquila e una gambina di formica. I doni lo renderanno all’occorrenza feroce quant’altri mai, veloce come nessuno, re dei cieli e minuscolo al punto di risultare invisibile. «Giuanin prese tutti i regali, disse grazie ai quattro animali, e partì. Alle virtù di quei regali non sapeva ancora se crederci o non crederci, perché poteva darsi che l’avessero preso in giro. Ma appena fu lontano dalla loro vista si fermò, e fece la prova. Diventò leone cane aquila formica e poi formica aquila cane leone e poi aquila formica leone cane e poi cane formica leone aquila e fu sicuro che funzionavano bene. Tutto contento riprese il cammino».
Calvino è narratore che saggia costantemente i suoi strumenti, da ultimo che li esibisce. È clamorosamente bravo, non è questo il problema, ma che cosa ne resta? E davvero questa abilità da “giocoliere leggero” fa di lui il maggior scrittore del nostro secondo Novecento? Lo applaudi, ma ti scalda il cuore? Non saprei, non ho risposte. A mio gusto tendo ad anteporgli Levi e Sciascia, Morante e Ginzburg, Fenoglio e Meneghello. Eppure, con Levi, Collodi e Dante (di recente con Elena Ferrante), è il nostro più pregiato articolo letterario da esportazione.
Copio qui, senza farne vangelo, alcune annotazioni di Alfonso Berardinelli, critico di scintillante intelligenza e libero dal gioco delle consorterie. Qualche rotella la fanno muovere.
«Inutile negarlo: Calvino alleggerisce, semplifica, riduce e schematizza il reale per poi lavorare a complicare intellettualisticamente gli schemi che ne ha ricavato, incrociandoli e incastrandoli. Mentalizza una complessità tenuta attentamente a bada, ne elabora un maneggevole doppio su cui operare pazientemente, con calma, a freddo e a distanza. È il Calvino che afferma senza mezzi termini, con una faziosità non meno bizzarra che fobica, che “dall’emotività non può nascere niente di buono, in nessun caso”. È vero che questa affermazione viene fatta in un articolo scritto negli anni del terrorismo (1976), ma Calvino esprime in quella frase una sua convinzione di sempre, molto radicata e non dovuta a una situazione contingente. Questo scrittore che crede di dover lavorare solo dopo aver messo a tacere le emozioni esibisce immancabilmente il suo sorriso di finto bambino che non si allarma e non ha paura (i veri bambini, però, sono emotivi, si allarmano, hanno paura: il “fanciullesco” calviniano è invece la ben costruita maschera di un adulto che si protegge dentro una lucente corazza ludica e moralistica).
Così Calvino non mostra il suo volto e le sue paure “naturali”, fa buffe smorfie apotropaiche, mette alla sua voce la maschera del falsetto (come hanno osservato la Ginzburg e Garboli). E raramente esprime in pubblico il suo vero pensiero, i suoi giudizi negativi, le sue preoccupazioni, il suo pessimismo crescente. Naturalmente nelle sue opere tutto questo c’è: ma bisogna cercare bene, nelle pieghe. Calvino, oltre che intelligentissimo, era anche furbo. E come tutti i furbi non si scopriva».
Ho tratto la lunga citazione da Un secolo dentro l’altro (il Saggiatore, 2022), che tengo sempre a portata di mano e di lettura assieme all’altro suo Giornalismo culturale (il Saggiatore, 2021) e al Diario del Novecento (il Saggiatore, 2022) di Piergiorgio Bellocchio, un gioiello da scoprire.
Mauro Lucentini, Il Genio familiare. Vita di Franco Lucentini scritta da suo fratello, Marlin, 2006

Nessun uomo è un genio per il proprio cameriere, diceva Hegel. Franco Lucentini non aveva camerieri ed era un genio per suo fratello Mauro, che scrive la sua (la loro) vita con qualche affettuosa esagerazione. Romano diventato torinese e francese (1920-2002), figlio di un fornaio indulgente e di una madre sollecita che insegnava il francese ai figli, è giovane promettente e fuori dai binari, precoce antifascista individualista che, per un lancio di stelle filanti con impressi slogan contro il regime, finisce a Regina Coeli. Inquadrato poi nei ranghi del Pwb americano (il suo capo è Renato Mieli), affascinato dall’Unico di Max Stirner, redattore e fondatore dell’Ansa, tentato suicida, expat a Praga (ne ricava il bellissimo I compagni sconosciuti che per Einaudi inaugura la collana “I gettoni” di Elio Vittorini) e a Parigi dove “legge” per Einaudi e per Plon. Negli anni ‘50 l’approdo a Torino e all’Einaudi dove traduce Beckett, Borges, Robbe-Grillet e altri e, in sodalizio con Carlo Fruttero, allestisce alcune bellissime antologie (Le meraviglie del possibile sulla fantascienza, Storie di fantasmi e altro) che il fratello, sopravvalutandone l’impatto, giura abbiano salvato il divo Giulio dal fallimento.
Poi la carriera da battitori liberi, direttori di Urania (ma la fantascienza in Italia non l’hanno portata loro), bestselleristi di qualità molto amati (anche da me), elzeviristi della Stampa. Anticomunisti i due, vero (ricordo Fruttero che, a margine di una mia intervista, mi chiese come facevo a essere di sinistra visto che gli sembravo intelligente), Franco neoliberista convinto che il welfare fosse la catastrofe, ma in buona sostanza estranei alla politica e ai suoi umori. E grandi sapienti prestati al pop dell’industria culturale.
Nel testo di Mauro Lucentini, conservatore dichiarato, ci sono molte glorificazioni del fratello che si leggono con intenerita indulgenza (il pensatore Franco che avrebbe anticipato in qualche modo le teorie sul big bang e la fisica quantistica) e qualche notazione interessante ma presumibilmente inesatta: per esempio i testi di Fanfani sul corporativismo che avrebbero influenzato Roosevelt : ma il primo New Deal è del 1933-34, e se le fascinazioni angloamericane per la “terza via” fascista ci furono, le teorizzazioni di Amintore sono tuttavia del 1937; Fanfani influenzò invece il giovane John Kennedy.. Per un ritratto altrettanto affettuoso di Lucentini, e forse più a fuoco, sarà bene riandare alle memorie di Carlo Fruttero, Mutandine di chiffon.
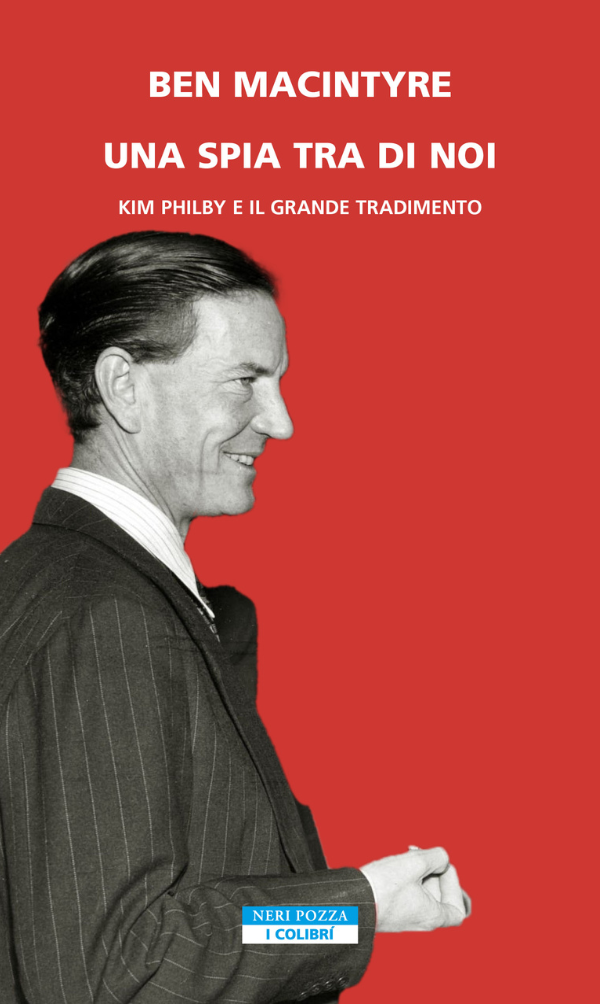
Kim Philby, 1912-1988, per trent’anni ai vertici dell’intelligence inglese e, fin dai tempi di Cambridge, spia dell’Unione Sovietica all’insaputa dei suoi. Insolita spia o forse quintessenza dell’agente segreto. Per fedeltà al comunismo, ma non una parola trapela, neppure dopo la fuga a Mosca, sulle convinzioni che lo spinsero a tradire. E, nella sua vita ufficiale, inglese fino al midollo, impregnato delle convenzioni e dei tic dell’alta borghesia a cui appartiene: il cricket, i club esclusivi, il bere forsennato che è cifra distintiva dello “small circle of friends” delle spie. Reclutato durante la guerra di Spagna, attivo fino al 1963, Philby riesce a scampare negli anni ‘50 ai sospetti che si addensano sul suo capo e per qualche anno lo vedono sospeso dall’MI6 – ma viene scagionato dal premier conservatore Harold Macmillan – per essere infine smascherato a Beirut. Gli inglesi, sospetta MacIntyre, gli permettono di scappare a Mosca senza bloccarlo perché lo scandalo di un processo a Londra sarebbe stato insostenibile. A Mosca, utilizzato come istruttore di spie e strumento di propaganda, fa vita grigia da alcolizzato e muore d’infarto.
Il traditore Philby, durante la seconda guerra mondiale autorevole addestratore delle spie americane che muovono i primi passi (l’Oss è appena stato creato, la Cia arriverà alla fine degli anni ‘40), infligge danni seri alla rete spionistica occidentale oltrecortina, mandando al macello centinaia di informatori. Una biografia che si legge come un romanzo di spionaggio, lo studio acuto di una personalità quasi schizofrenica e, non ultimo dei pregi, il resoconto del passaggio di consegne, nella leadership globale, dall’aristocratico e svagato approccio inglese alle più ruvide mani americane.
Spie dell’età eroica, buone a venire romanzate e assai facili a essere infiltrate, con la convinzione assoluta e stolida che agenti e ufficiali, figli dell’upper class educati a Cambridge, Oxford ed Eton, fossero al di sopra di ogni sospetto. C’è un passaggio del libro che mette in scena questo senso di superiorità che niente e nessuno riesce a scalfire. Ne è protagonista Nicholas Elliott, l’amico più intimo di Philby in seno all’MI6 e in seguito il suo accusatore più implacabile. Interrogato dal responsabile della sicurezza per capire chi fosse al corrente della sua attività, dà risposte che lette oggi suonano incredibili.
«Agente della sicurezza: Si sieda. Vorrei parlarle schiettamente.Nicholas Elliott: Come desidera, colonnello.
Agente: Sua moglie sa che cosa fa?
Elliott: Sì.
Agente: Come l’ha saputo?
Elliott: È stata la mia segretaria per due anni, e credo che lo abbia intuito.
Agente: È molto probabile. E sua madre?
Elliott: È convinta che lavori in una certa agenzia chiamata Sis, che crede sia l’acronimo di Secret Intelligence Service.
Agente: Santo cielo! E come ha fatto a scoprirlo?
Elliott: Glielo ha detto un membro del Gabinetto di guerra durante un cocktail party.
Agente: E suo padre, invece?
Elliott: Sospetta che io sia una spia.
Agente: Perché dovrebbe pensare una cosa simile?
Elliott: Perché glielo ha detto il Capo al bar del White’s Club».
Ecco. Un servizio di intelligence a maglie larghe, di cui fanno parte tre quarti dei letterati inglesi e dei cattedratici del ‘900, lingue svelte: Graham Greene è nome che ricorre spesso, non è l’unico.
Brevi ma interessanti gli accenni all’Italia. In particolare a monsignor Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Giovanni XXIII che, nunzio apostolico a Istanbul e convinto antifascista, si rivela fonte di preziose informazioni carpite ai tedeschi.
Curiosa la storia, che meriterebbe più distesa narrazione, dell’imbroglione Virgilio Scattolini. Ugo Zatterin ne ha lasciato un ritratto impietoso: «La polizia lo conobbe giovanissimo come istigatore di reato, come austriacante, infine come pornografo. Fece l’ateo, l’anticristo, lo scrittore di avanguardia, il libellista. Finì a Piazza San Sepolcro, si aggregò a Carli e Settimelli, entrò nel grande giornalismo accodandosi al carro mussoliniano dell’impero».
Qui lo ritroviamo a vendere bufale a James Angleton, capo delle spie americane: «Un corpulento giornalista che scriveva romanzi semipornografici di successo, fra cui uno dal titolo tutt’altro che invitante Amazzoni del bidet. Questo secondo lavoro non gli impedì di ottenere un incarico nella redazione dell’Osservatore Romano. Nel 1944 si offrì di consegnare all’Oss di Roma i documenti diplomatici e le comunicazioni telegrafiche del Vaticano, incluse le copie dei rapporti inviati dal nunzio apostolico a Tokyo, il quale aveva un contatto diretto con alti funzionari giapponesi. Angleton corrispondeva a Scattolini la cospicua somma di cinquecento dollari al mese. I suoi rapporti venivano immediatamente inoltrati a Roosevelt ed erano considerati così riservati che solo il presidente o il segretario di stato potevano autorizzarne l’accesso. Tuttavia, Angleton cominciò a nutrire sospetti quando emerse che Scattolini stava vendendo materiale simile ad altre agenzie di intelligence, tra cui l’MI6. La svolta decisiva avvenne quando l’italiano riferì una conversazione tra l’emissario giapponese presso la Santa Sede e la sua controparte americana, conversazione che, come scoprì il Dipartimento di stato, non aveva mai avuto luogo. Scattolini stava inventando tutto, e continuò a farlo anche dopo essere stato licenziato da Angleton. Nel 1948 finì in prigione per aver fabbricato due volumi spacciandoli per “documenti segreti della diplomazia vaticana”».
Enrico Pea, Moscardino/ Il Volto Santo/ Il servitore del diavolo, Einaudi, 1979
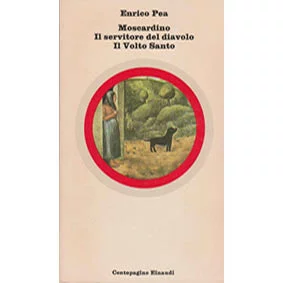
«Avevo sempre avuto delle allucinazioni, o meglio, le cose sognate spesso mi eran apparse vere, ed ero stato anche sonnambulo da ragazzo. Io davo la colpa alle paure che avevo preso, ai tuffi di sangue, e alla vita randagia, in continue diffidenze, e sempre solo, in ragionamenti con me stesso, rimuginando le cose udite, le più disparate, dalle parole della predica in chiesa alle dispute di piazza».
Curiosa, affascinante trilogia in miniatura questa del versiliese Enrico Pea (Seravezza 1881-Viareggio 1958) che fu bohèmien ad Alessandria d’Egitto agli inizi del ‘900 e frequentatore della “Baracca Rossa”, deposito di marmi apuani e di falso Chianti e raduno di liberi pensatori e raminghi e scontenti e ribelli d’ogni latitudine, dove lo scoperse Ungaretti. E poi fondatore di teatri, romanziere, poeta, drammaturgo e altro. Con un’aria arruffata, anarchizzante, con il candore di chi sta altrove, foto barbute da padre della patria garibaldino.
«Grazie, mio buon Dio, di avermi negata una piccola patria: di avere offerto al mio amore un mondo senza termini, su cui siamo tutti fratelli: di avermi posto nel sangue la polvere del nomade, e di avermi dato luce a discernere le cose terrene come provvisorie».
Apparso nel 1922 e autobiografico, tanto o poco non saprei dire, Moscardino che piacque molto a Ezra Pound – e il successivo Il Volto Santo del 1924, il Volto Santo è un crocifisso dell’VIII secolo venerato a Lucca, meta di pellegrinaggio e oggetto di leggende – è la storia detta in prima persona, dall’io narrante meno ingombrante in cui mi sia accaduto d’imbattermi, d’un bambino cresciuto da un nonno che è stato combattente contro gli austriaci (di uno morto ha preso il posto nella bara, per poter dormire in santa pace) e, per venticinque anni, ospite del locale manicomio dove lo hanno rinchiuso peché ha tentato di sventrarsi dopo acuta crisi di gelosia per la moglie Cleofe, servetta di altera bellezza che morirà di tisi.
Una casa di matti, quella che rievoca Moscardino: borghesia di campagna e di roba, decaduta e inaridita, con una donna all’origine della schiatta, la signora Pellegrina che si mura viva nella stanza da letto, vestita di nero e di seta, e smette di parlare dopo la morte del marito. E i fratelli del nonno anch’essi lunatici e inquieti, mattoidi, il Taciturno che s’impiccherà e l’Abate che veste la tonaca ma non è mai stato ordinato. Un mondo di preti tabacconi e liberali, contadini litigiosi e paesani fuori di senno, un’atmosfera che prende le mosse dal crudele bozzetto toscano dell’800 per aprirsi alla meraviglia negandosi all’idillio – un mondo di “polenta e aceto” – e virando sul visionario, quasi in un presagio del realismo magico sudamericano e di Cent’anni di solitudine. Un mondo che trasforma gli accidenti delle stagioni in pestilenze e carestie, che indaga le tare del sangue e offre la prima concreta narrazione della follia e del manicomio con mezzo secolo di anticipo sul conterraneo Mario Tobino. Un lessico tramato da un vernacolo prodigioso: bastré, bottaccio, bretto, dolco, inciprignirsi, macubino, orbaco, puppera, (a) spracchetta, uguanno e cento altre parole. E una punteggiatura estrosa che spesso conclude le frasi con due punti, anche qui con largo anticipo sul verseggiare di Edoardo Sanguineti.
È del 1929 l’atto conclusivo della trilogia, Il servitore del diavolo. Ci si sposta ad Alessandria d’Egitto: Pea vi risiedette facendo la spola con la Toscana e commerciando in marmo ed olio. Tra mollezze levantine, profumo languido di gelsomino e zaffate sulfuree di libero pensiero (e libero amore, teorizzato dall’ebrea Rachael fuggita di Russia), servi d’Africa poco più che schiavi (Barberino e la Sudanese), amori giovani e incantati (il greco Percas e Rebecca) o torbidi come in Lucchesia (il Maltese e la Goriziana), elogi dell’anarchia e di “né Dio né padrone”.
Il Diavolo di cui l’io narrante Moscardino è servitore corre in Russia per vedere come procede la rivoluzione, che ne è delle navi che sul Baltico hanno issato bandiera scarlatta (manca poco che voli sopra Mosca come il Woland di Bulgakov), mentre il capo dei servi Giuda, forse doppelganger del Diavolo e vero padrone, maestro di blasfemia e ribellione, regge le sorti della casa. Preda di rancori e gelosie, l’io narrante lascia il servizio e finirà per ribellarsi anche nella fonderia dove ha trovato impiego da operaio. «A quanti anni di questa pena sono stato condannato? E perché sono stato condannato così senza pietà? Mi adatterò anch’io, come tutti gli altri, che sono contenti e mangiano il loro pane intorno all’aguzzino, e ridono, senza accorgersi nemmeno della carcere che li tiene schiavi?».
Opera insolita nella letteratura di quegli anni, acre ed erratica, stupisce che il fascismo ne abbia consentito la pubblicazione. Avevo letto per la prima volta Moscardino in un’edizione Garzanti dei primi anni ‘60 curata da Attilio Bertolucci, l’ho ritrovato in una libreria dell’usato nella bella collana “Centopagine” diretta da Italo Calvino; chi vuole accostarlo oggi lo trova nelle edizioni Elliot ed Ets. Singolare calamita è Alessandria d’Egitto: crocevia di destini e di sorti letterarie (Kavafis, Forster, Durrell), colonia artistica anche italiana: Pea e Ungaretti, in quello scorcio di ‘900 anche Marinetti, in seguito Fausta Cialente con Cortile a Cleopatra, in anni più recenti Alessandra Lavagnino con Le bibliotecarie di Alessandria.
Georges Simenon, La collera di Maigret, trad. Giannetto Bongiovanni, Mondadori, 1959

Scritto nel 1945, appena terminata la seconda guerra mondiale, un Maigret potente e cupo, che ignora il conflitto ma lo incorpora tra le righe in una vicenda familiare con movenze quasi da tragedia greca.
Maigret è in pensione, ha lasciato Parigi per Meung-sur-Loire e si occupa dell’orto, combatte la sua battaglia contro le dorifore che infestano le melanzane. Nella controra di un agosto torrido gli piomba in casa un’ottuagenaria abituata a spiccare ordini, che lo tratta come un domestico e lo ingaggia perché indaghi sulle malefatte del genero, che sospetta di avere ucciso la nipote prediletta.
Maigret accetta. Per noia forse, per rimpianto delle indagini senz’altro. E si ritrova a Orsenne, sobborgo per ricchi sulle rive della Senna. Tra ville sontuose, barche, auto di lusso, rituali sfarzosi. È in un mondo non suo, forse a disagio, ma è massiccio come un muraglione che niente smuove, di un’apparente opacità che tutto assorbe.
La vecchia signora, Bernadette Amorelle, è la vedova di un proprietario di cave di sabbia e ghiaia, di chiatte, di una società di navigazione e di molto altro. I generi, Ernest e Charles Malik, hanno sposato le sue due figlie, figure pallide e prive di volontà. E sono diventati, Ernest soprattutto, i padroni del vapore.
Ernest Malik è una vecchia conoscenza di Maigret: è stato suo compagno di scuola alle superiori, era il figlio dell’esattore e tutti lo deridevano. Oggi è un uomo elegante ed energico, sprigiona sicurezza e potere, tratta Maigret con un misto di condiscendenza e disprezzo, ma ne teme la presenza.
Perché ha qualcosa da nascondere, non l’uccisione della giovane nipote Monita, ma un segreto torbido e inconfessabile. Fuori posto ma solidamente implacabile, Maigret metterà a nudo il nuovo ricco, ricostruendone il passato di prevaricazioni e inganni. All’ombra di ogni ricchezza c’è un delitto, in seno a ogni famiglia si nasconde un mostro. Ci sarà chi, come la ragazza Monita, deciderà di non voler più vivere dopo averlo scoperto. E chi, come la vecchia Bernadette, deciderà di liberarsi del mostro. Un’inchiesta anomala, che riporta Maigret per qualche giorno al Quai des Orfevres. Tra i comprimari, un’albergatrice alcolizzata di kummel, un vecchio acrobata del circo, un adolescente in fuga. Niente calvados, si beve vino bianco e grappa.
Ho riletto questo Maigret in una vecchia edizione – Il Girasole, Biblioteca Economica Mondadori – trovata nei vagabondaggi per bancarelle. Per nostalgia delle mie letture da ragazzo, mi porto spesso a casa libri che allora mi passavano per le mani, quasi sempre di seconda mano, e che rivendevo per acquistarne altri: i narratori Feltrinelli con la bellissima copertina grafica di solo titolo e autore disegnata da Bob Noorda, i Coralli Einaudi con il dorso telato, le plaquette della Fussi con la copertina color melanzana, le copertine verdi della Medusa diretta da Elio Vittorini e della Biblioteca Romantica Mondadori diretta da Giuseppe Antonio Borgese.
Per farsi una biblioteca – la mia è diventata mediamente cospicua, oltre diecimila volumi nonostante gli sfoltimenti periodici – venire da una famiglia che non aveva libri in casa è una molla forse più potente che discendere da una famiglia di studiosi. Di questa indagine andrà tuttavia preferita l’edizione Adelphi – La furia di Maigret, traduzione di Margherita Belardetti – non soltanto perché è tuttora in commercio, ma soprattutto perché è nettamente superiore.
Confrontiamo gli incipit. «La signora Maigret, che sbucciava piselli in una zona di ombra calda – il blu del grembiule e il verde delle bucce creavano forti macchie di colore – la signora Maigret – le cui mani non erano mai oziose, fossero le due del pomeriggio nella più calda giornata d’un agosto massacrante – la signora Maigret, che sorvegliava il marito come un bambino, si inquietò: “Scommetto che ti alzi già!”» fa quella Mondadori. «La signora Maigret, che sgranava i piselli nell’ombra calda, dove l’azzurro del suo grembiule e il verde dei baccelli creavano chiazze sontuose, la signora Maigret, che non stava mai con le mani in mano, fosse pure alle due del pomeriggio della giornata più calda di un agosto già torrido, la signora Maigret, che sorvegliava il marito come si fa con un neonato, sbottò: “Scommetto che stai già per alzarti…”». Non c’è partita.