Per tutti i gusti la rubrica di gennaio: dagli intrighi di stato alle profondità marine con un classico di Verne, dalla segnalazione di un autore colto e molto amato a piccoli tesori pescati sulle bancarelle fino all’interessante rassegna di libri su ciò che mangiamo e su come veniamo spinti a mangiare
Giorgio Boatti, Inganno di Stato, Einaudi, 2024

Nel tardo pomeriggio del 22 ottobre 1943, a Roma, Claudio Pavone è inquieto. Ha 23 anni, è un ufficiale di complemento tornato nella capitale in licenza in seguito alla morte del padre. Attivo nel partito socialista clandestino con Eugenio Colorni che nel 1944 verrà ucciso dai fascisti della banda Koch, porta in una borsa nera da avvocato, assieme a un libro di Benedetto Croce e ai Salmi, copie dell’Avanti e volantini che incitano alla rivolta. Sta per scattare il coprifuoco, Pavone capisce che deve sbarazzarsi di quel materiale compromettente ma non vuole «buttarlo via a vanvera», così lo fa scivolare all’interno di una macchina nera che ha un finestrino semiabbassato. Si è allontanato di pochi passi quando due braccia lo afferrano e due agenti in borghese lo riportano davanti all’auto. È quella di Guido Leto, vicecapo della polizia repubblichina. Rievoca Pavone: «Il commendatore uscì subito dal portone e i due poliziotti si vantarono: “Ne abbiamo preso uno”. Leto disse: “Portatelo al commissariato”, e rivolto a quello dei due poliziotti cui mi affidò: “Se cerca di scappare sparagli”. E il poliziotto: “Commendatore, non vi preoccupate, ho già il colpo in canna…”».
I due protagonisti di Inganno di Stato entrano in scena subito. Uno, Claudio Pavone “maestro di rigore storiografico, testimone di impegno civile” al quale il libro di Boatti, il suo ventiduesimo, è dedicato – di Pavone è il fondamentale Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza del 1991, che rivoluzionò la storiografia sul 1943-1945 – è il nume tutelare di questa immersione negli “Intrighi e tradimenti della polizia politica tra fascismo e Repubblica”, come recita il sottotitolo. L’altro, il palermitano Guido Leto, entrato in polizia sotto Giolitti per scalarne i vertici sotto Mussolini, è per Boatti la «sintesi emblematica dell’arte di sorvegliare il dissenso e imbrigliare l’opposizione al potere, dispiegando sulla scacchiera della repressione poliziesca tutti gli strumenti dell’indagine e dell’infiltrazione, della provocazione e del doppiogioco».
La continuità dello Stato e dei suoi apparati è la vera protagonista di questa ricognizione minuziosa – vanno lette anche le note: durante la repubblica di Salò agivano ben 77 polizie speciali come documenta l’Archivio Centrale dello Stato, non lo sapevo – che, sulla scorta di un approccio comparatistico, rintraccia le analogie e le pratiche costanti di depistaggio tra le peggiori trame della nostra storia nazionale.
Esemplare è in questo senso la strage del 12 aprile 1928. Quel giorno Vittorio Emanuele III è a Milano per inaugurare la Fiera Campionaria. Lo manca per pochi minuti una bomba che fa 20 morti e 50 feriti. L’hanno messa quasi certamente gli elementi più estremisti del fascio milanese, per propiziare un “golpe repubblicano” che, eliminato il re, avrebbe fatto proclamare Mussolini capo dello Stato. Ne è convinto il commissario Carmelo Camilleri, zio dello scrittore Andrea, ma viene cacciato dalla polizia e condannato a cinque anni di confino. Sarà allontanato da Padova e trasferito a Ruvo di Puglia, nel 1970, anche il commissario Pasquale Juliano che ha individuato nei neonazisti Franco Freda e Giovanni Ventura gli autori della strage di piazza Fontana, mentre il questore di Milano Marcello Guida, già capo del carcere di Ventotene in cui durante il ventennio erano rinchiusi gli antifascisti, indirizza le indagini verso gli anarchici.
La bomba della Fiera si tenta invece di appiopparla prima ai comunisti e poi a Giustizia e Libertà. Invano, l’accusa non regge e uno dei capri espiatori designati, Umberto Ceva, innocente sopraffatto dalla mostruosità delle accuse, si uccide in carcere. Nel 1943 Guido Leto, capo dell’Ovra, torna a costruire false prove contro Riccardo Bauer, futuro presidente della Società Umanitaria, e contro Ernesto Rossi futuro fustigatore della corruzione e del malcostume democristiano, che hanno già scontato dodici anni fra galera e confino, e li fa tradurre da Ventotene a Regina Coeli. Si torna a rimestare nel fango: sono loro gli autori della strage del 1928, non potranno fare parte di un futuro governo antifascista che il “servitore dello Stato” Leto cerca di condizionare a priori. Il piano fallisce.
Restano intatti però i «confini scivolosi che passano tra segreti e ricatti. Il ricatto: ovvero il patto omertoso con cui, chi i segreti li conosce e li fabbrica, li governa e li tesaurizza, incatena a sé chi del segreto è vittima». Perché «spiare è narrare. Narrare è spiare. È paradossale come un’attività che ruota attorno al segreto, come l’investigazione e lo spionaggio politico, si affratelli talvolta, in chi la pratica, a un’impellente vocazione all’affabulazione, a una bulimica tensione verso la narrazione, a un deciso ricorso alla scrittura incaricata di restituire la realtà virtuale e sperimentale con nuovo e alternativo sguardo. Spesso lo fa per riproporla ex novo, con tratti verosimili ma raramente veritieri, perché finalizzati e piegati a un preciso obiettivo da raggiungere».
Stato nello Stato, la polizia segreta – l’Ovra, che Mussolini “inventa” nel 1927 e che starebbe per Opera di Vigilanza e Repressione Antifascismo, in realtà preesisteva e riverserà dirigenti e modus operandi nella Repubblica – esegue e spesso anticipa le peggiori pulsioni dei governi, ne accentua o ne mitiga la crudeltà – sotto il fascismo, botte e sevizie per gli oppositori contadini e operai, una repressione più felpata e non esente da benevolenza nei confronti dei borghesi che hanno tralignato: è il caso di Rosario Bentivegna, futuro gappista di via Rasella, la cui famiglia è in amicizia con i Leto –, con una discrezionalità che usa la costruzione di prove false e falsi colpevoli, il dossieraggio, l’infiltrazione, il tradimento smaccato o l’occhio di riguardo, il doppio gioco anche con gli oppositori che “potrebbero essere i futuri ministri” oppure nemici da mettere fuori gioco.
Sfilano, nel libro di Boatti, traditori perfetti come Carlo Del Re, commercialista che negli anni ‘30 si vende gli amici milanesi di Giustizia e Libertà perché il fascismo ha promesso di ripianargli gli ammanchi di cassa: riuscirà a scucire al regime 400mila lire di allora, quando un operaio guadagna 250 lire al mese. Doppiochisti come Ugo Osteria, che nel convulso trapasso di poteri da poliziotto di Salò si accredita presso Ferruccio Parri sottraendolo alle grinfie dei nazisti. Infiltrati senza scrupoli come Ermanno Menapace, attendente di Costanzo Ciano che si insinua tra i fuoriusciti a Parigi per screditarli con un pamphlet che ne mette in piazza la vita povera e anche i lati quotidiani meno edificanti. Gaetano Salvemini lo ritroverà, nel dopoguerra, tra i funzionari del Viminale e avrà nei suoi confronti parole di fuoco: “Che meraviglia, se un antifascista che capiti in quel covo agli Interni troverà subito che la vita è difficile, mentre per i camerati di Ermanno Menapace, lì ogni pratica viene sbrigata favorevolmente, in quattro e quattr’otto”.
Come Camilleri e Juliano, poliziotti “non conformi” ed esuberanti come Giovanni Dosi vengono trasferiti e perseguitati. Dosi non crede che il povero Gino Girolimoni, additato dalla polizia come il “mostro di Roma” che ha ucciso sette bambine tra il 1924 e il 1927, sia colpevole e indaga su un pastore anglicano: ma non si può, si rischia l’incidente diplomatico con Londra. Così, viene trasferito in Abruzzo e, quando si ribella dando alle stampe un atto d’accusa contro il capo della polizia Arturo Bocchini, il libro viene sequestrato e l’autore viene cacciato dalla polizia e internato in manicomio.
Guido Leto non corre di questi rischi. Arriva a dirigere l’Ovra, si schiera con Salò avendo l’accortezza di trasferire al nord l’imponente archivio della polizia segreta, facendone l’arma di scambio per traghettarsi, sfuggendo all’epurazione, nella polizia della Repubblica: ne guiderà le scuole di formazione fino al 1951 quando, in pensione, andrà a dirigere i Jolly Hotel dei Marzotto. L’archivio intanto è stato riportato a Roma – e molti oppositori dossierati dal regime hanno potuto ripulire i loro fascicoli da notizie indiscrete o disdicevoli – da un giovane funzionario, Federico Umberto D’Amato, destinato a diventare il direttore dell’Ufficio Affari Riservati del Viminale. Il regista occulto del depistaggio su Piazza Fontana e della protezione accordata ai neonazisti, uno dei finanziatori della strage alla stazione di Bologna nel 1980. Quando si dice la continuità dello Stato…
Saggio appassionato e scrupoloso, sottotraccia autobiografia intellettuale che chiude il trittico cominciato con Piazza Fontana e con Preferirei di no, la storia dei dodici professori universitari che rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo, Intrigo di Stato è un’alta testimonianza del dovere morale di narrare e cercare la verità nascosta. Un atto di impegno civico come quello del suo maestro Claudio Pavone, del quale essere grati.
George Eliot, Il mulino sulla Floss, traduzione di Giacomo Debenedetti, Mondadori, 1940

Conversando con un amico sulle «tre parole che così spesso son state usate quali squilli di tromba ispiratori degli uomini», le tre parole Dio, immortalità, dovere, George Eliot «dichiarò, con terribile gravità, quanto fosse incomprensibile la prima, incredibile la seconda eppure quanto perentoria e assoluta la terza». L’aneddoto, che ricavo da David Daiches, rende perfettamente l’idea di quella puritana senza religione che fu George Eliot (1819-1880), nata Mary Ann Evans. Grande donna, grande romanziera. Cresciuta in una famiglia della proprietà terriera, educata secondo la severa precettistica evangelica in buoni college di provincia, padrona di casa e amministratrice del patrimonio familiare già a sedici anni, quando fratelli e sorelle si erano sposati e lei era rimasta sola accanto al padre.
Intanto aveva studiato greco e latino, tedesco e italiano. Intanto, un soggiorno a Coventry l’aveva messa in contatto con la critica razionalistica della religione: la Vita di Gesù di Strauss, che avrebbe tradotto, per poi cimentarsi con Spinoza e con L’essenza del Cristianesimo di Feuerbach («L’essere divino non è altro che l’essere umano, o piuttosto la natura umana purificata, liberata dai limiti individuali, resa obiettiva – cioè contemplata e venerata come un essere altro e distinto»). E la sua abiura aveva suscitato la ripulsa del padre, che morendo le aveva assegnato soltanto una modesta rendita.
Approdata a Londra, traduttrice e saggista, segretaria di redazione della radicale e positivistica Westminster Review, si legò al poligrafo George Henry Lewes, che si occupava di critica letteraria e teatrale nonché di filosofia e, in seguito, si sarebbe dedicato anche alle scienze naturali e alla fisiologia. C’era però un problema: Lewes era già sposato e padre di tre figli, sua moglie aveva avuto altri figli uno dei quali Lewes aveva riconosciuto benché non fosse suo, diventando così secondo la legge inglese complice dell’adulterio di lei e quindi impossibilitato a chiedere il divorzio. Il problema venne superato con la convivenza, che durò per ventidue anni, fino alla morte di lui, e che Eliot considerò sempre come un matrimonio di fatto, regolato da una mutualità e da una fedeltà forse ancora più forti che nei matrimoni regolari.
La loro scandalosa unione, che soltanto negli ultimi anni diventò quasi motivo di orgoglio per gli inglesi (la scrittrice, divenuta anche maestra di etica, ricevette la visita di Luisa, figlia della regina Vittoria), costò a George Eliot il ripudio da parte della sua famiglia, la rottura con tutta la cerchia delle amicizie e un duraturo ostracismo sociale. Che lei sopportò con stoicismo e perenni emicranie, e da cui evitò di venire schiantata, quando decise di diventare romanziera, scegliendo uno pseudonimo maschile (glielo trovò, a quanto raccontano le biografie, lo stesso Lewes). A quarant’anni, dopo il buon successo di critica dell’esordio anonimo, Scene di vita clericale (si fecero le congetture più fantasiose sull’identità dell’autore, soltanto Dickens indovinò che si trattasse di una donna), e il clamoroso successo, popolare e di critica insieme, di Adam Bede, stese di getto in circa sei mesi Il mulino sulla Floss, che assieme a Middlemarch del 1871 è considerato il suo capolavoro.
Che cosa racconta? La storia di una famiglia e della sua rovina. Quella dell’onesto e litigioso mugnaio Tulliver, che una causa sconsiderata riduce in miseria. Il suo mulino passa all’avvocato Wakem, da lui sempre ingiuriato, che per mortificarlo lo tiene nella vecchia proprietà alle sue dipendenze. Quella della debole e un po’ sciocca moglie Bessy, che mentre il marito e la famiglia vanno in rovina piange amare lacrime sul vasellame pignorato dai creditori.
Soprattutto Il mulino sulla Foss racconta dei loro due figli, Maggie e Tom, legati da un profondo affetto ma divisi da caratteri inconciliabili. Perché, se Maggie è tutta impulsività e immaginazione e non sopporta briglie, Tom è tutto concretezza e automatismo, senso del dovere e mancanza di fantasia. Gli scontri fra loro fin dall’infanzia sono costanti, ed è sempre Tom a prevalere e a punire Maggie.
La ragazza si lega a Philip Wakem, sensibile e deforme figlio dell’avvocato che ha causato la rovina del padre: è soltanto tenerezza e compassione, lei crede che sia amore. A troncare quel legame interviene Tom, che ha giurato al padre (il giuramento è stato trascritto sulla Bibbia di famiglia) di vendicarlo. E Maggie accetta di non vederlo più, per senso del dovere e per fedeltà alla famiglia.
Qualche anno dopo, tornata in casa dopo un periodo trascorso a fare l’istitutrice (quante istitutrici nei romanzi vittoriani), Maggie viene corteggiata da Stephen Guest, fidanzato della cugina Lucy. Benché innamorata di lui lo respinge, ma durante una gita in barca il giovane le chiede di sposarla e di fuggire insieme. Dopo una notte di stordimento Maggie torna a dire di no e chiede di essere sbarcata. Non è successo niente ma è come se fosse successo tutto: Tom, inesorabile, la considera disonorata e la scaccia.
Maggie si rifugia nella casa di un amico d’infanzia, respinge per l’ultima volta la proposta di matrimonio di Stephen, riceve una tenerissima lettera d’amore di Philip Wakem e si prepara a una vita di solitudine. Intanto la Floss in piena rompe gli argini e travolge ogni cosa. Maggie è tra le prime ad accorgersi del pericolo, salva gli amici che la ospitano e, su una barca, corre verso il vecchio mulino che Tom è riuscito a riscattare, per salvarlo. Lo prende a bordo ma i due fratelli, travolti da mucchi di legname, moriranno abbracciati.
I riassunti inevitabilmente semplificano. Pieno di slanci lirici e di concretezza (è uno dei primi romanzi inglesi a descrivere con proprietà i lavori e la quotidianità minuta), di interni domestici e di personaggi da elegia, di humour e di tragedia, di descrizioni e riflessioni, Il mulino sulla Floss è insieme romanzo psicologico e romanzo morale.
La trepida, indimenticabile Maggie Tulliver è uno dei primi personaggi femminili di cui venga scandagliata con acume e tenerezza, penetrazione e rispetto, l’interiorità: le eroine di Henry James prendono le mosse da qui. Come Proust prenderà le mosse dalle meditazioni della Eliot sui primi anni: «Amare pene dell’infanzia, quando la pena è ancor tutta nuova e ignota, quando la speranza ancora non ha trovato le ali per volare di là dai giorni e dalle settimane, e il tempo dall’una all’altra estate pare smisurato!».
George Eliot è una narratrice equanime e compassionevole: il personaggio di Tom fa prudere le mani al lettore ma l’autrice lo giustifica. Questa equanimità, tuttavia, non è equidistanza: Maggie è una donna di caratura morale superiore, di profonda generosità e onestà intellettuale. Non c’è niente di meschino in lei, glielo riconoscerà proprio la cugina abbandonata, a suo vantaggio, dal fidanzato, la mite e affettuosa Lucy: «Sei la migliore di tutti noi». Non c’è morale nel libro, almeno nel senso del sermone, della lezioncina, e sbaglia un anglista insigne come Mario Praz a ritenere che George Eliot voglia mostrare «i pericoli che nella pratica e nelle complicazioni della vita, ci posson venire dalle qualità più brillanti dello spirito quando non sian frenate da un retto e sicuro senso dei limiti e dal rispetto per le forme e anche pei pregiudizi consacrati dalla consuetudine».
O meglio, se morale c’è consiste nel mostrare quando difficile sia «il dovere a perseguire la felicità» quando i piombi e le zavorre della fedeltà alla famiglia, ai pregiudizi, alla consuetudine e alle tradizioni vi si frappongano. Non c’è ribellione contro la piattezza vittoriana – la stessa mite ma fermissima ribellione che la Eliot oppose con le sue scelte private – in questo romanzo che non ha malvagi e trova parole di comprensione per tutti. Ma c’è il disvelamento di questi lacci, di questi ostacoli, di questo passato che intrappola il presente e rende impossibile il futuro.
Il mulino sulla Floss è anche un’autobiografia, un’espiazione per interposta persona: Maggie Tulliver è Mary Ann Evans, la donna che sarebbe stata condannata allo stesso destino di infelicità se il suo posto non fosse stato preso da George Eliot. La tesi è di Giacomo Debenedetti, che la espone nel saggio conclusivo del volume, ottimo esempio della sua idea di critica come “consustanzialità all’autore”.
Maggie soccombe, George Eliot a suo modo conquista la felicità. Con l’elegia vibrante del Mulino vuole forse dirci che si sente in colpa per essere sopravvissuta? Poco prima di morire la scrittrice rientrerà nei ranghi. Scomparso Lewes, chiederà all’amico banchiere John W. Cross, più giovane di lei di vent’anni, di sposarla. E il fratello Isaac, che non sentiva da un quarto di secolo, si farà vivo per dirle che è finalmente diventata una donna onesta.
Heinrich von Kleist, La Marchesa di O***, traduzioni di Giovanna Federici Ajroldi e Bruno Maffi, Rizzoli, 1952

Ho cominciato da qualche mese la prima collezione della mia vita, io che ho sempre avuto scarsa attitudine al collezionismo e non sono mai riuscito a completare neppure le rare dispense che acquistavo in edicola. Vado cercando in bancarelle e librerie dell’usato (a Milano ma anche altrove: a Sassari e Palermo ho fatto bottini notevoli, amici e parenti che sanno di questa mia nuova mania qualche volta la alimentano) i vecchi volumetti con la copertina bigia della Biblioteca Universale Rizzoli, la mitica Bur ultratascabile creata nel 1949 da Luigi Rusca e Paolo Lecaldano che fino al 1972, quando venne soppiantata dall’attuale Bur, mandò in libreria più di un migliaio di titoli (l’ultimo volume, che non possiedo, è il 2481-2487: Fatti e detti memorabili di Valerio Massimo). Già, perché i volumetti Bur erano singoli o multipli. Singoli come, l’ho davanti agli occhi, Il miglior giudice è il re di Lope de Vega Carpio, drammaturgo del siglo de oro spagnolo (n. 922, sessanta lire). Doppi o tripli come Il brigante galantuomo di Heinrich von Kleist che mi accingo ad annotare (n. 415-416, doppio, lire duecento).
I volumetti della Bur m’ingolosivano da ragazzo. Erano tra i rari abbordabili per i miei pochi spiccioli, ma non era solo questo. Avevano davvero un’ambizione “universale”: le letterature maggiori e massime, ma anche le laterali (polacca, ungherese, danese, norvegese, araba, austriaca, anche la spagnola il cui ricordo si è andato affievolendo man mano che esondavano anglosassoni anche non memorabili) e molti “minori” che più tardi sarebbero tornati in circolo, non sempre e non tutti, nei repechage adelphiani. Anche le traduzioni, molte delle quali oggi suonano inevitabilmente datate, ospitavano nomi di vaglia: Ervino Pocar dal tedesco, lo svizzero Felice Filippini da molte lingue, Oreste del Buono dal francese (suo, fra i tanti, un Maupassant degli anni ‘50), Gabriele Baldini e Alfredo Polledro che per me restano ancora la miglior versione del teatro di Shakespeare e la più bella resa dell’integrale dei racconti di Cechov, nonché l’unica allestita dall’editoria italiana.
Durante le vacanze natalizie, assieme a volumi letti per esigenze di lavoro e documentarie, ho affrontato alcuni titoli di Natalia Ginzburg (Le voci della sera e l’implacabile Famiglia, ne parlerò il prossimo mese) e ho ripreso in mano lo smagliante, incantatorio Libera nos a Malo di Luigi Meneghello. Mi ero portato dietro anche Il brigante galantuomo di Kleist, autore centrale del romanticismo tedesco che ho molto caro, anche grazie al cinema (La marchesa di O*** nella versione capolavoro di Eric Rohmer, Il principe di Homburg nelle trasposizioni di Gabriele Lavia e soprattutto di Marco Bellocchio). La marchesa di O*** l’ho riletto volentieri, gli altri due testi mi aspettano. Segnalo, l’ho fatta anche troppo lunga, che fra i traduttori di questo volumetto figura Bruno Maffi, dirigente comunista bordighista, uomo coltissimo e traduttore supremo da molte lingue, padre dell’anglista Mario Maffi. Segnalo, per chi cercasse avventure meno antiquarie, che del racconto di Kleist esiste un’eccellente versione di Andrea Casalegno, pubblicata da Garzanti. Ecco i miei appunti sul racconto.
«A M., importante città dell’Italia settentrionale, la vedova marchesa di O***, signora di ottima fama e madre di due bravi figliuoli, annunziò sui giornali che si era trovata incinta a sua insaputa, che il padre del bimbo al quale avrebbe dato vita si presentasse, e che, per ragioni d’ordine familiare, era decisa a sposarlo». Ardita oltre misura per l’epoca, viene pubblicata nel 1808, la novella di Kleist mette in scena, fingendola resoconto di un fatto vero e omettendo ogni nome di persona e di luogo – soltanto la protagonista, Giulietta, e le città di Napoli e Costantinopoli vengono citate – forse un caso di stupro, forse una vicenda di rimozione ostinata.
A M., la cittadella comandata dal colonnello padre della marchesa è presa d’assalto dall’esercito russo, e un gruppo di soldati sta per usare violenza alla giovane marchesa. La salva, disperdendoli spada in pugno, un ufficiale russo, che la porta in salvo svenuta. Qualche tempo dopo, la marchesa riconoscente viene a sapere che il nobile ufficiale – è un conte – è morto in battaglia, e allo stesso tempo comincia a mostrare i sintomi della gravidanza. Ma il nobile russo è sopravvissuto e, dopo la convalescenza, ritorna dalla marchesa, chiedendola in moglie e quasi pretendendo un matrimonio all’istante, per ragioni che lui sa e non dice. Gli viene opposto un cortese rifiuto: torni dopo avere sbrigato i suoi affari, frequenti la famiglia della marchesa, e si vedrà. Intanto la gravidanza di Giulia diventa ufficiale: lei invano protesta di ignorare come sia potuto accadere, i genitori non le credono e la scacciano.
Decisa a resistere da sola, la marchesa fa pubblicare l’annuncio sui giornali. I genitori cominciano a nutrire qualche dubbio e la sottopongono a una prova, spingendo a presentarsi come padre del nascituro un loro servo ignaro di tutto, che la giovane donna accetta di sposare. Pentiti della loro intransigenza, i genitori chiedono alla marchesa di perdonarli e la riaccolgono in casa. Dove si ripresenta l’ufficiale russo, che viene scacciato: Giulia sposerà tutti tranne lui. Alla fine acconsente alle nozze, a patto che del marito lui abbia tutti gli obblighi e nessuno dei diritti. L’ufficiale accetta le condizioni e, dopo un anno di distanza discreta, le nozze (stavolta d’amore) vengono celebrate. «Una serie di piccoli russi seguì al primo; e quando, in un’ora felice, il conte chiese alla moglie perché, quel tremendo giorno 3, mentre sembrava ormai rassegnata a qualunque peccatore, l’avesse sfuggito come il diavolo, ella rispose, buttandogli le braccia al collo, che allora non le sarebbe apparso un diavolo se, alla sua prima apparizione, non le fosse sembrato un angelo».
La bellezza della Marchesa di O*** risiede nella sua ambiguità. Castissima e sommamente elusiva nei dettagli, la novella fa intuire da subito che il padre del nascituro è l’ufficiale russo. Mai però viene detto che Giulia sapeva, e mai vengono chiarite le circostanze del concepimento. Forse la marchesa è stata presa nel sonno, forse ha partecipato a un attimo di passione che le convenzioni sociali le hanno impedito di portare alla coscienza. Insomma, una storia dell’innocenza che trionfa. Oppure la storia di un amore che il filisteismo censura e cancella, scelga chi vuole la sua interpretazione.
Philip Larkin, Finestre alte, traduzione di Enrico Testa, Einaudi, 2002

Philip Larkin (1922-1985) è stato il maggiore poeta inglese del secondo ‘900. “Master of the Ordinary”, con felice formula, lo ha definito il Nobel Derek Walcott. Laureato a Oxford, bibliotecario per tutta la vita, poeta dopo il lavoro “dalle nove alle cinque” con una produzione assai parca, quattro raccolte. Un poeta di quotidianità e di periferie, di esistenze che progrediscono per biologia e senza fare esperienza, della vecchiaia come traguardo inesorabile (L’edificio) e della giovinezza «che non è mai tesoro perduto ma possibilità non esistita» (Finestre alte).
Poesia narrativa e antimetafisica, antiretorica. Ironica e dolorosa, non consolatoria. Anche con se stesso, che parli delle sue tardive esperienze sessuali legandole agli esordi dei Beatles e alla riabilitazione di Lady Chatterley (Annus mirabilis), si dedichi un epitaffio (Condoglianze in bianco maggiore) o si veda affidato a uno studioso annoiato (Posterità). Ma, scrive il traduttore Enrico Testa, «il sarcasmo non esclude la pietà, l’ironia non si raggela mai in ghigno». Come nella memorabile Vecchi scemi, che dà la misura esatta dei temi e del tono:
(…)
Morendo, si va in frantumi: i pezzetti che erano te
incominciano, in gran fretta, a salutarsi l’un l’altro per sempre,
inavvertiti da tutti. È solo oblio, certo:
ci capitava anche prima, ma allora finiva,
ed era continuamente assorbito in un unico sforzo
teso a far sbocciare il fiore dal milione di petali
dell’essere qua. La prossima volta non potrai fingere
che ci sia qualcos’altro. E questi sono i primi sintomi:
non sapere come, non sentire chi, il potere di scegliere
svanito. Il loro aspetto mostra che sono prossimi:
capelli di cenere, mani di rospo, volti rugosi come prugne secche –
Come possono far finta di nulla?
Ma forse essere vecchi è avere stanze illuminate
dentro la testa, e in esse delle persone, che recitano.
Persone che conosci, ma di cui ti sfugge il nome:
ognuno appare in lontananza come un vuoto profondo che si colma:
si volta sulla soglia di casa, sistema una lampada, sorride da una scala,
prende un libro già letto dallo scaffale; oppure, qualche volta,
soltanto quelle stanze, le sedie e un fuoco ardente
o, alla finestra, un cespuglio mosso dal vento o dal sole,
timido e gentile, sul muro una serata solitaria
di mezza estate dopo l’acquazzone. È là che vivono:
non qui e adesso, ma là dove tutto è successo un tempo.
(…)
Poesia “postuma”. Alla fine delle ideologie e di un senso della vita, alla fine dell’Inghilterra (Andare, andare). Poesia di una vita da affrontare a ciglio asciutto, di cui niente resterà. O forse sì. Una riunione conviviale come nel Sabato di fiera:
qualcosa da
tutti condiviso
che atavicamente ogni anno prorompe in
rigenerata unione. Possa restare là per sempre.
La natura, l’aria, come in Finestre alte:
E all’improvviso
non una parola viene, ma il pensiero di finestre alte:
il vetro che assorbe il sole,
e, al di là, l’aria azzurra e profonda, che non mostra
nulla, che non è da nessuna parte, che non ha fine.
La gioventù nello sguardo di un vecchio che si è svegliato di notte:
la durezza, lo splendore e la semplice
e vasta unicità di quello sguardo
sono un ricordo della forza e del dolore
della gioventù; non potrà tornare
ma in qualche parte resta, per gli anni, intatta.
Resterà forse la gentilezza, come una possibile metafora del mondo, anche di fronte al dolore. Come, dopo lo schianto in miniera (L’esplosione), resta intatto un nido di uova di allodole, che un minatore aveva deposto con cura nell’erba prima di entrare nel cunicolo.
Giovanni Mariotti, La biblioteca della Sfinge. Cento enigmi letterari, Palingenia, 2024

Cento ritratti mascherati, cento biografie brevi e laterali, costruite partendo da poche circostanze – tre, quattro, a volte anche meno – di altrettanti autori, a volte notissimi (Proust, Wilde, Manzoni) e a volte più esoterici: Saikaku Ihara, Shang Yang, Hartmann von Aue. Indovinelli (ogni ritratto si conclude con un “Chi è?”) che Giovanni Mariotti, scrittore da me molto amato, allestiva più di trent’anni fa per Sette e Io donna. Ora, immagino arricchendo la dotazione iniziale, li ha raccolti in un libro doppiamente prezioso: un volume sontuoso con carta pregiata, segnalibro in stoffa e dovizia di quadri dedicati alla lettura e ai lettori; e una prova discreta quanto smagliante di stile e di sapienza, una maestria suprema nell’arte di tratteggiare le “vite brevi”.
Ci sono ritratti che un lettore scaltrito non fatica a riconoscere. Come questo, dedicato al più grande autore di racconti di sempre:
“I medici non amano essere visitati da altri medici… e poi, cosa potevano dirgli che già non sapesse?
Ma la notte del 2 luglio – un caldo terribile stagnava su tutta l’Europa – chiese alla moglie di chiamare un medico.
Da qualche giorno si erano trasferiti all’albergo Sommer di Badenweiler.
Quando il dottor Schwörer arrivò, lo informò con sobrietà: «Ich sterbe», io muoio.
Schwörer gli fece un’iniezione di canfora e ordinò al cameriere di correre in ospedale, a prendere una bottiglia di ossigeno; ma il malato intervenne: «È inutile. Quando arriverà sarò già morto».
Così, invece di una bottiglia di ossigeno, al cameriere fu chiesto di portarne una di champagne.
Gli tesero il bicchiere. Constatò: «È da molto che non ne bevevo».
Vuotato il bicchiere, si girò su un fianco.
Un istante dopo non respirava più.
Quando il suo corpo arrivò a Mosca su un vagone verde refrigerato che portava la scritta «Ostriche» perché di solito era adibito al trasporto di quella mercanzia, assai amata dai moscoviti, sul marciapiede della stazione una banda militare stava eseguendo una marcia funebre.
Quelli che erano andati ad accoglierlo si accodarono alla banda, credendo che suonasse in suo onore; invece suonava in onore del generale Keller, morto in Manciuria. Accorgendosi di avere scelto il funerale sbagliato, gli amici e gli ammiratori dello scrittore raggiunsero di corsa quello giusto, che già si stava allontanando.
Ancora una volta, tutto era andato per il meglio: nessuna enfasi e, come nelle sue commedie e nei suoi racconti, non era mancato un tratto umoristico”.
E altri ritratti cifrati, di tenera aneddotica, forse più ardui da intuire.
Come questo dedicato a un grande praghese di lingua tedesca.
“Nel 1924, a Berlino, una bambina scoppiò in pianto.
Un uomo alto, esile e dall’aria sofferente – aveva quarant’anni, e da qualche tempo aveva lasciato, a causa della tisi, il lavoro in una società di assicurazioni – le chiese quale fosse la causa delle sue lacrime. La bambina rispose di avere perso la bambola.
«La tua bambola è in viaggio» disse l’uomo «lo so, mi ha appena scritto una lettera».
«Leggimela» disse la bambina.
E l’uomo: «Non ce l’ho qui, ma domai te la porterò».
Detto fatto: l’indomani l’uomo portò la lettera e la lesse. La bambola spiegava che aveva scelto di cambiare città e nazione perché era stanca di vivere sempre nella stessa famiglia; però avrebbe scritto ancora”.
Ho dato un piccolo assaggio, gli altri 98 ritratti ve li leggete. Senza ricorrere, per le soluzioni, a wikipedia e simili. Più semplice prendere un coltellino da cucina o un tagliacarte e aprire l’ultimo sedicesimo intonso con la lista dri nomi.
Ho avuto Mariotti come collaboratore di rango in un femminile in cui ho lavorato. Mi piacevano di lui, oltre all’infinita sapienza (ha curato per anni la preziosa “Biblioteca Blu” di Franco Maria Ricci diretta da Jorge Luis Borges), allo stile terso e a una gentilezza timidissima, cose che spiacevano ad alcune mie schizzinose cape: che preferisse il vino rosso del bottiglione, che protestasse come uno zappatore al quale hanno conteggiato male le giornate se lo pagavano meno del convenuto. Tra gente nata povera ci si capisce.
Giovanni Mariotti, Il bene che viene dai morti, et al., 2011
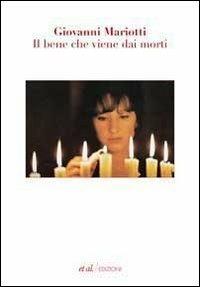
L’accento mesto della Versilia. L’autobus della Saca che tutti i giorni da Viareggio porta a Pedona, frazione di Camaiore, «i viaggiatori che affluiscono a piccole onde mansuete, uno due alla volta, chi da una direzione, chi da un’altra: donne a servizio nelle case, giovani operaie, cameriere ai piani, facchini». E il mendicante Alipio, che fa incetta di spiccioli fra Viareggio e Forte dei Marmi.
Nella corriera Bruna, sedici anni, operaia in un calzaturificio, tiene sempre il posto a Giovanni, io narrante di questa storia sospesa tra i vivi e i morti. Giovanni che forse è Giovanni Mariotti, ma forse è più corretto pensare che sia un personaggio che dice io e si chiama Giovanni. Giovanni che studia, legge e non parla: è cresciuto in solitudine, allevato da una madre vedova che fa la cameriera negli alberghi della Versilia e, quando le va bene, nelle case borghesi. È venuto su timido, introverso, di quei ragazzi che stanno sempre in fondo all’aula. E la sua timidezza lo porta a correre, a scappare.
Nella corriera Giovanni legge i vecchi Bur con la copertina bigia, Bruna legge Bolero. Poche parole, tra loro. Come va? Così. Bruna, chissà, ama Giovanni ma non dice niente; forse Giovanni ama Bruna o la dovrebbe amare, ma non lo sa, non se ne accorge: i timidi sono anche distratti, svagati. Un solo gesto, solenne e impacciato, che sarebbe quasi d’amore: quando Giovanni, con fare quasi cerimonioso, bacia il dito incerottato di Bruna, ferito da una macchina.
Un giorno Giovanni lascia Pedona all’improvviso. Va a Milano, ha vinto un concorso in Rai. Parte senza salutare, non vedrà più Bruna. A Milano conduce l’esistenza smarrita che hanno fatto mille provinciali inurbati prima di lui: camere ammobiliate con foto di ragionieri morti appese sopra il letto, vagabondaggi senza una meta più in periferia che in centro, scarpe troppo strette per piedi troppo grandi e per una voce timida che non osa chiedere un numero in più, solitudini e cinema pomeridiani, la Casa della Cultura e il vicino locale di strip-tease, l’avanspettacolo e i cortei del ‘68.
Torna a Viareggio due tre volte l’anno. A Pedona nelle feste di Natale.
Nei brevi conversari con la madre apprende che Bruna è cambiata. Dopo quello che allora si definiva un “esaurimento nervoso”, legato forse alla sua brusca partenza (ma la madre non lo sa), si è fatta spavalda e scontrosa, ha un’auto, si accompagna a uomini. A Giovanni pare di riconoscerla in una giovane donna che gli cammina davanti, in una strada di periferia tra case in costruzione e campagna che si ritrae (pagine ammirevoli, che ricordano i paesaggi desolati della Notte di Antonioni). Non è lei, Giovanni la guarda allontanarsi ed entra nell’ippodromo di San Siro davanti al quale è sbucato a sorpresa, come si entra in un sogno. Consigliato da un frequentatore (scoprirà il giorno dopo che aveva le fattezze del ragioniere morto che lo guarda dalla sua fotografia nella camera ammobiliata), gioca e vince.
Nella sua camera, quella notte, Bruna gli fa visita per congedarsi. Poche parole, come sempre, una ripulsa al contatto, forse l’idea di un bacio durante il sonno, un risveglio placido.
Il giorno dopo apprenderà al telefono dalla madre che la ragazza è morta in un incidente d’auto. Il bene che gli ha portato, come in una commedia di Eduardo dove i morti suggeriscono i numeri al lotto, è la vincita all’ippodromo che spenderà per acquistare un maglione di cachemire. Che porterà a un altro maglione, a un’altra donna; a scrollarsi forse di dosso quel vago senso di colpa che era quell’amore mai dichiarato e mai vissuto.
«Non so dove siano i morti: certo non all’Inferno, né in Paradiso; tanto meno nelle anticamere di qualche Tribunale, in attesa del Giudizio; che non c’è.
Sono qui, credo… poco lontano da qui. Forse nemmeno sanno di essere morti. La morte non è questione di istanti, di questo sono convinto: è un processo di disgregazione che a volte comincia prima (anche molto prima) e continua dopo (anche molto dopo) la fine certificata dai medici.
Ognuno ha la sua morte, come ognuno ha avuto la sua vita; per alcuni sarà un indugio, una condizione labile e transitoria: un po’ come quando la direzione di un albergo ci permette di trascorrere parte del pomeriggio nella camera che avremmo dovuto lasciare in tarda mattinata (…)
Mi piacerebbe che la mia morte fosse così; immagino che possa essere anche così, la morte di un vecchio: soltanto un po’ malinconica; appena increspata da irrequietezze; legata a un luogo, agli odori che ristagnano nelle stanze, e di cui si è impregnati. È la morte di chi non ha attese: con una vita ormai a bilancio, anche se si tratta di un bilancio deludente; ma altri muoiono con un’agenda ancora fitta di impegni, di conti in sospeso, di amori frustrati, di passioni senza riscontro, di riconoscimenti mai avuti. (…)
Il dolore per un destino incompiuto mantiene i morti nel giro dei vivi, come falene bianchicce in giostra intorno a un lume acceso. Si muovono cieche, irrequiete; sbattono contro ostacoli invisibili. A volte il pensiero di qualcosa che nella vita è mancato spalanca nell’aria voragini, precipizi, abissi di assenza; da quei vuoti gli Spiriti sono aspirati, risucchiati, come da un turbine; trascinati da un vento oscuro. Il vento che forse, quella notte, aveva portato Bruna da me».
Ho riassunto in maniera lineare Il bene che viene dai morti, che è qualcosa di meno di un tradizionale romanzo a plot e qualcosa di più. Mariotti è scrittore assai sorvegliato e dai molteplici registri stilistici: il suo libro più lodato, Storia di Matilde del 1993, che Pietro Citati considera il più bel romanzo degli ultimi vent’anni, si dipana per 220 pagine senza traccia di punteggiatura, a parte il punto fermo che lo chiude. Lo possiedo con la dedica timida e preziosa dell’autore: “Una frase, un libro appena”.
Stavolta Mariotti sceglie una prosa scarna e volutamente esile, fatta di frasi brevi, periodi corti, molti spazi bianchi e grande uso dei punti di sospensione; più che raccontare compiutamente evoca, suggerisce, si ricorda all’improvviso, cambia discorso, salta avanti e indietro nel tempo. L’apparente disordine è controllatissimo, la svagata e quasi reticente laconicità accumula come per caso figure, situazioni, epifanie, tesori: i fuochi fatui nel vecchio convento, il nobile polacco che rimase in silenzio per trent’anni; Leonida Repaci con il petto “lanoso” e un asciugamano intorno ai lombi, Buster Keaton spaesato e con gli occhi sbarrati in un teatro del varietà milanese; la ragazza che piange davanti a Nôtre Dame, il bal du muguet, la fola del povero nonno, il calzolaio Tinchetta in fondo alla Scesa, Baudelaire e Apollinaire, Victor Hugo e Hölderlin; la spogliarellista Ya Douchevskaja che «possedeva, penso, un’arte, o un dono, che le altre non possedevano: far credere a chiunque, in quella platea, che lei lo guardasse».
In questa contiguità tra morte e vita, in questo modo allusivo e discreto di annoverare anche noi vivi tra i fantasmi (Musica nella stanza accanto è l’altra metafora per la morte, nel bellissimo romanzo del 1999) si riassume l’educazione sentimentale di una generazione: la sua, in parte anche la mia che gli è successiva. Lo spaesamento, la timidezza e il senso di inadeguatezza che negli anni ‘50-‘60 accompagnò molte piccole ascese sociali e che oggi ha mutato di segno: esuberanza ed estroversione costante dei tanti Lucignoli sempre sotto i riflettori, nel Paese dei Balocchi. L’attrazione per le donne mista a paura che fu la cifra della nostra maleducazione sentimentale. L’intimità e l’estraneità assoluta che convivono nei rapporti fra madri e figli, fra padri e figli. La necessità, per crescere e vivere, di prendere congedo e dire addio.
Scrive Mariotti nella nota conclusiva: «Ognuno scrive quello che può e che sa. Questa storia di poveri, di timidi, di spettri discreti e vergognosi non ha certo la tenuta e l’interesse sociale delle belle storie borghesi, o di quelle tragiche raccontate dai memorialisti ebrei. Non sono mai esistiti una cosa scritta, un lavoro, una nazione, una società, un mondo che io abbia sentito miei; queste pagine sono un sarmento, uno stecco intirizzito, di quelli che a Pedona raccattavamo per il fuoco». Ci si può riscaldare anche a questo piccolo fuoco.
Michael Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, traduzione di Luigi Civalleri, Adelphi, 2008
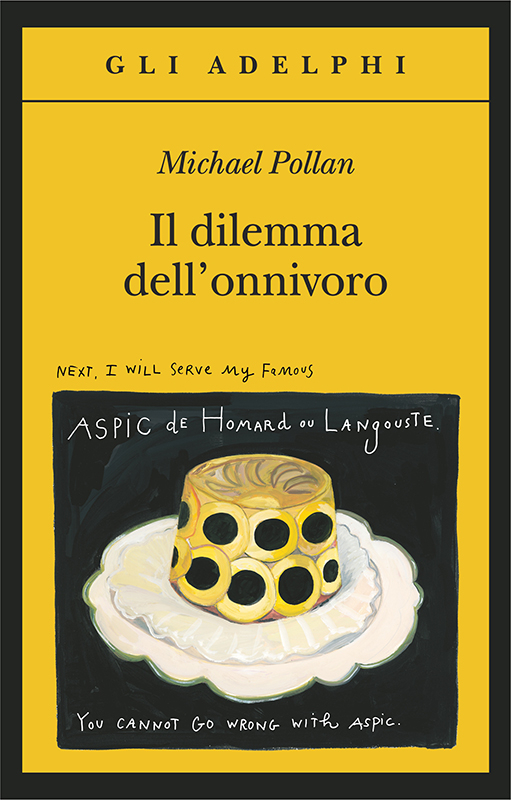

Michael Moss, Grassi, dolci e salati, traduzione di Francesca Gimelli, Mondadori, 2014
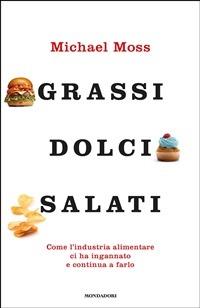
Chris van Tulleken, Cibi ultraprocessati, traduzione di Annarita Tranfici, Vallardi, 2024

Mi è capitato di recente di scrivere un’inchiesta sul cibo industriale che avvelena americani e inglesi e prende piede, in forme più modeste ma non meno insidiose, anche da noi. Attaccavo così, mi cito perché parlo anche di due libri che ho consultato.
«Tre mucchi di mattoncini Lego. Ci puoi costruire il grattacielo, la reggia o l’allegra fattoria. Versailles e il mulino bianco. Detto così suona gioioso e sembra che sia tu l’architetto. I mattoncini sono zucchero, grassi e sale: gli ingredienti principali di preparazioni che non sono più cibo ma combinazioni di composti. Big Food li sposta per noi, ingegnerizzando il cibo – grasso incolore inodore insapore che si mimetizza, zucchero e sale che modificano la struttura diventando impalpabili per invadere meglio gli alimenti da colonizzare – dalla barretta che sostituisce il pasto ai cereali per la colazione, dalla bevanda gasata alla pizza surgelata, dallo snack al panzerotto alla patatina, dalla lasagna alla caramella. Poi varia le proporzioni, un po’ più di zucchero e un po’ meno di sale o viceversa; guarnisce di composti chimici, emulsiona, addensa, solidifica o ammorbidisce. Il gioco è fatto, i prodotti sembrano diversi ma sono più o meno tutti uguali nella struttura.
Si chiamano cibi ultraprocessati, sono il vanto e la fonte quasi esclusiva di profitti immensi per i giganti mondiali del pronto all’istante, dello “stacca, lecca e inzuppa”, del “ne voglio ancora, ne voglio di più”. Negli Stati Uniti otto alimenti su dieci sono fatti così e forniscono il 60% dell’apporto calorico medio quotidiano alla popolazione, il 70% nel caso degli adolescenti. In Italia siamo ancora lontani da quegli abissi, secondo un recente rapporto della Fondazione Aletheia soltanto il 14% delle calorie quotidiane arriva dai cibi Frankenstein, ma nei grandi centri urbani, tra i single indaffarati e imbranati ai fornelli e tra gli anziani soli con pochi soldi e scarsa voglia di spignattare la percentuale aumenta.
«Negli ultimi dieci anni la situazione è peggiorata dovunque, l’obesità e le altre conseguenze nefaste per la salute che una dieta a base di cibi processati porta con sé si sono impennate da quando le grandi aziende hanno esteso il loro dominio sul mondo» mi dice Michael Moss, reporter del New York Times che con le sue inchieste ha vinto il premio Pulitzer (la sua requisitoria Grassi, dolci, salati. Come l’industria alimentare ci ha ingannato e continua a farlo in Italia è stata pubblicato da Mondadori, la trovate in e-book). E cita l’esempio dell’arrembaggio della Coca-Cola sul Brasile, dell’India invasa dai biscotti Oreo, della Cina conquistata dal “più zucchero, ancora più zucchero”. «Inoltre, si allarga il divario tra chi può permettersi una dieta sana e chi è costretto ad acquistare alimenti nefasti a basso costo».
Ma come si riconosce il pappone da cui stare alla larga? Secondo l’epidemiologo brasiliano Carlos Monteiro, che ha inventato il termine “ultraprocessato”, se contiene aromi, coloranti, addensanti, emulsionanti e altri additivi fra gli ingredienti, non è un alimento naturale. Non lo è neppure se non posso farmelo in casa: se usa lo sciroppo di glucosio al posto dello zucchero, se sostituisce la caseina e il siero al latte, se utilizza un grasso idrogenato al posto del burro.
Ancora più drastico Chris van Tulleken, medico e ricercatore inglese, volto noto della Bbc e autore del bestseller fresco di stampa Cibi ultraprocessati. Come riconoscere ed evitare gli insospettabili nemici della nostra salute (Vallardi), che scrive: “Se è avvolto nella plastica e contiene almeno un ingrediente che di solito non si troverebbe in una classica cucina, è cibo ultraprocessato: forse li conoscete come ‘cibo spazzatura’, ma esistono un sacco di alimenti ultraprocessati biologici ed ‘etici’, che vengono venduti come sani, nutrienti, rispettosi dell’ambiente o utili per perdere peso (in linea di massima quasi tutti gli alimenti che riportano sulla confezione un’indicazione sulla salute sono cibi ultraprocessati)”.
Completiamo l’identikit dei prodotti nel mirino. Sono cibi piacevoli al tatto e al gusto. Morbidi o croccanti, invitanti nell’aspetto, facili da masticare. E facili da tenere in casa, a volte senza neanche il bisogno del frigorifero: ci pensano i conservanti e gli additivi. Energetici e ad alta densità calorica: saziano presto e, al tempo stesso, ne vorresti di più. Non c’è problema: te li vendono spesso in confezioni giganti. Costano poco, se li possono permettere anche i più svantaggiati. Sono pratici, devi solo riscaldarli e a volte li puoi mangiare anche freddi: il successo miliardario dei vassoietti Lunchables è un caso da manuale. Placano il senso di colpa delle mamme lavoratrici che devono preparare colazione, pranzo al sacco (e cena svelta) ai figli in una manciata di minuti. Pronti, c’è il “convenience food”, il cibo istantaneo così comodo: come l’aranciata in polvere Tang, basta aggiungere l’acqua. Peccato che sia al 100% artificiale, pura chimica, l’arancia neanche vista in cartolina. Ci sono i cereali zuccherati che hanno fatto triplicare l’obesità infantile in un paese di obesi (negli Stati Uniti sono il 42% della popolazione, con un ulteriore 31% in sovrappeso, a tal punto che diventa difficile reclutare nuovi marines e, per le partorienti, affrontare un parto cesareo; da noi sono obesi undici italiani su cento, con un 36,1% in sovrappeso). Un dentista americano, Ira Shannon, allarmato dall’aumento della carie tra i bambini, tempo fa ha raccolto 78 campioni di cereali zuccherati e li ha mandati ad analizzare, scoprendo che un terzo conteneva dal dieci al 25% di zucchero, un terzo il 50% e il restante terzo lo superava, con la palma del più stucchevole (del più irresistibile?) al Super Orange Crispie, che raggiungeva la vetta del 70,8%: non più cereale, ma puro glucosio con un residuo di frumento, avena o riso. «Tra cereali, biscotti, merendine, bibite gasate e zuccheri nascosti nei vari cibi, per esempio nel ketchup e nelle salse, in America consumiamo circa 32 chili di dolcificanti all’anno. Sono 22 cucchiaini di zucchero a persona al giorno» dice Michael Moss. La dose quotidiana raccomandata per una donna che fa un lavoro non troppo faticoso è cinque cucchiaini al giorno: all’incirca mezza lattina di Coca-Cola.
Stiamo parlando di zucchero per completare l’identikit: i cibi ultraprocessati danno dipendenza e lo zucchero, assieme ai grassi, è l’imputato numero uno. Il dolce è una predisposizione innata negli umani, il primo gusto che i bambini istintivamente apprezzano: li gratifica, li tranquillizza, è blandamente analgesico. Basterà insistere e non si farà fatica a condizionarli a vita. Lo zucchero raggiunge la barriera encefalica in un secondo facendola esultare, le risonanze magnetiche lo dimostrano, mentre il tabacco ce ne mette dieci. E, quando la caloria è liquida, i nostri corpi sono meno consapevoli di un apporto eccessivo. «L’industria utilizza una combinazione di iper-ingegneria per massimizzare l’eccitazione che i loro prodotti creano nel nostro cervello e un marketing selvaggio che ci spinge ad agire d’impulso per acquistare e consumare questi prodotti anche quando non abbiamo fame» spiega Michael Moss. «Inoltre, credo che per molte persone questi prodotti alimentari siano più pericolosi delle sigarette, dell’alcool o anche di alcune droghe, perché l’industria ha imparato a massimizzare il loro fascino sfruttando la nostra biologia più profonda – compresa la nostra innata attrazione per i cibi a buon mercato, per la varietà e per le calorie – per indurci a mangiare troppo».
Fin qui la mia inchiesta. Era inevitabile che riprendessi in mano Il dilemma dell’onnivoro, un classico del 2008 di Michael Pollan che non ha perso mordente né attualità, un viaggio nelle viscere degli Stati Uniti. Che cosa mangia l’onnivoro americano (e occidentale), signore e padrone della catena alimentare? Di tutto, di più, e male. Senza sapere da dove arriva questa cornucopia avvelenata. Michael Pollan, professore di giornalismo a Berkeley e collaboratore fra gli altri del New York Times, costruisce questo reportage sul cibo come una sorta di Commedia dantesca. Con tre gironi: l’inferno dell’industria alimentare, il purgatorio del biologico, l’improbabile paradiso del ritorno allo stato di natura del cacciatore-raccoglitore.
Si fa prima a dire che cosa non è il libro di Pollan: non è un pamphlet predicatorio, non è un saggio fondamentalista, non è neppure (soltanto) un saggio. È, piuttosto, una miscela affascinante di conoscenza ed esperienza, di studio e verifica sul campo, di raccolta di dati e narrazione.
Il meccanismo, se non lo stile, è quello della prosa proustiana: narrazione, divagazione saggistica, ritorno alla narrazione.
Seguiamolo dunque nel suo viaggio all’inferno. Alla scoperta della monocultura del mais, che è diventata la componente essenziale diretta e indiretta, assieme alla soia, di ogni prodotto per l’industria alimentare: mangime animale che corrode il rumine dei bovini, ingrediente di hamburger, sciroppi, bibite gasate, merendine, sotto forma di farina ma anche di glucosio, addensante, acidificante, conservante, antischiumogeno ecc (un pezzo di bravura da segnalare: i trentasette ingredienti dei Chicken McNuggets, crocchette di pollo dei fast-food costruite per tre quarti con granturco). E all’esplorazione dei disumani feedlot, i lager per animali in cui i bovini trascorrono la loro esistenza breve e infelice ingozzati di mais e antibiotici (e, spesso, di grassi animali e urea). Un fiume di mais a basso costo alimentato da un fiume di petrolio, che costringe gli agricoltori a produrre sempre di più per restare a galla, appiattisce le varietà, cancella le altre colture e riduce una popolazione all’obesità.
Abbiamo parlato delle divagazioni di Pollan: particolarmente interessanti, qui, la storia del chimico ebreo tedesco Fritz Haber, inventore del processo per fissare l’azoto (e quindi dei fertilizzanti chimici, che nel dopoguerra invadono le campagne americane come sottoprodotto che l’industria bellica deve smaltire) e, per tragica ironia della storia, inventore anche del Zyklon-B, il gas usato dai nazisti nei campi di sterminio. E la storia del mais a buon mercato che nella prima metà dell’800, avviato alla distillazione perché ancora non esisteva il fast-food, fece impennare i picchi di alcolismo della giovane nazione.
La guida all’inferno, che Pollan attraversa da una fattoria nello Iowa ai feedlot del Kansas ai silos e alle macine industriali, fino a un pranzo da fast-food (quindici dollari) consumato in auto in California, è il contadino George Naylor, schiavo del suo mais.
Battagliero protagonista del biologico è invece un allevatore della Virginia, Joel Salatin, che si definisce “cristiano conservatore ecologista e libertario”. Prima di arrivare alla sua fattoria, la Polyface, Pollan smonta anche il mito del biologico: arcipelago frastagliato, a volte migliore del prodotto industriale, ma spesso e volentieri brand di nicchia dell’industria alimentare. Con Salatin, che si definisce “erbicultore”, il discorso cambia: tutto parte dall’erba e Pollan, che trascorre una settimana a lavorare in fattoria, comincia proprio dal riconoscere le varietà erbacee. I bovini pascolano “quasi” liberamente sui quaranta ettari della fattoria. Quasi nel senso che, periodicamente, vengono spostati da un punto all’altro del pascolo (le suddivisioni sono segnate su un foglio elettronico del computer), per lasciare all’erba il tempo di ricrescere.
Tre-quattro giorni dopo che i bovini hanno abbandonato l’appezzamento, arrivano a bordo di una curiosa “ovomobile” le galline, che becchettando fra il letame lo spargono e disinfestano il terreno dai parassiti. Minuscoli e determinati, Joel Salatin e affini mostrano un’alternativa possibile e osteggiata dal ministero dell’agricoltura: la produzione di animali (e uova) sani e qualitativamente superiori, che vengono venduti direttamente, raggiungono i ristoranti della zona e arrivano fino a Washington grazie al circuito dei farmers’ market. Affascinanti, in questa sezione, tutte le digressioni teoriche, e in particolare quelle sul lavoro degli animali e sul “macello trasparente”.
La terza parte è la più divertente narrativamente, e allo stesso tempo la più filosofica: la trasformazione di Pollan in cacciatore, coltivatore e raccoglitore per preparare il “pasto ideale”, con alimenti cioè direttamente procurati da lui. Avvertenza: Pollan non predica il ritorno alla preistoria né suggerisce un’alternativa da buon selvaggio alla barbarie industriale. Semplicemente, vuole raggiungere (e comunicare) una consapevolezza personale sugli anelli che formano la catena alimentare. Vuole rivivere l’esperienza della caccia e della raccolta come stato di necessità e non come hobby. La sua guida è, più di ogni altro, un siciliano trapiantato a San Francisco, Angelo Garro, architetto del ferro battuto e appassionato della cucina fai-da-te che caccia, raccoglie, insacca, fa vino e aceto balsamico ecc.
Con l’assistenza di questo tarchiato Virgilio, Pollan imbandirà una cena di purea di fave e paté di cinghiale, tagliatelle (unico strappo alla regola dell’autosufficienza) con sugo di spugnole, maiale selvatico brasato e alla griglia, crostata di ciliegie raccolte sulla pubblica via (a Los Angeles esiste addirittura un sito Internet che segnala la frutta a disposizione di tutti: fallenfruit.org). E pane fatto in casa. Un trionfo. Non dogmatico e assai ben scritto, Il dilemma dell’onnivoro amalgama, nella narrazione in prima persona, robuste dosi di biologia, economia, etologia, psicologia, neurologia, storia e quant’altro. Il risultato è notevole.
Di recente Pollan ha aggiornato e riassunto il suo lavoro di esploratore del cibo industriale in un Manuale dell’onnivoro arricchito dalle deliziose illustrazioni di Maira Kalman. Offre 83 raccomandazioni, cito le prime dieci. Che non si limitano a ingiungere, ma spiegano perché.
1) Mangiate del cibo.
2) Non mangiate nulla che la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo.
3) Evitate prodotti alimentari con ingredienti che nessuna persona normale terrebbe in dispensa.
4) Evitate prodotti che contengono sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio.
5) Evitate cibi che contengono qualche genere di zucchero (o dolcificante) elencato tra i primi tre ingredienti.
6) Evitate i prodotti alimentari che contengono più di cinque ingredienti.
7) Evitate i prodotti con ingredienti che un alunno delle elementari non saprebbe pronunciare.
8) Evitate prodotti alimentari con indicazioni salutiste.
9) Evitate i prodotti alimentari con le scritte «dietetico», «magro» o «senza grassi».
10) Evitate i cibi che vogliono sembrare quello che non sono.
Alessandro Robecchi, Le verità spezzate, Rizzoli, 2024

Manlio Parrini, settant’anni, regista venerato, un Oscar, ha deciso di ritornare dietro la macchina da presa dopo trent’anni di silenzio. Aveva lasciato perché il cinema gli appariva un luogo senza verità.
Ha in testa una storia vera, un delitto frettolosamente archiviato come fatalità: l’uccisione di uno scrittore per mano fascista a Bellagio, nel 1944. La vittima è Augusto De Angelis, romano trapiantato al Nord, classe 1888. Giornalista, autore di commedie, poligrafo e traduttore. Soprattutto, a partire dal 1935, creatore dell’umano troppo umano commissario De Vincenzi, il nostro Maigret sideralmente lontano dal poliziotto energumeno che vorrebbe il fascismo. Dopo i successi iniziali del suo personaggio, De Angelis se la passa sempre peggio.
I suoi gialli non piacciono – ma sarebbe più esatto dire: i gialli non piacciono – al regime, che chiede un protagonista più energico e impone assassini tutti stranieri: gli italiani, si sa, sono brava gente. Il suo commissario, invece, è un uomo gentile e colto, preferisce i libri al manganello. De Angelis, che non è fascista ma non si è segnalato per antifascismo, accetta bon gré mal gré le richieste di autocensura, smussa gli angoli, elimina i particolari torbidi, ingentilisce, normalizza. Non gli serve a niente: nel 1943 il Minculpop vieta la pubblicazione dei polizieschi. Lui intanto si è fatta la fama del non allineato, dell’oppositore, e sul lago si Como dove si è rifugiato un repubblichino lo ammazza di botte simulando l’incidente per questioni di donne.
Verrà rivalutato post-mortem, De Angelis, senza che tuttavia sulle circostanze della sua fine si torni a indagare. Lo riscopre nel 1963 Oreste del Buono e lo ripropone per Feltrinelli, qualche anno dopo la Rai gli dedica una serie affidando la parte a Paolo Stoppa e, in tempi più recenti, lo ripubblicano Sellerio e Mondadori, mentre Luca Crovi ridà vita al suo investigatore con nuovi romanzi.
Il film-indagine dell’anziano maestro, tuttavia, non è un cold case, o non soltanto. È, come lo è il romanzo di un Robecchi a suo agio anche senza Monterossi, una metafora sulla libertà. Che non si perde mai, ieri come oggi, tutta per intero e tutta d’un colpo. Ma per progressivi slittamenti, compromessi quotidiani, alzate di spalle e mugugni repressi contro imposizioni che si accettano perché paiono cose ridicole, piccole seccature senza importanza.
Sembrano fastidi da sopportare, gentili pressioni a fin di bene (a fin di marketing) anche gli interventi del produttore che cerca di addomesticare il film, in forse fino alle ultime pagine. E se un delitto brutale di ieri viene derubricato e amnistiato come lite che ha preso la mano ai litiganti, un delitto di oggi (del quale non diremo e che si svolge sotto gli occhi del regista, vittima una sua vicina di casa) non avrà, come ieri, giustizia. Non occorre essere eroi per andare incontro alla morte, non serve essere gente normale per scansarla. Anche senza esiti così tragici, è l’implicito ammonimento, avere la libertà o perderla è questione che riguarda tutti.
Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari, traduzione di Enrico Lupinacci, Mondadori, 1995

Fa una strana impressione rileggere le imprese del capitano Nemo e dei suoi involontari prigionieri mentre il nostro mondo conosce una crisi profonda. La pagina celebra l’apogeo dell’Occidente e dei suoi miti – il progresso, la conoscenza senza limiti e senza ostacoli, il mondo che si offre come un frutto da cogliere allo scienziato, all’esploratore, al colonialista – con le sue prime incrinature (Nemo, appunto), mentre sugli schermi di oggi scorrono le immagini delle guerre. Ieri, in Verne, i “selvaggi” di Papua fulminati dalla corrente mentre cercano di introdursi nell’inaccessibile Nautilus. Oggi, a Kabul e Teheran, a Damasco e Gerusalemme, il fanatismo trionfante.
Da ragazzo amavo Verne, che preferivo a Salgari. Leggevo versioni asciugate e ridotte dei suoi romanzi, che trattenevano l’essenziale delle molte descrizioni: il dugongo, il lamantino, il narvalo. «Che stile Jules Verne, nient’altro che nomi» commentò Apollinaire, e aveva ragione. Ventimila leghe sotto i mari è avventura e catalogo, le traversie e i prodigi del mondo di sotto e, assieme, il compendio delle “meraviglie della scienza e della tecnica”, pagine e pagine con elenchi di pesci, alghe, navigatori, scoperte. Fascino e noia mano nella mano.
La storia è nota: convinti di dare la caccia a un immenso cetaceo, le marinerie di mezzo mondo si mettono sulle tracce di quello che si rivelerà il sottomarino Nautilus creato e assemblato – anche questo viene spiegato nel dettaglio – dal misterioso capitano Nemo. Per il quale il mondo non esiste più da quando si è immerso, e che nel suo “mobilis in mobile” vive circondato da compagni devoti che parlano una lingua misteriosa. Ha una libreria ben fornita – dodicimila volumi, come precisa con puntiglio –, inestimabili capolavori d’arte, invenzioni futuribili che lo aiutano, un organo dal quale cava melodie strazianti;e trae cibo bevanda vestiario e piccoli piaceri – il fumo – soltanto da quel che il mare gli offre.
A bordo del Nautilus il capitano Nemo accoglie il naturalista professor Pierre Aronnax, il suo domestico fiammingo Conseil (“Come piacerà al signore”) e il fiociniere canadese Ned Land. Gli intellettuali e l’uomo d’azione, i riflessivi e l’impulsivo, piccole macchiette semicomiche e niente più. Erano sulla nave americana Abraham Lincoln che ha tentato di “catturare” il Nautilus ed è stata speronata. Sbalzati in mare, vengono salvati da Nemo e dai suoi. E assieme a lui gireranno il mondo: la Polinesia e lo stretto di Torres, Ceylon (qui Nemo salverà un povero pescatore di perle aggredito da uno squalo e gli farà dono di un sacchetto di perle, rendendolo ricco: «Quell’indiano, signor professore, vive nel paese degli oppressi; e a un simile paese io appartengo ancora e apparterrò fino all’ultimo respiro»), un tunnel che corre sotto il canale di Suez non ancora completato, Atlantide e il Polo Sud, il Mare dei Sargassi e il terribile maelstrom dei mari del nord che consentirà ai prigionieri di riacquistare la libertà.
Il capitano Nemo è un eroe byroniano, un prometeide, un “superuomo di massa” per dirla con Umberto Eco: pensatore e uomo d’azione, scienziato e vendicatore. Nel corso del romanzo sarà di volta in volta cortese, erudito, inflessibile. Piangerà almeno due volte, come il Corsaro Nero di Salgari, per un compagno morto e per la sua famiglia sterminata da un’innominata potenza alla quale ha giurato odio eterno e della quale affonda una nave con il suo equipaggio. Inglesi con ogni probabilità, come lo era il Rajah bianco avversario di Sandokan: il capitano Nemo, apprenderemo nel successivo L’isola misteriosa che ce lo presenta anziano, invisibile e ubiquo protettore dei naufraghi protagonisti, è il principe indiano Dakkar. Occidentalizzato e amante dell’Occidente, non dell’Inghilterra. Un primo ribelle, una prima incrinatura nelle certezze dei padroni del mondo.
Alberto Vigevani, Milano ancora ieri, Sellerio, 2012
Alberto Vigevani (1918-1999) è stato un narratore più che garbato e da riscoprire (Estate al lago lo lessi da ragazzo nell’edizione Feltrinelli, adesso si può trovare presso Sellerio che ha ripubblicato i suoi libri maggiori). Nonché il fondatore, nel 1941, del Polifilo, la più importante libreria antiquaria di Milano, tuttora attiva. E il gestore della Ricciardi, che aveva sede proprio accanto alla sua libreria quando venne trasferita da Napoli a Milano, per conto del banchiere-mecenate Raffaele Mattioli (la collana dei classici italiani, ristampata da Einaudi, è un monumento dell’editoria del Novecento). Questo cordiale volumetto dedicato a “luoghi, persone, ricordi di una città che è diventata metropoli” venne pubblicato in prima edizione da Marsilio nel 1996.
Procedendo per elencazioni e accumuli minuziosi, Vigevani rende omaggio a una civiltà borghese che fu anche la sua e che oggi è, o sembra, scomparsa. Scorrono, pagina dopo pagina, i giardini segreti del centro patrizio (i «giardini chiusi, a pena intraveduti» di D’Annunzio) e i giardini pubblici con la sfilata delle tate e la banda dei tramvieri. Le scarse ville della città (l’aristocrazia meneghina edificava in Brianza e presso il lago di Como). Memorabili però come Villa Simonetta «con le sue cinquanta eco che Stendhal sperimentò tirando un colpo di pistola». Le botteghe e i mercati filtrati da memorie letterarie (Dossi che ricorda «l’amore gentilizio dei milanesi per i salumai»; Carlo Linati – altro scrittore di limpida prosa che andrebbe riscoperto, fu tra i primi a tradurre Joyce – che rievoca le bancarelle del Verziere e cita Carlo Porta: «Ed i tordi più di trenta / in lardosa maestà / stavan lì sulla polenta / come turchi sul sofà»). I luoghi della moda prima che arrivassero gli stilisti, le sartorie.
Descrizioni affettuose e dense di nostalgia ben temperata (la Galleria De Cristoforis, distrutta nei bombardamenti della seconda guerra mondiale, ricordava secondo Vigevani le arcades londinesi e i passages parigini che avevano incantato Walter Benjamin).
Ma Milano ancora ieri si raccomanda soprattutto per le rievocazioni del milieu culturale: i caffè letterari degli anni Trenta-Quaranta (spesso modesti bar e offellerie, a volte contigui ai bordelli), le librerie, le case editrici. Appunti densi e importanti per una storia editoriale di Milano che (è Vigevani a sottolinearlo) andrebbe scritta. Sfilano Guttuso con una contessa bistrata e incipriata, Piovene messo al bando per i suoi attacchi a Eugenio Colorni che verrà poco tempo dopo ucciso dai fascisti, Carlo Bo con Marise Ferro, Vittorio Sereni, Sergio Solmi e decine d’altri. Sfilano, assieme alle persone, le case editrici di allora: Alpes che aveva in catalogo soprattutto letteratura di viaggi (ma pubblicò Rilke e Gli indifferenti di Moravia e si diceva appartenesse ad Arnaldo Mussolini, che la faceva gestire a un prestanome), Slavia di Alfredo Polledro che fu la prima a proporre versioni accettabili dei russi (il catalogo confluì in quello Einaudi), la Modernissima di Gian Dauli che precedette Mondadori nel presentare ai lettori italiani autori come Chesterton, Mann, Conrad, Schnitzler, Dos Passos, Thornton Wilder, Zweig e Döblin.
Gran bel personaggio Gian Dauli (era lo pseudonimo del veronese Giuseppe Ugo Nalato, 1884-1945). Editore ardimentoso e sfortunato, il cui catalogo fu in seguito a un fallimento rilevato da Corbaccio-Dall’Oglio, cercava di far quadrare i conti dei suoi libri raffinati curando “libri da bancarella” per il tipografo anarchico Lucchi: Jack London, Alexandre Dumas (ai Dumas di Lucchi, scovati dai bouquinistes, ho attinto anch’io), Carolina Invernizio. E scrittore stimato da Borges: un suo romanzo fu accolto nella Biblioteca blu che l’argentino curò per Franco Maria Ricci. Nonché traduttore instancabile e bravo (il suo Stevenson per me fa ancora testo) di Maugham, Galsworthy, Hardy e molti altri.
Gian Dauli non è solo nella galleria dei ritratti memorabili. Merita la citazione almeno Carlo Emilio Gadda, «ingegnere d’aspetto fino alla punta del naso polputo che troneggiava arcimboldescamente, come una pera o una melanzana, tra gli occhi un po’ da gufo nel volto ovale, se si toglie l’accentuata rientranza del mento. Vestiva come gl’ingegneri lombardi, corpo plasmato dal Politecnico, e il cui modello in fatto di abbigliamento era l’aristocrazia della Edison e sue consociate: sempre grisaglie scure col gilè accollato e i calzoni che si afflosciavano in pieghe sopra i polacchini neri mai troppo lustri, che sarebbe stato segno di fatuità». Al Gran Lombardo Vigevani dedica, sparse tra i capitoli, pagine assai vivaci.
Ma il Personaggio di questo libro è Enrico Noseda, fotografo dilettante del quartiere Magenta nella seconda metà dell’Ottocento, quando era “borgo” e non aveva ancora acquisito la sua fisionomia parigina (le immagini di Noseda, equivalente milanese del conte Primoli a Roma, vennero raccolte da Linati in un prezioso volume per Longanesi). Discendente di setaioli comaschi, “di professione benestante” com’era scritto nel suo passaporto, visse di rendita per novant’anni, dal 1842 al 1931. «Ma se Enrico si faceva vestire a Londra e mandava a stirare le camicie, naturalmente di seta, a Parigi, e se teneva in cantina i migliori crus di Francia (…) compì tuttavia la sua figura di buon borghese lombardo, seguendo, nel 1866, Garibaldi fino a Bezzecca, ma, da stravagante com’era, con la scorta di due domestici, di una piccola scuderia e, immagino, di qualche cesta di buone bottiglie».