Si addentra in molteplici oscurità – dai sentimenti del sud degli Stati Uniti, alle strade di città viste dalle vite ai margini all’eterno incandescente dei rapporti familiari e amorosi – la rubrica settembrina dedicata alle letture. E almeno due recenti uscite hanno meritato l’applauso dell’autore: scoprite quali
Ritorna la rubrica delle mie letture correnti, dopo la pausa estiva. Libri recenti e recentissimi, ma non solo. Gorczyca, D’Eramo, Verna, Cassar Scalia, Voltolini, Franchini, Wodehouse. E qualche repechâge: Pollack, Cortázar. E Stefan Zweig che sto rileggendo sistematicamente e del quale ogni mese proporrò un’opera.
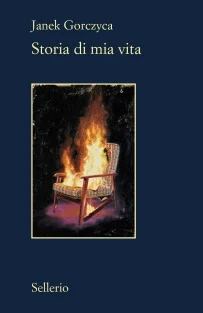
Janek Gorczyca, Storia di mia vita, Sellerio, 2024
«Questo sarà un breve racconto di mia esperienza sulla vita per la strada. Tutto comincia nel 1998 di ottobre, io sto in una stanza a Campo dei fiori, contratto di lavoro scaduto, permesso di soggiorno uguale, ho un milione e mezzo di lire in tasca, e penso come riprendere tutto, ma non è facile».
Comincia così l’asciutto memoir del polacco Janek Gorczyca, classe 1962, in Italia dagli anni ‘90. Senza un contratto regolare e senza fissa dimora, soltanto lavori in nero e alloggi provvisori. In strutture occupate, a casa di amici e conoscenti, a volte all’addiaccio.
Caso letterario del momento con molte buone ragioni. Intanto perché è scritto in italiano – non è Conrad, va da sé – da chi l’italiano lo ha appreso in ‘vita per la strada’, senza frequentare corsi e scuole. Poi perché il suo è un italiano icastico e, pur nelle approssimazioni, scorrevole ed efficace, con un suo ritmo e una sua musica. Con un suo stile. Infine perché quella di Gorczyca è una narrazione senza fronzoli, attenta ad asciugare e sottrarre più che ad aggiungere e infiorettare. Priva di introspezioni e psicologismi – in Storia di mia vita le cose accadono e basta – e poco incline all’autoindulgenza o al vittimismo.
Non è colpa della società, qui, se un’esistenza è allo sbando, se una vita è vivere alla giornata. (E, va da sé, è anche colpa della società: dei padroncini che lo fanno lavorare quattordici ore al giorno senza mai metterlo in regola; del Comune che promette alloggi e si limita a chiudere un occhio quando i senzacasa occupano; di poliziotti e carabinieri che, per quanto non si comportino da carogne, fanno controlli e retate continue senza un vero perché). Per l’impavido Gorczyca è andata così, semplicemente. Forse addirittura se l’è cercata. «A distanza di anni mi domando che cosa mi ha spinto a fare questa scelta difficile. Sentimenti? Ne ho pochi. Carattere ribelle? Mancanza di senso di responsabilità? Più probabile voglia di vita un po’ sbandata».
Sarà davvero così? Nato in una famiglia contadina, saldatore e operaio nelle centrali elettriche polacche, in una centrale nucleare in Russia ai tempi di Chernobyl – e intanto fa contrabbando, e intanto si è sposato con una russa che lo abbandonerà – per faide di famiglia Gorczyca perde tutto e tronca ogni rapporto con i suoi. Arriva in Italia e fa il fabbro. Recinzioni, inferriate, cancellate, porte scorrevoli. Alle dipendenze di un padroncino, qualche volta in proprio. Pagato alla giornata, a settimana. Per anni, vive in una struttura occupata a Montesacro: la villa che fu del gerarca Roberto Farinacci, già sede sgomberata di un centro sociale.
Ci vive, l’individualista che si dichiara quasi privo di sentimenti, facendo il capopopolo. Degli altri immigrati dell’Est che si sono uniti a lui nell’occupazione, dei giovani italiani strafatti che lì si rifugiano. Gestisce il gas e l’acqua, trova cibo e lavoretti, cura i rapporti con il quartiere facendosi amici, con le organizzazioni assistenziali dalle quali arrivano aiuti sussiegosi e carità pelosa. E tratta con le forze dell’ordine perché è l’unico in grado di parlare un italiano decente.
La vita di strada non è un paradiso: ci sono liti e scazzottate tra lui e i compagni d’avventura, gelosie e furti e sciatterie. E tante bevute, l’alcool in queste pagine scorre a fiumi: birra, vino, vodka. Gorczyca ha un serio problema d’alcolismo, in anni più recenti entra ed esce dagli ospedali, tenta la disintossicazione, ogni tanto ci ricasca, oggi il bere è sotto controllo.
La vita di strada non è un paradiso ma c’è l’amore per la connazionale Marta, protetta e accolta, qualche volta respinta o picchiata – lui va al commissariato ad autodenunciarsi – ma accudita per 25 anni con dedizione sino alla morte di lei per tumore. «Qui voglio finire mio racconto, perché ho sofferto troppo».
Scritto durante il lockdown – quaderno dopo quaderno, in stampatello – a casa dello scrittore Christian Raimo che lo ospitava, trascritto e fatto girare per le redazioni, anticipato per qualche parte da una rivista di Goffredo Fofi, Storia di mia vita è diventato libro per scelta saggia di Sellerio, che ne ha colto il valore.
Di stile – irregolare, ma affascinante e coinvolgente, l’ho già detto – e di testimonianza. Perché ci offre un mondo che sta a due passi da noi – i clochard che dormono sopra un cartone, quelli che chiedono l’elemosina, i ragazzi che in bicicletta ci consegnano i pasti a domicilio, le donne che fanno pulizia nelle nostre case e assistono i nostri anziani – e che noi anime belle ci sforziamo di non vedere.
Un’operazione artefatta, per ‘costruire’ il caso, come qualcuno ha sospettato? A me non sembra. Se editing c’è stato – faceva editing anche Ezra Pound con T. S. Eliot – è stato leggero, qualche frase raddrizzata, soprattutto i caratteri speciali aggiunti agli impronunciabili cognomi e toponimi polacchi.

Marco D’Eramo, I terroni dell’impero. Viaggio nel profondo Sud degli Stati Uniti, Marietti1820, 2024
“Il sud ha perso la guerra ma ha vinto la pace” è una battuta che si sente spesso negli Stati Uniti.
Da oltre vent’anni il sud, oltre che una roccaforte conservatrice, è il nuovo centro di gravità permanente della nazione. Qui accorrono le corporation, anche europee e giapponesi, attratte da un paradiso di illimitata libertà padronale: incentivi vertiginosi (in Alabama quelli per la Mercedes erano il 10 per cento del bilancio statale), zero libertà sindacali, ferie non pagate e nessun congedo di maternità. Marco D’Eramo, giornalista e saggista dallo sguardo acuto, è stato a lungo corrispondente dall’America per il Manifesto. Oggi raccoglie i suoi reportage illuminanti sul profondo sud degli States, scritti tra la fine degli anni ‘90 e il 2005, in un libro che si beve d’un fiato, e che correda la vivacità delle narrazioni con un’impressionante serie di dati.
I 200 mila bianchi che nel South Carolina celebrano i funerali con gli onori militari di otto marinai sudisti affondati nel 1864: come se da noi onorassero con una cerimonia pubblica i resti di soldati borbonici. I casino per i poveri cristi gestiti dai cherokee. Quel che resta della Tennessee Valley Authority, punta di diamante del new deal rooseveltiano, oggi fortemente ridimensionata. L’integralismo religioso (a Chattanooga, su un quotidiano locale, D’Eramo trova quattro pagine con le funzioni religiose della settimana in 500 chiese). Gli atenei neri della Georgia dove alligna un separatismo da “svantaggio nello svantaggio”. Miami nuova capitale dell’America Latina, una metropoli che deve le sue fortune a Fidel Castro. La Louisiana che, dopo l’uragano Katrina, ha visto la colpevole mancata ricostruzione di New Orleans e il tentativo di espellere i neri poveri dalla città.
Nell’America di oggi, dice D’Eramo, il razzismo è riemerso più forte che mai, assieme al suprematismo bianco. Con l’alibi offerto nel 2008 dall’incolpevole Obama (“Come potete dire che siamo razzisti se abbiamo eletto un presidente nero?” è il sottotesto di molte violenze). Un libro che sfata, senza nessun proclama e molti fatti, i luoghi comuni sull’impero e sul sogno americano: una casetta di legno nei sobborghi con un praticello striminzito davanti.

Martin Pollack, Il morto nel bunker. Indagine su mio padre, traduzione di Luca Vitali, Keller, 2018
«All’inizio dell’estate del 2003, insieme a mia moglie, intrapresi un viaggio in Sudtirolo, fino al Brennero, per cercare il bunker nel quale cinquantasei anni prima mio padre era stato trovato morto. Gli avevano sparato. Volevo saperne di più sulle circostanze della sua scomparsa e sui motivi che lo avevano spinto a recarsi in Sudtirolo. Per anni avevo esitato a svolgere queste indagini, forse per un inconscio timore di imbattermi, seguendo le sue tracce, in scoperte che avrebbero superato le mie aspettative, senz’altro già cupe. Di una cosa, però, ero convinto fin dall’inizio: la sua morte violenta era la conclusione di una vita in cui la violenza aveva giocato un ruolo di primo piano».
Il nazismo della porta accanto. Non quello dei ‘mostri del male’ che torturano i prigionieri con le corde del pianoforte mentre in sottofondo suonano Schubert; piuttosto quello dei piccoli e medi burocrati, più prossimi e non meno efferati, ma più decifrabili. Della ‘banalità del male’.
Nato nel 1944 a Bad Hall, nella montuosa Stiria dove l’Austria confina con la Slovenia, cresciuto da un patrigno che gli ha dato il cognome, Martin Pollack va in cerca di un nazista, il «dr. Gerhard Bast, Sturmbannführer delle SS, nato il 12 gennaio 1911 a Gottschee, in Jugoslavia, residente a Amstetten, nell’Austria inferiore. Era ricercato dalla direzione della polizia federale di Linz in quanto criminale di guerra, poiché era stato a lungo a capo della Gestapo di Linz. Mio padre».
Un padre che non ha conosciuto, del quale non conserva ricordo, del quale ha distrutto in un impeto di furore giovanile – era allora un militante di sinistra – l’unica lettera ricevuta. Il nazismo della porta accanto, dicevamo. Che ci rende più facile leggere il ritorno dell’ultradestra in Europa, e anche le risse i rancori e gli sgambetti tra le fazioni della destra: oggi in minore Lega e FdI, ieri i cristiano-corporativi di Dollfuss e i nazionalsocialisti messi fuorilegge.
All’origine c’è una stirpe di avvocati. Tanto ‘normale’ nella vita familiare e negli affetti – il piccolo Pollack viene cresciuto da nonni amorevoli tra dolcetti e richiami patriottici, elogi della caccia e degli sci e verdura e frutta dell’orto – quanto nazista senza pentimenti nel dopoguerra austriaco che inclina all’oblio e chiude gli occhi sui trascorsi di troppi. Una famiglia che all’odio non dismesso per gli ebrei ha aggiunto quello per gli americani, ‘porci’ come loro. E per i sovietici che hanno occupato a lungo la loro casa.
All’origine c’è un’identità da ‘tedeschi di frontiera’ assediata, dicono loro, dagli slavi inferiori e bellicosi. E difesa con l’esaltazione della lingua e della tradizione, con la fascinazione di un pangermanesimo aggressivo e antisemita, con gli scontri sempre più cruenti con gli sloveni, con il rancore crescente nei confronti dell’impero asburgico e del suo ‘melting pot’. L’anschluss, l’inglobamento dell’Austria nella più grande Germania realizzato da Hitler, è rivendicazione dei nazionalisti austriaci già all’inizio del secolo.
Ci si barrica in un esclusivismo localistico, fatto di grandi bevute e pantaloni in pelle e associazioni piccole e grandi, richiamo della montagna e della caccia, rituali barbarici in uso anche in Germania – i duelli all’arma bianca fra studenti universitari che dalle cicatrici sul volto ricevute traggono motivo di vanto. Il rifiuto dell’altro, ieri come oggi.
Aderiranno al nazismo i Bast, avvocati tanto fanatici quanto affaristi, perché il nazismo è anche occasione per fare carriera. E Gerhard Bast, padre dell’autore, scalerà i gradi della Gestapo, impiegato in Austria e in Germania, in Slovenia e in Russia. Boia di prigionieri polacchi e rastrellatore di ebrei, dipinto dalle rare testimonianze ora come sadico spietato e ora come incline a una più mite misura, a un occasionale lasciar correre. Nel dopoguerra, inseguito da un mandato d’arresto, sarà latitante per qualche anno e, bracciante in una fattoria del Sudtirolo, mentre è in procinto di varcare la frontiera per rientrare in Austria – vorrebbe espatriare in Canada con una falsa identità – viene ucciso da un contadino che cerca di derubarlo.
In questo doloroso corpo a corpo con i fantasmi, con una documentazione distrutta o dispersa, con la rimozione e l’azzeramento dei ricordi praticata in famiglia, Pollack tallona l’orrore del nazismo – in fieri, in essere, in immersione dopo la sconfitta. E ricostruisce la pratica quotidiana dello sterminio, quella catena innumere di sopraffazioni quotidiane e di quotidiane uccisioni che, nella contabilità generale, diventano il bagno di sangue. Lo fa senza impennare il tono narrativo, senza alzare la voce, senza nascondere gli affetti intimi, ma senza tacere niente.
Martin Pollack, slavista e traduttore del polacco – è lui che ha fatto conoscere Kapuściński nel mondo tedesco – è scrittore affascinante quanto necessario. Io l’ho scoperto a Trieste, acquistando nella libreria del Caffè San Marco il suo Galizia (Keller, 2017), splendido baedeker storico e sentimentale di una propaggine estrema dell’impero asburgico oggi divisa tra Polonia e Ucraina – la patria di Joseph Roth e di Bruno Schulz, Leopoli proprio in questi giorni bombardata dai russi – e riscoperto quest’estate grazie alle letture comuni con la mia compagna Cristina. Continuerò a frequentarlo. Scrive Claudio Magris che Il morto nel bunker è un piccolo gioiello, sottoscrivo.

Nicoletta Verna, I giorni di Vetro, Einaudi, 2024
«-Com’è che non piange? – chiedeva la sera mio padre. -Piangerà. Prima o poi le donne piangono tutte».
Redenta è nata nel 1924, il giorno in cui hanno ucciso Matteotti. A Castrocaro in Romagna, non lontano da Predappio. È la prima viva tra i figli della volitiva Adalgisa e del fascista e buono a niente Primo: l’hanno preceduta tre fratelli nati morti che torneranno a dialogare con lei nel sogno e nella veglia, la seguiranno due sorelle.
È nata con la scarogna, Redenta, e temono che non sopravviva. Ma sopravviverà, anche quando la polomielite la lascia sciancata. «Non avrà fortuna, però avrà pietà» le pronostica il guaritore-stregone Zambutèn. Crescerà con la nonna ostetrica Fafina e con la tribù di orfani che la donna si tiene in casa. A uno di loro, Bruno, dotato di un istintivo senso della giustizia pronto a tramutarsi in rabbia e ribellione, Redenta si affeziona. Ma Bruno scompare, e Redenta si troverà sposa del brutale gerarca Vetro al quale l’ha venduta il padre, un Barbablù da fiaba crudele che la sevizia come tortura nemici e partigiani.
Siamo negli anni della dittatura, in questo romanzo dallo stile crudo e brutale per un tempo feroce e assassino. Redenta ha momenti di tregua soltanto quando il marito è altrove. «Respiravo nelle disgrazie e nel sangue degli innocenti, nei supplici che infliggeva giù alle Casermette, e avevo vergogna di questo sollievo. E allora capivo una verità cattiva: che il più delle volte, se noi stiamo bene non è per merito o per virtù, ma solo perché a qualcun altro tocca stare male al posto nostro».
Feroce e animalesco il mondo contadino, feroce e sopraffattore il fascismo, ferocissimo l’ultimo atto della dittatura (proprio al Grand Hotel di Castrocaro nasce la Repubblica di Salò), con lo psicopatico Vetro che dà la caccia al misterioso comandante partigiano Diaz e cattura la maestrina Iris, alla quale hanno sterminato la famiglia e incendiato il paese, e che tra i partigiani ha scelto la missione – eroica quanto azzardata – di infiltrarsi tra i fascisti per carpire i loro segreti. Seviziata e lasciata per morta da Vetro, Iris viene salvata dalla mite Redenta che alla fine farà giustizia, per amore e per pietà.
Un plot saldissimo, uno stile magistrale che impasta e raggruma anche un dialetto romagnolo insolitamente aspro, un’incursione nella ferocia contadina che ricorda i piemontesi (il primo Pavese, il Fenoglio della Malora), una meditazione alta sulla guerra non immemore di Elsa Morante, I giorni del Vetro nella sua ricostruzione della barbarie fascista (le stragi raccontate sono tutte vere, la nota finale ne dà conto) ha accenti tutti attuali nel raccontare la barbarie maschile.

Cristina Cassar Scalia, Il castagno dei cento cavalli, Einaudi, 2024
Sono donne volitive e non pacificate le protagoniste più seguite (anche in televisione) del giallo italiano dell’ultimo decennio. Un giallo-commedia del quale un critico illustre, Cesare Cases, lodava in tempi non sospetti il “genio mediterraneo”. Sulla scia della Petra Delicado inventata da Alicia Giménez-Bartlett, anch’essa approdata al piccolo schermo con Paola Cortellesi, abbiamo avuto la Lolita Lobosco di Gabriella Genisi e la Imma Tataranni di Mariolina Venezia. E soprattutto il vicequestore Vanina Guarrasi, palermitana trapiantata a Catania, brusca e mangiona, cinefila e incasinata, ma capace come pochi di sbrogliare indagini ingarbugliate. Creata da Cristina Cassar Scalia, medico oftalmologo, originaria di Noto e anche lei trapiantata a Catania, l’unica scrittrice in grado di raccogliere l’eredità di Camilleri e del suo Montalbano.
Single non per vocazione, Vanina ha una storia tormentata con il pm Paolo Malfitano che ha salvato da un agguato mafioso. Ma fugge da lui come da Palermo – prima di scegliere la omicidi era in forze all’antimafia – perché entrambe, l’uomo e la città, le ricordano l’assassinio del padre poliziotto. Tenace nel suo lavoro, spiccia e brusca con gli arroganti e i leccapiedi (l’agente Lo Faro), tuttavia empatica e amichevole (con il commissario in pensione Biagio Patané, con la vicina di casa Bettina che la rifocilla, con gli uomini della sua squadra). Disordinata negli orari, nel sonno, nel rapporto con il cibo (non sa cucinare ma adora mangiare, ed è una festa di involtini e arancine, raviole e scacce, stavolta compare anche il panino Camogli degli autogrill), ha una passione per i vecchi film d’autore italiani che guarda assieme al medico legale Adriano Calì.
Nell’ultimo dei suoi romanzi, diventati serie tv per Canale 5, la vittima è una donna misteriosa e di poche o nessuna frequentazione. La chiamavano la Boscaiola, cercatrice di funghi, venditrice di ortaggi e uova, occasionale guida degli escursionisti sull’Etna. La trovano morta sotto un albero monumentale, il castagno dei cento cavalli censito dall’Unesco fra i patrimoni dell’umanità. Uccisa in maniera orribile: strangolata, il ventre squarciato, le mani e i piedi spiccati dal corpo. Seguirà una seconda vittima, una casellante autostradale eliminata con le stesse modalità. Delitti che vengono da un passato che non è lecito rivelare, con un assassino insospettabile, e tuttavia, mentre Vanina Guarrasi sembra cominciare a far pace con Palermo (nella sua casa alle falde dell’Etna si è rifugiata per qualche mese la sorellastra Cocò che ha mandato all’aria il fidanzamento), la soluzione arriva puntuale. Sempre più scaltrita nella gestione del plot e dell’affollato parterre di comprimari e comparse, Cassar Scalia, parola di un consumatore seriale di gialli, si aspetta come un appuntamento irrinunciabile e si legge con piacere crescente, storia dopo storia.

Filippo Tuena, Il volo dell’occasione, Terrarossa, 2023
«Non era un antiquario. Piuttosto un rigattiere. Non fa molta differenza, comunque. Ma era un rigattiere, so riconoscere il tipo: giaccone largo di pelle nera, rovinato ai gomiti; pantaloni di velluto a coste, gualciti, con l’affossatura alle ginocchia; capelli unti; modi bruschi ma sottomessi. E i soldi tenuti assieme da un elastico, che rigonfiano la tasca interna del giaccone.
Grandi pagatori, vanno sempre di fretta e non c’è bisogno di blandirli. I migliori. Fanno affari e li fanno fare a te. Non occorre mentire, non occorre recitare. Sanno quello che vogliono. Ma non devi incontrarli a un’asta».
In rue Drouot, a un’asta, va in scena la contesa che oppone un rigattiere a un uomo distinto sulla cinquantina, che perde forfora e sa d’aglio, pernod e muffa. I due si disputano un brutto orologio da tavolo art déco. «Il quadrante ovale era laccato bianco, con la cornice e i numeri di ottone dorato. Il vetro era incrinato e le lancette ferme alle ore 12. Il corpo dell’orologio era in alabastro verdino e una donnina in bronzo, un po’ sbilenca e goffa, vi saltellava sopra, con le braccia lunghe lunghe e le gambe sottili sottili. Il viso allungato ma le labbra carnose. Forse l’artista si era ispirato a Joséphine Baker».
Vince l’asta il forforoso, un contrabbassista jazz che si chiama Renant. Come re(ve)nant. Uno spettro, l’autore di un delitto che si è consumato il 18 marzo 1948, data non più aggiornata sotto il quadrante dell’orologio. In una Parigi anni ‘90 che nel romanzo di Tuena è ancora la capitale di tutti i nostri miti giovanili, con i suoi passages e i suoi bistrot, recita un insolito trio: il musicista; Blanche, la diciottenne bellissima e spregiudicata di cui è innamorato; e il turco ricco e arrogante, Altay, che di Blanche è l’amante in carica. I tre si inseguono in litigi e scenate, l’orologio d’alabastro scompare e riappare, diventando infine arma del delitto. E il trio diventa quartetto quando l’io narrante del romanzo cerca di infrangere la barriera del tempo, di ritornare in quel 1948 funesto, per avere Blanche e sottrarla al suo destino.
Romanzo di assoluta scorrevolezza ma coltissimo (Tuena ammette fra le suggestioni il Paul Auster della Trilogia di New York, Borges e il Bioy Casares dell’Invenzione di Morel, assieme alla Donna che visse due volte di Hitchcock), Il volo dell’occasione è meditazione sull’eterno ritorno e insieme struggente constatazione che tutto ritorna ma come separato da un muro invisibile, da una lastra insuperabile, che l’occasione sprecata è irripetibile. E propone per la prima volta il tema della variazione che sarà cifra peculiare del suo narrare.
Il romanzo uscì nel 1994 per Longanesi, venne riproposto nel 2004 da Fazi e ora ritorna con la meritoria riedizione dell’editore pugliese Terrarossa. Quando apparve, Corrado Augias lo salutò come un piccolo capolavoro. Condivido, per me è la più bella storia di fantasmi del ‘900 italiano, assieme a I pomeriggi del sabato di Antonio Tabucchi e a Ti trovo un po’ pallida di Carlo Fruttero.
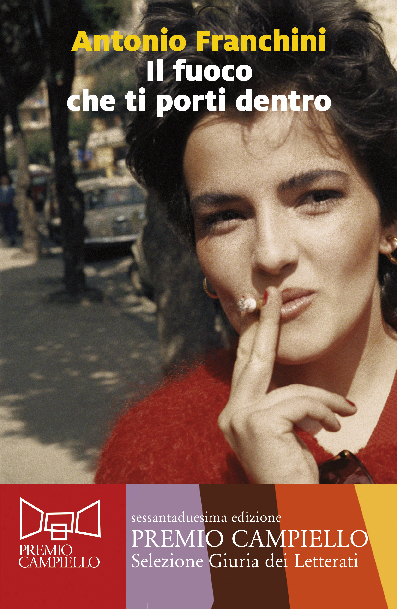
Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio, 2024
“Mia madre puzza”, l’incipit di Il fuoco che ti porti dentro, è di quelli proverbiali, che catturano e non si scordano. Un personaggio straripante, in America dicono larger than life: Angela Izzo, madre borghese dell’autore – il padre è un compassato commercialista bibliofilo – con l’anima della popolana attaccabrighe. Una vajassa dei quartieri alti, un vulcano che erutta lava e rancore, che attraversa la vita come un litigio ininterrotto, l’amore come un mandarsi al diavolo, l’amicizia come un sentimento da scansare. «Angela odia sia per differenza sia per affinità, e per affinità, come è in genere naturale che accada, odia ancora più intensamente».
Il familismo amorale, il privilegiare la propria piccola cerchia ignorando la comunità e la società, categoria coniata negli anni ‘50 dall’americano Edward C. Banfield per il nostro Meridione è se non l’ideologia almeno l’umore, il ‘sentimento’ che impregna Angela e le donne come lei. Scrive Franchini: «Uno scrittore napoletano mi raccontò che un giorno sua madre aveva visto l’altro suo figlio assai preoccupato, e gli aveva chiesto che cos’avesse. Il giovane le aveva confessato di aver messo incinta una ragazza. La madre con molta naturalezza lo confortò: “E tu dici ca nun è ‘o tuoio…”. Non credo che mia madre e quella di colui che mi raccontò questa storia avessero molti altri punti di contatto, ma quando alludevo all’analogia tra l’amoralità di certe famiglie e quella delle organizzazioni criminali mi riferivo a episodi simili».
Senza sociologismi ma con esattezza chirurgica nell’individuare le parole e i vaniloqui del luogo comune e i comportamenti dettati dall’asocialità quotidiana, Franchini affonda il bisturi nella mediocrità piccolo-borghese. Che considera gli uomini tutti fetenti – ma le donne sono tutte zoccole – e nell’amicizia vede «una forma di dipendenza, di indebolimento della personalità». Che ammira l’uomo forte e l’uomo della provvidenza: ieri “Musulino”, oggi Putin. L’esclusivismo materno, con Angela, è una colata di fango che schiaccia e soffoca: «L’altra massima era: chi ti vuole più bene di mamma t’inganna». Eccole qui, le suocere contro le nuore delle barzellette, ma dietro c’è un rancore da lesa maestà che ulula.
La ribellione di chi scrive è, in questo caso, a un mondo più che (oltre che) a una persona: «Ne detesto il qualunquismo, il razzismo, il classismo, l’egoismo, l’opportunismo, il trasformismo, la mezza cultura peggiore dell’ignoranza, il rancore, il coacervo di mali nazionali che lei incarna in blocco, nessuno escluso, al punto da essermi convinto che se c’è una figura simbolo degli orrori d’Italia, una creatura di carne e ossa che tutti li racchiude, questa è Angela, mia madre».
La madre rancorosa di tutta la vita. La madre indifesa, rattrappita e imbozzolata nella vecchiaia, che il figlio risarcisce con una gita in montagna che per un giorno la pacifica e la rende felice. Atto d’amore sotto forma dell’atto d’accusa, cupo grottesco napoletano come certo Eduardo e, al tempo stesso, orazione civile non intenzionale, Il fuoco che ti porti dentro è un romanzo memorabile e destinato a restare.

Dario Voltolini, Invernale, La Nave di Teseo, 2024
Un padre macellaio, che al mercato di Torino squarta agnelli, polli e conigli. Che ordina nuove bestie ai fornitori, perché a colpo d’occhio sa come andranno le vendite della giornata. E prepara quelle che ha in bottega, prelevando le carcasse dalla cella frigorifera e appendendole ai ganci. Poi, in un balletto di trincianti e ceppi, le trasforma in gigot, cotolette e bistecchine. Davanti al suo banco sono in molti ad affollarsi, «sembrano una versione insurrezionale della Borsa di Wall Street». Dall’altra parte macellai e garzoni si avvicendano e spesso s’intralciano, in un gioco di sezionamenti, pesate, pacchetti e scontrini. Un giorno quel padre concentrato e preciso fa una mossa sbagliata, urta o viene urtato, e il coltello quasi gli trancia un pollice.
Glielo riattaccano, ma un batterio si è insinuato nella sua carne. Il lento arretrare comincia con una spossatezza, con visite mediche prima vaghe e inconcludenti, poi sempre più mirate, fino alla diagnosi nefasta. A quel padre cacciatore e appassionato di calcio, affettuoso senza smancerie, dedito al lavoro e cautamente curioso del mondo, il ventenne Dario è legato da un’intimità pudica e intensa. Lo segue passo passo nel suo declinare e spegnersi, nella malattia affrontata con decoroso stoicismo, nei viaggi in Francia per curarsi, fino al “non c’è più niente da fare” e alla morte che lo coglie, poco più che cinquantenne, sull’ambulanza che lo riporta a casa.
Tutto qui, ma qui la morte di un uomo è la morte di tutti gli uomini, la sua vita è tutte le nostre vite. Invernale è, ai nostri giorni, non troppo distante da quello che La morte di Ivan Il’ic fu nell’800. Fa la differenza con la narrativa corrente l’esattezza millimetrica, come un taglio netto e preciso, nel rendere i fatti e le sensazioni, gli stati d’animo e le sfumature, in un romanzo che dà vita ad accadimenti e sogni e soffi di vento, rallentamenti e spaesamenti, piccole vertigini e minimi stupori. Fa la differenza uno stile che non ha bisogno degli acuti. Uno stile che è padronanza del mestiere (i capitoli iniziali hanno vertici virtuosistici, il finale commuove nel suo impietrimento) e tensione etica: seme di umanità che le storie devono possedere, fuoco che brucia nascosto. Per me con Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini l’opera migliore di questo 2024.

Julio Cortázar, Le armi segrete, traduzione di Cesco Vian, Einaudi, 2021
Cinque racconti con la botola. Con il doppio fondo. Con il passaggio segreto. Con la sorpresa, il ribaltamento, la metamorfosi, lo scarto finale, scegliete voi la definizione che preferite. Cinque racconti che mostrano e dimostrano al lettore la concezione che Julio Cortázar (1914-1984) aveva del fantastico in letteratura. Niente soprannaturale ed orrorifico, lo scrittore argentino detestava il genere, in particolare Lovecraft, anche se era stato un eccellente traduttore e studioso di Poe. Piuttosto un fantastico che nasce da una frattura improvvisa nella normalità, da una crepa che si apre nel quotidiano, da una voragine che si spalanca all’improvviso.
Un fantastico che è a volte dichiarazione perentoria dell’io narrante: «Proprio fra il primo e il secondo piano ho sentito che stavo per vomitare un coniglietto» (Lettera a una signorina a Parigi); «Ci fu un’epoca in cui pensavo molto agli axolotl. Andavo a vederli nell’acquario del Jardin des Plantes, e mi fermavo ore intere a guardarli, osservando la loro immobilità, i loro oscuri movimenti. Ora sono un axolotl» (Axolotl). Un fantastico che è a volte inversione dei ruoli, carta che si fa vita nella carta: il personaggio di un romanzo che va a pugnalare il lettore seduto in poltrona mentre sta leggendo il romanzo che ha il pugnalatore come personaggio (Continuità dei parchi). E a volte confusione e inversione tra un piano temporale e l’altro, fra una persona e un’altra, fra la veglia e il sonno.
Il racconto che tanti anni fa, sulla rivista Alterlinus diretta da Oreste del Buono, mi fece scoprire Cortázar, è un buon esempio di quel che cerco di dire: un motociclista ricoverato in ospedale dopo un incidente sogna, nel dormiveglia indotto dai sedativi, di correre nella foresta braccato dai guerrieri aztechi; e si sveglia sull’altare sacrificale, con ancora negli occhi le immagini confuse di un sogno in cui cavalcava un grande insetto di ferro. Il racconto è La notte supina.
Cortázar ha molto teorizzato sul “sentimento del fantastico”. Che a sua volta esige un ‘camaleontismo dell’universo’ in cui l’oggetto della narrazione abita un istante sul limite, che non è più là e non è ancora qui: come il camaleonte, appunto, mentre sta cambiando colore. Che chiede il sentimento del «non esserci del tutto in una qualsiasi delle strutture, delle ragnatele che prepara la vita e in cui siamo alternativamente ragno e mosca» (Giro del giorno in ottanta mondi).
Da questo sentimento straniato, lontano da un centro e forse incapace di accettarne l’esistenza, quindi propriamente eccentrico, nascono i suoi racconti. Quasi come una propaggine della sua fabula biografica. Come se uno che nasce a Bruxelles da un diplomatico e vi trascorre i primi anni, cresce a Buenos Aires, va esule volontario a Parigi dagli anni ‘50 in avversione al peronismo e diventa infine cittadino francese, ha consuetudine con i linguaggi di Babele perché di mestiere fa il traduttore per l’Unesco, ma resta scrittore tenacemente attaccato al castigliano, abbia iscritta nel destino la sua particolarissima vocazione di narratore.
Se la vicenda biografica ha qualche pretesa, il mestiere è il mezzo attraverso cui Cortázar media fra istinto e stile, improvvisazione e struttura data. Il paragone musicale è voluto: lo scrittore conosce e ama la musica classica e l’opera, ma soprattutto è critico competente e appassionato estimatore del jazz e dirà in un’intervista che questa musica, assieme a quella indiana, è «la sola che corrisponde alla grande ambizione del surrealismo in letteratura, e cioè alla scrittura automatica, l’ispirazione totale, che nel jazz corrisponde all’improvvisazione, una creazione che non è sottomessa a un discorso logico e prestabilito ma che nasce dalla profondità».
L’apprendistato e la disciplina, strano a dirsi per chi è refrattario alle regole del quotidiano per statuto poetico, sono in Cortázar ferree. La prima raccolta di racconti, Bestiario, è del 1951, quando l’autore ha trentasette anni e, alle spalle, una lunga attività di traduttore, saggista e poeta (e un romanzo lasciato nel cassetto e pubblicato postumo); questa raccolta, la terza, arriva nel 1959. E l’autocontrollo, la consapevolezza di sé, sono fortissime: il Cortázar che teorizza l’improvvisazione, il racconto come un take di jazz o come lo scatto di un fotografo, ha chiare (teorizzerà anche quelle) le tre regole per un buon racconto: significazione, intensità e tensione.
La significazione, per lui, equivale all’eccezionalità del racconto. Niente di insolito o di bizzarro, ma la capacità di rappresentare «una realtà più vasta del suo mero aneddoto». L’intensità è l’uso delle parole, meglio ancora delle frasi: non una di troppo, niente rallentamenti e punti morti. La tensione è il modo con cui il racconto mantiene una presa costante sul lettore il quale, anche senza sapere e capire come andrà a finire, non può sottrarsi alla sua atmosfera.
Mettiamole alla prova, queste teorie, esaminandone gli esiti. A partire dal racconto più normale, più tradizionale nella struttura e nello svolgimento, I buoni servigi. Una storia di finzioni. Madame Francinet, domestica a ore nelle case dei ricchi, viene chiamata da un’amica della sua padrona per dare una mano durante un ricevimento: dovrà stare chiusa in una stanza a sorvegliare i sei cani di madame Rosay. Assolto onorevolmente l’incarico e conosciuto alla fine della festa, in cucina, un ospite molto affabile e ubriaco, monsieur Bebé, verrà qualche tempo dopo chiamata a fingersi madre di lui, che è nel frattempo morto, nella veglia funebre e ai funerali.
Accettato l’incarico con qualche esitazione, Madame Francinet entra nella parte della madre apocrifa. Ma tutto il racconto, senza speciali effetti e slittamenti, è un gioco di apparenze e finzioni. Finge contegno e contiguità sociale, familiarità la plebea madame Francinet, il cui parlato da “mignolo in su all’ora del tè” dà il timbro, il colore al racconto. Fingono tutti i domestici, anzi il rito della finzione è essenziale al loro lavoro. Fingono i Rosay, soci borghesi e affaristi del sarto Bebé, che assecondano nelle loro feste quella che oggi si chiamerebbe ‘trasgressione’ ma nel rito pubblico (il funerale) temono lo scandalo.
E sulla reticenza (la lezione di Henry James: il narrare obliquo, lasciando zone d’ombra e punti oscuri nel racconto) è costruita l’immagine del defunto. Sarà morto di morte naturale? Per qualche eccesso? La sua morte ha a che fare con l’omosessualità, come le risse fra i suoi amanti potrebbero lasciar supporre? Eccoli, i personaggi al tempo stesso mosche e ragni. Il finale inatteso, qui, è che vada a finire tutto bene, quando si attende a ogni riga il temporale. E il tono inatteso è il grottesco, applicato a una veglia funebre. Ma siamo ancora alle prove generali.
Un passo avanti decisivo Cortázar lo compie in Lettere di mamma, ancora tradizionale nella struttura, per me il più bello e perfetto di questi racconti. Luis e Laura hanno lasciato Buenos Aires e vivono a Parigi da due anni. Una coppia felice, in apparenza. Ogni tanto arriva una lettera di mamma. Che parla del più e del meno e nelle ultime missive incespica in piccoli lapsus inquietanti, confondendo forse un nome con un altro ma, di fatto, richiamando in vita un morto, Nico. Fratello di Luis, che gli ha rubato la fidanzata Laura e, dopo la morte di lui per tisi, l’ha sposata. I due hanno lasciato Buenos Aires portandosi dietro il rancore muto del parentado. Per fare nuove esperienze, forse. Per fuggire, forse. Da allora di Nico non si è parlato più. Mai. E questa rimozione ha agito in profondità, come una presenza invisibile, minando il loro rapporto.
Che potrebbe rompersi del tutto quando mamma annuncia, dal suo delirio senile: “Nico sta arrivando in Europa”. Fino allo scioglimento ‘fantastico’, magistrale come un gioco di prestidigitazione, che avviene in tre frasi e quattro righe appena (niente anticipazioni, andatevelo a leggere o provate a immaginarlo). Qui le dualità in bilico sono tante: Luis e Nico, Luis e mamma, Luis e Laura, Buenos Aires e Parigi, il passato e il presente, la felicità e l’infelicità, la normalità e la crisi. E l’inferno familiare è reso in maniera discreta e allusiva ma sottile e profonda, come uno specchio d’acqua che nasconde le sabbie mobili.
Il limite estremo del racconto per così dire tradizionale Cortázar lo raggiunge con il lungo Il persecutore, quasi un romanzo breve. Il soggiorno parigino del genio del sax alto Johnny Carter, i suoi deliri, l’alcol e la marijuana, gli sbalzi d’umore. E il dialogo con il normale e affezionato Bruno, critico e suo biografo. Fino al ritorno a New York e alla morte. È un racconto di grande bellezza ma qui, per la prima volta, accade di vedere l’autore ‘al lavoro’: se ne percepisce lo sforzo narrativo, come di un atleta teso per saltare l’asta.
Manca, o meglio è offuscato, quello stile, per dirla con Mario Vargas Llosa, «che finge meravigliosamente l’oralità, la fluida disinvoltura del parlare quotidiano, l’espressione spontanea, senza abbellimenti né pretese dell’uomo comune». Non perché il parlato manchi, perché l’oralità sia assente, ma perché qui Cortázar sta cercando di sceneggiare e ridurre alla misura della cronaca l’indicibile, l’altro: l’orfismo dell’artista (l’espressione è di Ernesto Franco), che trascende la logica comune e il “tempo degli orologi” del critico Bruno per dire: «Questo l’ho suonato domani».
Lo schizofrenico che delira di urne vuote nei campi sogna di comprimere una settimana in un quarto d’ora, se la prende con Dio.
Ne era cosciente lo stesso Cortázar, che aveva preso a modello esteriore l’appena scomparso Charlie Parker (i dati biografici collimano: la moglie Chan che qui si chiama Lan; la morte della figlia; i ricoveri all’ospedale psichiatrico di Camarillo; il rapporto con la nobildonna e mecenate Pannonica de Koenigswarter qui chiamata Tica, mecenate di jazzisti alla quale la nipote Hannah Rothschild ha dedicato il recente e assai bello La baronessa, Neri Pozza), cercando però di “inventarlo” a partire da quelle coincidenze: «Avevo bisogno di un personaggio che rispondesse a caratteristiche molto particolari… un individuo che è insieme capace di avere un’enorme intuizione e di essere molto ignorante, molto primitivo. È molto difficile creare un personaggio che non pensa, un uomo che non ha pensieri ma sensazioni». Il risultato, comunque, è l’omaggio più alto che la letteratura abbia reso al jazz.
Sperimentano anche nel linguaggio gli ultimi due racconti. Uno, Le bave del diavolo, riflette sull’affinità tra il racconto e la fotografia. Entrambi narrazioni senza svolgimento a differenza del romanzo e del film, devono dilatare l’attimo, portarlo oltre l’inquadratura, verso l’ipersignificazione. Devono, per dirla con lo stesso Cortázar, «suscitare nello spettatore o nel lettore una specie di apertura». Il fotografo franco-cileno Roberto Michel scatta una foto a un adolescente che ha visto assieme a una donna, nell’Ile Saint-Louis. E ignora le proteste di lei, che vorrebbe la consegna del rullino, mentre di fronte al litigio l’adolescente scappa.
Quando, nel suo studio, sviluppa e ingrandisce la foto, l’inquadratura acquista un nuovo senso: il colloquio fra i due poteva essere seduzione; la seduzione poteva essere, forse è stato, quasi senz’altro è stato, adescamento per conto terzi. Per conto di un uomo che non compare nell’inquadratura. Lo scatto di quella foto ha cambiato un destino. Forse… Per collocarsi nel punto camaleontico in cui realtà fenomenica e realtà congetturale stanno in bilico, in cui “questo hai visto” e “questo in realtà era” si confrontano, servirebbe un nuovo linguaggio che scardini la sintassi e trascenda il dato (reale? apparente?) dell’istantanea: «Se si potesse dire: io videro salire la luna, oppure: ci mi duole il fondo degli occhi…».
Non scardina nessuna grammatica ma giustappone una persona a un’altra, facendo coincidere il passato e il presente, Le armi fatali, che dà il titolo alla raccolta e le infonde un connotato perturbante, un finale cupo. La storia è quella, all’apparenza banale, di un corteggiamento fra due ragazzi che hanno da poco passato i vent’anni. Lui, Pierre, scalpita e si consola fantasticando. Lei, Michèle, resiste e prende tempo. Si amano, ma c’è una storia (non detta) che affiora dal passato e giustifica le ritrosie e i rifiuti di lei. Quando si trovano da soli il passato ritorna: crudele ma più che mai ambiguo, confondendo una violenza che fu a una nuova che forse si sta consumando. Ma è la terrorizzata Michèle a vedere nel mite Pierre un nuovo carnefice, o sta fantasticando? E il mite Pierre sta, a sua volta, facendo fantasie di stupro o le sta mettendo in pratica? È Pierre oppure l’uomo di ieri, che i mitissimi amici dei due… Oppure, ancora, la conclusione della storia è una semplice ‘prima volta’ che il fantasticare dei due popola di aggressività (inferta, subita) per ‘vestirne’ la normalità? Non lo sapremo, e il congedo da Cortázar avverrà senza certezze né consolazioni.
Va aggiunto, per concludere, che questi racconti hanno affascinato il cinema. Le bave del diavolo ha offerto lo spunto ad Antonioni per Blow up, I buoni servigi si è affidato allo humour nero e antiborghese di Chabrol (Monsieur Bebé, film per la tv del 1974 inedito in Italia), Lettere di mamma è stato portato sullo schermo da Manuel Antin e Il persecutore da Osias Wilensky.
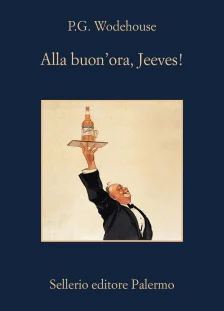
Pelham Grenville Wodehouse, Alla buon’ora, Jeeves!, traduzione di Beatrice Masini, Sellerio, 2024
Pelhan Grenville Wodehouse (1881-1975), l’inventore dell’incomparabile Jeeves e del frivolo bon vivant Bertie Wooster, incarna una certa idea platonica dell’Inghilterra. Un’idea eccentrica e anacronistica, un po’ come i cinesi con il codino e gli africani con l’osso al naso e la sveglia al collo che si vedevano un tempo nelle vignette dei giornali enigmistici. Un’idea d’Inghilterra blandamente bizzarra e fatua che gli inglesi adorano senza riserve (tra gli ammiratori recenti di Wodehouse figurano Salman Rushdie e il Douglas Adams della Guida galattica per autostoppisti, nonché l’attore-scrittore Stephen Fry, che ha interpretato Jeeves in una serie tv degli anni ‘90, mentre il vacuo Bertie era Hugh Laurie non ancora Dr. House), quando non cercano di scrollarsela di dosso con fastidio (nel 1967 lo scrittore, da tempo residente in America, venne proposto per un’onorificenza nel paese natale, e l’ambasciatore inglese a Washington obiettò che ciò «avrebbe dato credito a un’immagine alla Bertie Wooster della personalità inglese, che stiamo facendo del nostro meglio per sradicare»).
Nei suoi novanta e passa libri, questa idea d’Inghilterra si incarna in aristocratici ottusi e dediti a hobby singolarissimi (la collezione di lattiere da tè a forma di mucca, l’allevamento di scrofe da competizione o di tritoni, com’è il caso di Gussie Fink-Nottle in questo libro), in zie inaffondabili e pestifere che guidano la caccia alla volpe, giocano d’azzardo dissipando patrimoni e dirigono riviste per signore, a metà strada fra una rurale noblesse un po’ equina alla Camilla Parker Bowles e un’inossidabilità alla Elisabetta II. In nipoti vacui, scavezzacollo e sempre nei guai, eppure paurosamente imbranati nei confronti dell’altro sesso (l’universo di Wodehouse, come quello disneyano, è una macchina celibe e orfana: padri e madri ne sono stati espulsi per essere sostituiti da zii e zie, e i giovanotti hanno in orrore il matrimonio).
In imbroglioni che impegnano spille e corgi, affittano cottage e ville delle zie a estranei pur di fare soldi. In fidanzati che si lasciano perché hanno litigato sulla differenza tra squali e rombi (accade in questo romanzo fra Tuppy Glossop e Angela Travers cugina di Bertie), fanciulle svenevoli e corteggiatori che non trovano il coraggio per dichiararsi.
E, naturalmente, in maggiordomi onnipresenti, onnipotenti e soprattutto onniscienti, depositari di ogni sapere esoterico e pragmatico: lettori di Spinoza e frequentatori delle corse di cavalli allo stesso tempo, depositari dei segreti dell’aristocrazia da fare invidia all’MI5. Il campione della categoria, lo abbiamo ricordato, è Jeeves, che corregge le citazioni a sproposito e i piani disastrosi dell’altezzoso e ‘asino’ Bertie Wooster e scongiura i disastri in agguato.
In gioventù, quando in Italia era ancora edito da Elmo e Bietti (nella fascetta c’era il motto: “Se sei saggio ridi”), sono stato un lettore seriale di Wodehouse e mi sono molto divertito. Ora rimane un’ombra di quel sorriso ma i suoi libri, se per me non sono più esilaranti come in passato, restano sempre accattivanti. Perché si sa che va a finire bene, ma come ci si arriva è sempre una sorpresa.
E se le trame risultano più stereotipate con il passar degli anni, lo smalto umoristico della prosa di Wodehouse non ne è rimasto intaccato. Ha ragione Stephen Fry, per il quale passare Wodehouse al vaglio della critica equivale ad affondare una vanga in un soufflé, a definirlo «a man stuck in a permanently pre-pubescent childhood, were it not for the extraordinary, magical and blessed miracle of Wodehouse’s prose, a prose that dispels doubt much as sunlight dispels shadows, a prose that renders any criticism, positive and negative, absolutely powerless and, frankly, silly».
La serie di Jeeves viene riproposta adesso da Sellerio nella smagliante versione di Beatrice Masini – è stata fra l’altro l’ottima traduttrice di Harry Potter – accompagnata da un’introduzione ricca d’informazioni e godibilissima.
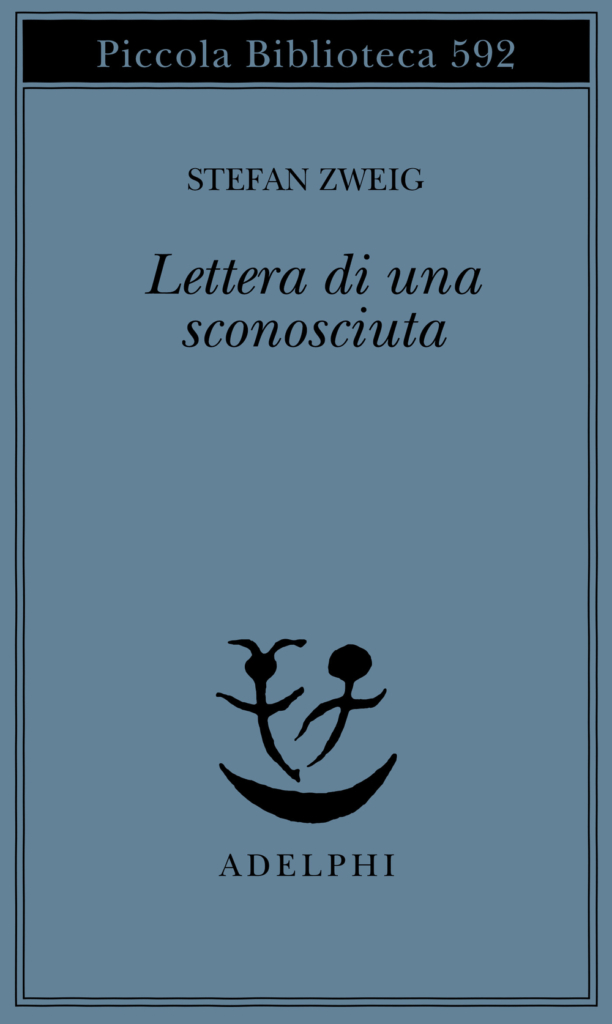
Stefan Zweig, Lettera da una sconosciuta, trad. Ada Vigliani, Adelphi, 2009
L’affermato romanziere R. torna a Vienna da «una ritemprante vacanza di tre giorni in montagna». A casa lo attende, assieme alla corrispondenza ordinaria, una lettera di circa venti pagine, «vergate alla svelta in una grafia femminile affannosa e sconosciuta, un manoscritto piuttosto che una lettera».La lettera comincia così: «Ieri il mio bambino è morto – per tre giorni e tre notti ho cercato di strappare alla morte la sua piccola, tenera vita, per quaranta ore sono rimasta al suo capezzale mentre l’influenza scuoteva quel corpicino che bruciava di febbre».
Incuriosito, lo scrittore si immerge nella lettura. Scopre che la lettera, non firmata, gli è stata inviata da una morta. Se riceverai questa lettera, avvisa l’ignota corrispondente, vorrà dire che io avrò seguito il mio bambino. E mentre ti scrivo, aggiunge, «mi sei rimasto solo tu, tu che mai mi hai conosciuta e che io ho sempre amato».
La lettera racconta l’amore assoluto, la passione di una vita di questa sconosciuta che, adolescente e figlia di una vedova, era una vicina di casa di cui R. non si era mai accorto. Costretta a seguire la madre, che si è risposata con un facoltoso commerciante trasferendosi a Innsbruck, la ragazza qualche anno dopo torna a Vienna per guadagnarsi da vivere. Fa la commessa e trascorre le serate sotto le finestre di lui, sperando che lo scrittore la incroci.
Quando ciò avviene, il romanziere non la riconosce. Attratto tuttavia da lei (R. è un bon vivant incline alle avventure leggere), la invita a casa e passa con lei tre notti. Mentre parte per l’estero, giura che la cercherà ma non si fa più vivo. Incinta di lui, la giovane donna partorirà nel reparto dei poveri dell’ospedale e alleverà da sola il figlio che, giura, gli assomiglia. Senza cercarlo e senza rivelargli mai niente.
Per mantenere il figlio, la giovane donna si fa a sua volta mantenere da un’eletta schiera di distintissimi. Che le offrono l’agiatezza, la rispettano, talvolta la chiedono in moglie. Lei rifiuta sempre, pensa soltanto a lui. E una sera, in un locale di lusso, mentre è con il cavalier servente in carica e con gli amici di lui, viene abbordata dal solito R., che come al solito non la riconosce ma la invita a scappare con lui.
Lei accetta, lascia il locale e trascorre la notte con R. Al mattino, l’uomo le infila in tasca delle banconote e lei fugge inorridita. Fine degli incontri, fino al drammatico epilogo annunciato dalla lettera.
Apparsa nel 1922, la novella di Stefan Zweig (1881-1942) ottenne un successo clamoroso e, quel che più conta, duraturo. Per il monologo febbrile e concitato di un amore sublime e assoluto, che neppure la frivolezza di lui e i cedimenti mondani di lei scalfiscono. Ma sotto la superficie palpitante della grande storia romantica stanno, sommersi ma non troppo, altri motivi di ambiguo fascino che fanno del racconto un grande racconto.
La storia dell’amore sublime è anche, in qualche modo, la narrazione di un caso clinico, di un’alterazione della psiche: la storia di un’ossessione. E Zweig, seguace appassionato e convinto di Sigmund Freud, doveva esserne consapevole. Come doveva avere presenti le pagine di Psicopatologia della vita quotidiana in cui Freud parla del piacere che si trae dall’umiliazione autoimposta, dal poter dire “sono una vittima”.
La vittima, in realtà, se è il controcanto femminile di tante storie viennesi narrate con lo sguardo di lui (penso a Girotondo di Arthur Schnitzler, penso alla Milleduesima notte di Joseph Roth), è tale anche perché tale ha scelto di essere. Per volontario e malato annullamento di sé o per inconsapevole delirio di onnipotenza non si è mai rivelata, non ha mai chiesto, non ha mai cercato una risposta dall’oggetto del suo amore. La lettera dalla tomba così, oltre che la rivelazione di un amore sublime, può essere anche una sublime forma di vendetta.
Dalla novella di Stefan Zweig sono stati tratti ben cinque film: uno austriaco (Robert Land, 1931), due americani (John M. Stahl nel 1933 e Max Ophüls nel 1948), uno francese (Jacques Deray, 2001) e addirittura uno cinese (Xu Jinglei, 2004).
Conosco il film di Ophüls, bellissimo e lievemente infedele, fluido e barocco, romantico senza sdolcinature e nostalgico come soltanto un ebreo sopravvissuto a tutto sa essere (Ophüls è tra i miei registi preferiti, ed è uno dei grandissimi della storia del cinema), sceneggiato da Howard Koch, tra gli autori di Casablanca che negli ‘50 finì nelle liste nere del maccartismo.
Come si fa a trasformare un monologo, una parete liscia e impossibile da scalare, in un film? Con un uso sapiente dei flashback, con una storia che presuppone un minimo di frequentazione e di dialogo. Così i due (lei è Joan Fontaine, sorella di Olivia de Havilland che fu l’insopportabile Melania di Via col vento, lui è Louis Jourdan) acquisiscono dei nomi e delle professioni (amarsi senza avere un nome, oltre che nella novella di Zweig, è possibile soltanto in Ultimo tango a Parigi).
Lui è il pianista Stefan Brand, lei che da ragazzina lo sentiva suonare dalle finestre di fronte è l’indossatrice Lisa Berndle. Come nella novella, si reincontrano e lui non la riconosce, si amano (una sola notte, siamo a Hollywood) e lei aspetta un bambino, lui non ne saprà niente. Lisa racconta tutta la storia a un aristocratico, Johann Stauffer, che la sposa e adotta il bambino. Lisa cede una sola, ultima volta a Stefan, benché il marito la metta in guardia: ma se l’incontro è innocente, quando ritorna trova il figlio, che nel frattempo aveva contratto il tifo, morto. Morirà anche lei dello stesso male e il marito sfiderà a duello il pianista, che nell’ultima scena del film andrà incontro al suo destino. A Ophüls piacevano i duelli: finirà tragicamente, dando la parola alle pistole, anche un altro suo capolavoro, I gioielli di Madame de…, infinitamente superiore al romanzetto di Louise de Vilmorin da cui fu tratto.