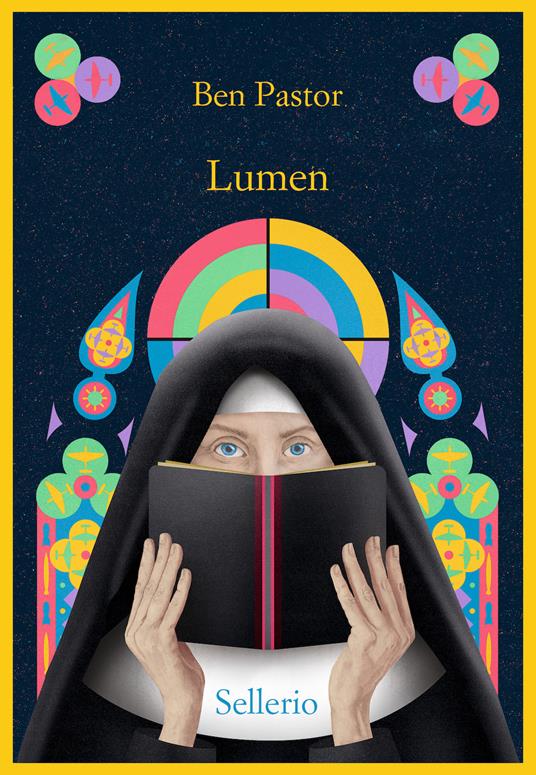Otto racconti brevi riportano Martin Bora, il personaggio inventato da Ben Pastor, tra fronte orientale e fronte occidentale: “La finestra sui tetti” è una raccolta che interseca personaggi e luoghi che compaiono nei romanzi della scrittrice, e che compongono in brevi lampi la complessità psicologica avvincente e perduta del suo personaggio. Otto gioielli: quasi una epitome. Consueta cura nella ricostruzione storica, lingua cristallina, identica intelligente prospettiva: la necessità di interrogarsi sul senso della distruzione, e sulla scottante vicinanza del nostro passato.
Da qualsiasi parte la si voglia guardare, una cosa è certa: Ben Pastor (al secolo Maria Verbena Volpi) non poteva scegliersi un personaggio più scomodo da far agire nelle coscienze di chi ha la fortuna di incontrarlo.
Colto, ma infilato nella barbarie della guerra. Retto, ma nato dalla parte sbagliata della storia. Passionale, ma costretto a una rigida contenzione della propria emotività (per educazione, e per circostanze), mai contraddittorio – e però trascinato dagli eventi nelle più atroci e cupe contraddizioni che l’uomo abbia saputo alimentare.
Proprio per questo Martin Bora è un personaggio magnetico, avvincente, completo: uno di quei personaggi dotati di una tale intraprendente intelligenza che potrebbe decidere, a un certo punto, di farsi una sua (ulteriore) vita anche al di fuori delle pagine – al pari di uno Sherlock Holmes, per intenderci, o di un Philipp Marlowe. E strano che, dopo ben dodici romanzi, non sia ancora successo.
Del resto, anche quando non si trova al centro di un lungo intrico, come avviene da Lumen (il primo, intenso libro che lo vede protagonista, nel 1939, in una Cracovia occupata dai tedeschi, tra chiostri dall’ambiguo silenzio e madri badesse di frequentazioni occulte), Bora esercita la sua innata capacità di sedurre, patire e costringere a pensare.
Così è nella raccolta La finestra sui tetti, che Sellerio ha di recente pubblicato: otto racconti, equamente divisi tra fronte orientale e fronte occidentale, nei quali Ben Pastor dimostra la sua bravura anche nella misura breve. Una sorta di epitome, che però ha anche il merito di aggiungere tessere al dinamico (e drammatico) mosaico che compone la vita dell’ufficiale tedesco, liberamente ispirato da Claus von Stauffenberg.

Ci sono, nel piccolo, tutti i grandi temi che la scrittrice predilige.
Il primo, e più evidente, è quello della guerra.
Scegliere un uomo dei servizi segreti dell’esercito tedesco, educato nella sua formazione teorica a valori granitici e saldi, costringerlo a confrontarsi quotidianamente con la brutalità, l’insensatezza, la crudeltà gratuita della parte tedesca nel secondo conflitto mondiale significa mettere alle corde ogni sua convinzione. Poiché Martin Bora ha sicuramente le caratteristiche dell’eroe, ma dell’eroe che comprende che il bene non può essere più lontano dal sistema nel quale è comandato.
E, dunque, come non perdere l’anima, come non tradire i principi, come contenere il male in uno scenario nel quale ciò che si prevede è l’obbedienza fino all’autodistruzione, e qualsiasi legittimo dubbio è considerato atto di imperdonabile insubordinazione?
L’inferno del fronte (dei fronti), la quotidiana partita a carte con la morte, l’insensata irruzione della catena di cause ed effetti che, dai vertici della Germania di Hitler, costringe le vite dei singoli a degradarsi, dissociarsi, espropriarsi di ciò che è amore, bellezza, nobiltà, felicità – tutti concetti che costa caro anche soltanto ricordarli.
Martin Bora è un uomo obbligato ad andare incontro alla fine. Della guerra, dell’umanità, di un paese, della vita.
Nel terzo racconto della raccolta appena pubblicata, Il giaciglio d’acciaio, Ben Pastor entra dolorosissimamente nei pensieri del suo ufficiale a un passo dalla morte, facendolo parlare in prima persona: se la capacità di uno scrittore è esattamente quella di arrivare a dare parola a ciò che non ne ha, qui siamo dentro un documento umano di rara caratura. E il dramma nel dramma (ovvero ciò che rende ancora più prezioso il senso dell’opera di Pastor) è che, leggendo una storia ambientata nel secondo conflitto mondiale, non possiamo non ragionare che nulla (a parte gli equipaggiamenti) è cambiato rispetto a ciò che ci sta accadendo intorno.
Il mio nome è Heinz-Martin Bora, di antica schiatta militare, sassone ma nato a Edimburgo l’11 novembre 1913. Ho dunque ventinove anni, quarantaquattro giorni e due ore. Sono sposato con Benedikta da tre anni e quattro mesi. Alle ore 9 e 45 di questa mattina mi hanno ufficializzato la promozione di grado di maggiore.
Richiamarsi alla razionalità, alla realtà della vita nel momento presente, contare (le piastrelle, gli oggetti, i fili d’erba, magari, o i capelli in testa), attaccarsi al controllo di sé per rispetto dei sottoposti (radersi minutamente mentre il mondo crolla intorno), suddividere la preoccupazione in piccoli pezzi per riuscire a dominarla: Martin Bora mostra come è l’uomo al tramonto dell’umano, quando ha strumenti (e una ultima possibilità) per non cedere al naufragio.
“La sedia era scomodissima, gli oggetti di cancelleria poveri e insufficienti. La vista del brutto calendario sul muro, e della cartina appesa storta, lo irritò di colpo. Buttò entrambi nel cestino.
La disarmonia, l’approssimazione gli davano più fastidio che mai. Osservava se stesso come dal di fuori, in questo strano momento della sua vita, né gradendo né rifiutando quanto vedeva: un giovane deciso a controllare anche la sua pulsione verso il controllo”
si legge in La Venere di Salò, probabilmente il romanzo nel quale più forte emerge l’altro grande tema che Ben Pastor non abbandona mai: quello dell’arte come bene di salvaguardia interiore, anche in momenti estremi, risorsa salvifica e luogo di espressione di ciò che è indicibile, il supremo come l’ultimo.

Nel primo racconto de La finestra su tetti, dove Bora incontra Vladimir Propp e ha con lui una schermaglia sul formalismo, Martin si siede al pianoforte come davanti a un dono inaspettato: si trova da qualche parte in una Ucraina devastata (anche qui, e più ancora ne Il cielo di stagno, è fortissima la dissonanza che riverbera nel leggere il martirio degli stessi luoghi che incontriamo sui giornali oggi, in questo tempo scellerato); il Petrof è miracolosamente accordato: non può non cedere a quel lembo di umanità che lo abita ancora, lo suona come se fosse, questo, l’atto per continuare a possedere la propria anima, e arriverà a ordinare di caricarlo in treno – impossibile, incongruente ratto per la sua sensibilità ferita.

Il tema della musica (il nonno di Bora è stato un valente direttore d’orchestra, e ha vissuto l’epoca dei Brahms, degli Schumann, degli Schubert, tutta la grande stagione romantica tedesca) ha una persistenza non casuale: il fatto che, in un attentato, Martin perda una mano, non è che l’ennesima prova che la Storia lo costringe ad affrontare: la mano continuerà a sentire la musica che non potrà più far nascere, ma il rimpianto terrà in vita quella parte umana che, benché orbata, è troppo preziosa, troppo alta per essere accantonata.
La nobiltà d’animo destina Martin Bora a un profilo ben preciso: e certo si addice, come si addiceva ai cavalieri antichi, lo struggimento difficilmente contenibile (e però fondamentale per darsi motivo di rimanere in vita) di un amor de lonh, un amore di lontano. Refrattaria a qualsiasi tentativo di beatificazione, però, Dikta – la moglie sposata d’impulso, rapinosa e bellissima – non corrisponde a nessuna forma angelica. È al contrario una donna singolarmente emancipata, che non ha alcuna vocazione a fare la Penelope del momento. Ogni volta che Dikta compare, non sono soltanto le pulsioni più intime di Bora a essere sconvolte: è proprio, e più profondamente, il senso di ciò che la guerra gli impone, a salire sulla bilancia del dubbio. Non si sottrae al suo compito, Martin, come non si sottrae al suo voto di fedeltà (un autentico vassallaggio d’amore, viene da dire): ma a questi altari dovrà presentarsi sempre, inevitabilmente, solo – e ancora di più quando, dopo anni di incontri fuggevoli contati sulle dita delle poche licenze, con la domanda di divorzio arriverà la sentenza della reale consistenza della lontananza, ennesimo prezzo che la guerra esige, e ottiene.
Certo, c’è il Sud, il fronte dell’Italia, dove Martin Bora sente di nuovo il sole sulla pelle: un Sud che ha amato e frequentato, e a cui Ben Pastor dedica pagine estremamente efficaci (sempre il paesaggio non è contorno, ma sostanza dell’inquietudine: in Grecia, ne La strada per Itaca, come nella Roma di Kaputt Mundi, sensualissima, feroce e decadente, o nell’Abruzzo struggente de Il morto in piazza). Il Sud dove incontrerà altre forme per nutrire il desiderio più pericoloso che riconosce di sé, ovvero la necessità di amare, e continuare a essere uomo dotato di emozioni e sentimenti: a questa parte sono dedicati i racconti del fronte occidentale della raccolta La finestra sui tetti.
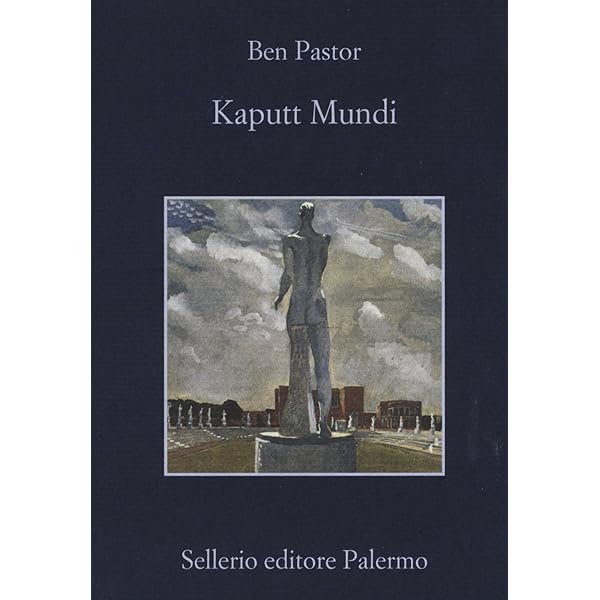
Ci sono molti modi per leggere Ben Pastor. Uno è, per esempio, quello di andare incontro alla tragedia di eventi noti della Seconda Guerra Mondiale attraverso una prospettiva non didascalica, ma significativa nella sua originalità – così come, per esempio, si può leggere Fred Vargas per comprendere diversamente la persistenza dei grandi temi mitologici e antropologici nel nostro quotidiano.
Un altro modo è interrogarsi su ciò che fa di Martin Bora un personaggio tanto contemporaneo, nonostante i suoi riferimenti eroici appartengano inoppugnabilmente al passato: qui sta, credo, la forza che lo rende, al contempo, affascinante e insopportabile, ammirevole e compatibile.
Martin Bora appartiene a quella sostanza che avvince i personaggi di crinale, che in ogni epoca mostrano ciò che avrebbe potuto, nel meglio, essere l’uomo (qui alle soglie del Novecento: altrove in altro modo): cosmopolita, amante della bellezza, intelligente, progredito. Ampio in tutti i suoi orizzonti.
E invece.