Riletto oggi e nella forzata reclusione della pandemia, Oblomov ci dice molto nella sua ambiguità: infinita accidia o grande coerenza nello star fuor dai commerci del mondo, dal ‘gioco balordo degli incontri e degli inviti’ ? E quanto
parla alla nostra fatica nel tenere il passo dei cambiamenti veloci e al nostro desiderio di rifugiarsi in un altrove che è ieri?
Se cercate un capolavoro dove non succede niente, dove il protagonista impiega un capitolo per uscire dal letto, quindici capitoli per uscire di casa, peggio addirittura di noi reclusi in tempi di coronavirus, è Oblomov di Ivan Gonĉarov, apparso in Russia nel 1859, due anni prima che lo zar Alessandro II abolisse la servitù della gleba.
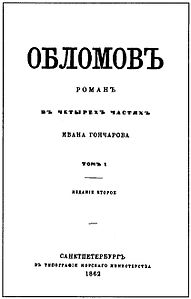
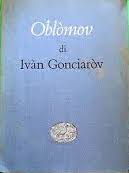
Brava persona d’animo gentile e delicato, ma pigra e indolente, Il’ja Il’ic Oblomov. Più che indolente irresoluta. Più che irresoluta inetta, con un buon mezzo secolo di anticipo su Zeno Cosini (che comunque si agitava ben più di lui). Proprietario di una tenuta, l’Oblomovkà, con trecentocinquanta anime. Che garantirebbe una buona rendita, se qualcuno se ne occupasse: ma Oblomov, quando non mangia e non dorme (il cibo e il sonno permeano tutto il romanzo; la veste da camera del protagonista, una vestaglia all’asiatica che lo avvolge e lo protegge come un ventre materno, è quasi l’unico capo di vestiario che fa spicco) vagheggia piani di riordino e modernizzazione delle sue terre che non riesce neanche a mettere su carta.
Cresciuto nella tenuta paterna (il capitolo “Il sogno di Oblomov”, scritto e anticipato da una rivista dieci anni prima del romanzo, descrive bene il sonno pesante e la digestione laboriosa della nobiltà rurale russa, che non studia e non si muove di casa, che vede l’istruzione e l’operosità con sospetto, che consuma quel che la terra produce incurante di perdite e profitti, ma è molto riluttante a spendere e a fare migliorie anche solo nell’arredamento, che ha nel non scalfire la tradizione l’unico modello possibile), Oblomov è stato mandato a studiare presso il maestro e amministratore tedesco Stolz, nel villaggio vicino, e poi a San Pietroburgo. Alunno svogliato, e terminati gli studi impiegato presso un ministero, lavoro che lascia dopo un errore, temendo il biasimo del capufficio.
Da allora Oblomov vive rinchiuso in casa, con rarissime sortite. Oscillante fra la beatitudine (la calma, la placidità del non far niente contrapposte a un progresso in cui vede soltanto insensata frenesia) e la scontentezza (la coscienza di sé come incapace e inadatto a stare nel “mondo di fuori”). Sue uniche compagnie, a parte il sonno e il cibo, poche frequentazioni scialbe o truffaldine. Il servo Zachar, scorbutico e inetto forse più di lui, ma fedele. E le fantasticherie.
Tenta invano di farlo riscuotere (“Ora o mai più”) il devoto amico e compagno d’infanzia Andrej Stolz, figlio del suo antico maestro e intraprendente uomo d’affari, curioso e quasi avido del mondo quanto Oblomov ne è indifferente o impaurito. Fallirà nell’impresa, come fallirà il pungolo della trepida e volitiva Olga, della quale Oblomov si è innamorato: qualche mese di buoni propositi e poi il ritorno all’apatia, la ripulsa di lei che più tardi sceglierà Stolz, il fidanzamento rotto.
Riuscirà soltanto, Stolz, a salvare il patrimonio dell’amico, che alcuni lestofanti stavano per portargli via, e a fare fruttare la sua tenuta. Quanto a lui, Oblomov, sposerà la donna che lo tiene a pigione, l’incolta ma devota e “materna” vedova Agaf’ja Matveevna, ne avrà un figlio, trascorrerà gli ultimi anni in un dolceamaro vegetare tra ricordi e cibo, fino al colpo apoplettico finale.
Una vittoria o una sconfitta, la sua? L’intima coerenza di un uomo che si mantiene fedele al passato, o l’irresolutezza di chi ha paura di affrontare il mondo? Quando apparve, Oblomov venne salutato dal più autorevole dei critici radicali, Nikolaj Dobroljubov, come il ritratto spietato dell’inerzia nobiliare, l’oblomovismo bollato come la malattia mortale dell’anima russa, come il risultato nefasto della servitù della gleba che aveva reso una classe sociale incapace di sbrigarsela da sola e di assumersi delle responsabilità. Una lettura che venne confermata dal bolscevismo, con Lenin – figlio di una tedesca luterana del Volga – veemente nel denunciare la persistenza degli Oblomov. Sul fronte opposto, gli spiritualisti come Merezkovskij videro nell’opera di Gonĉarov una denuncia della volgarità affaristica e contemporaneizzante che trionfa sui più alti ideali di amore e tradizione.
C’è in effetti tutto questo in Oblomov, un’ambiguità feconda e, diremmo oggi, un po’ cerchiobottista che non disconosce le ragioni del progresso ma non lo sa indagare (se è bella la relazione “alla pari” tra Olga e Stolz, l’attività di lui è un perenne agitarsi del quale poco o niente viene detto) e, pur deplorandola bonariamente, fa sua l’autoindulgenza con cui Oblomov si vive e si rappresenta.
Costruito su coppie di opposizioni nelle figure maschili (il fuori e il dentro, l’ombra e la luce, la tradizione e il cambiamento, l’immobilità e il movimento, Oblomov e Stolz) come in quelle femminili (l’amore come intelligenza che partecipa in Olga, l’amore come mansuetudine servizievole in Agaf’ja), Oblomov con il non-fare a cavallo fra l’accontentarsi soddisfatto e il nascondersi spaurito del protagonista dice a noi più cose, e forse cose diverse, di quanto non dicesse ai suoi contemporanei. Dice della fatica perenne di tenersi al passo con i mutamenti, mai come oggi impetuosi; della paura che i mutamenti suscitano e della sensazione angosciosa di non farcela; della difficoltà di mettere in pratica quel che si pensa; della tentazione di riparare – anche senza l’iperbole fra il caricaturale e il simbolico di Oblomov – nella beata regressione del mondo di ieri. Dice della necessità di non stare rinchiusi nella casa, nella famiglia, nell’etnia, nella piccola patria: di essere in una parola ibridi, come Stolz metà russo e metà tedesco, metà sentimento e metà azione.
Oblomov, per inciso, è in parte fabula autobiografica: figlio di mercanti assurti alla nobiltà rurale anche Ivan Gonĉarov (1812-1891), cresciuto in una campagna sempre rimpianta, impiegato di proverbiali lentezze – era censore – e pantofolaio riluttante a muoversi – fece però il giro del mondo in nave – , blando conservatore in tempi di intellighenzia progressista. Nell’ultimo capitolo del romanzo, fa capolino: è l’uomo di lettere al quale Stolz racconta la storia del suo amico in vestaglia perché ne scriva. «Una volta, verso mezzogiorno, sui marciapiedi di legno del quartiere di Vyborg passavano due signori; una carrozza li seguiva piano. Uno di questi signori era Stolz, l’altro un suo amico letterato, un uomo grasso, dal viso apatico, pensieroso, con occhi che sembravano assonnati». Ecco fatto: monsieur Oblomov c’est moi.