Roberto Contu sceglie lo spazio tra “Il banco e la cattedra” per raccontare ciò che della scuola non viene raccontato; Elianda Cazzorla fa un mosaico di storie per ricostruire le relazioni femminili nate (e perdute) in classe; Valentina Petri si volta con coraggio indietro, e riporta alla luce cos’è stato il tempo scolastico della sospensione; Alessandro Gazzola dà parola alla frontiera dell’insegnamento dalle pareti di un centro Eda. Quattro libri raccontano la scuola, in tempo di prima campanella.
Roberto Contu, Il banco e la cattedra (Aguaplano)
Esiste (resiste) un modo nobile di vivere, raccontare, pensare la scuola. Roberto Contu lo riafferma, con un libro che è il seguito ideale del suo Insegnanti. Il più e il meglio, pubblicato nel 2019 sempre da Aguaplano. In diciotto testi brevi, frutto della rielaborazione di un lavoro di riflessione messo insieme nell’arco di sei anni, l’anno scolastico viene illuminato per settimane, mesi, festività, pieni e vuoti.
C’è la voce di chi la scuola la fa da dentro in queste pagine limpide, profonde, di pacata (e per questo ancora più potente) argomentazione sulla vita minuta, sui dubbi, sugli scalini e sulla umanissima complessità dell’educazione.

Roberto Contu ha il merito di svelare quanto accade in una classe quando si accende, come (e con quale velocità) un singolo verso di settecento anni fa permetta di far divampare la riflessione sulle magagne contemporanee, quale sia il senso della fatica dell’insegnamento. Soprattutto, Contu dà parola al non detto, al non registrabile nelle algide note dei registri elettronici, allo spazio temerario che di giorno in giorno si costruisce nelle classi: il programma come atto democratico, Dante per il peso della libertà, lo straniamento di Verga come strumento conoscitivo, il “vuoto fertile dell’ignoto”, le grafie che contengono le posture delle vite giovani, il dubbio, il necessario ribaltamento del punto di vista per continuare a poter capire, le parole come armi che possono (e sanno) uccidere una vita.
Il banco e la cattedra ha una scrittura di rara onestà, e di coraggiosa gentilezza: utile, viva, felice.
Con il pregio di rivolgersi davvero a tutti quelli che hanno messo, almeno una volta, la cartella sulle spalle (e oggi pensano di avere dimenticato).
Il banco e la cattedra sono lo spazio e il tempo della scuola, ma la scuola è in un altrove dallo spazio e dal tempo del mondo. La scuola è dove l’ago della bilancia tra la vita e il morire punta sfrontato verso la prima. Perché le pelli sono giovani, i passi sono elastici, le dita sono tese. Perché i pensieri sono rapidi, le parole sono frenetiche, i rossori sono improvvisi. Invecchiano i muri e gli insegnanti, loro no, gli studenti hanno sempre quell’età, sono aggrediti dall’eccesso della vita. (…) la scuola (…) è comunque uno sguardo di sghembo sul mondo. (…) per questo si continua a parlare della scuola, si torna a raccontare della scuola, si insiste a dire male e a dire bene della scuola. Perché di quel fuoco da dove guardare di sghembo il mondo c’è bisogno, come quando il cielo è spento e si aspetta la luce del sole, che poi, quando torna, tutto è verde e germoglia, cresce e spiga; (…) l’ultimo granaio di senso, il magazzino stipato di futuro; l’ultimo desiderio possibile, il tensore d’inerzia del futuro; l’ultima risposta attesa, la cavea gremita, nel procinto di una parola che predica il futuro. Per questo, indebitamente, anche chi nel mondo proclama l’inattendibilità del senso, la fine del senso, l’impossibilità del senso, dalla scuola continua ad aspettarsi, sotto la pretesa del futuro, la produzione di un senso.
Elianda Cazzorla, Lilith e Lola (Iacobelli editore)
In qualche modo, la scuola non finisce mai.
Continua nella vita adulta: nella memoria del tempo che si è trascorso, nei rapporti che si assottigliano, nelle compagnie che si sono perse. Vite che hanno condiviso porzioni quotidiane di tempo, e sembravano indissolubili, all’improvviso si disperdono. Eppure, a ciascuno capita, prima o poi, di ricordare una faccia, un nome, una figura. Cosa avranno fatto? Come saranno? Perché ce le siamo perdute per strada?
Da qui parte il nuovo libro di Elianda Cazzorla, Lilith e Lola, che si spinge sugli stessi territori esplorati in Isolina, un martedì ma ne amplia il tiro.
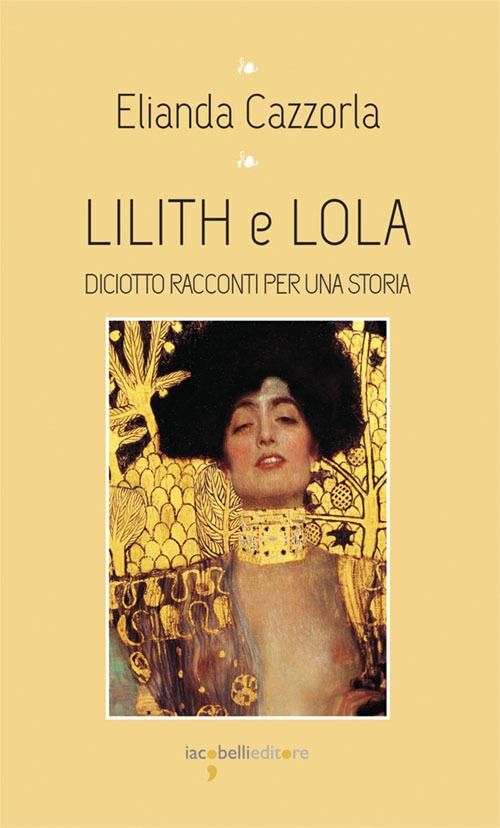
A volte, la scuola diventa una scelta: per chi compie la rotazione, da dietro il banco a davanti, e decide di diventare insegnante: ci sono anche momenti in cui il lavoro della scuola salva, altri in cui diventa una dannazione.
Tutto questo sono: storie. Diciotto movimenti che compongono la vita di un gruppo di compagne di classe, dal momento in cui hanno condiviso l’ultima campanella cominciando a perdersi nelle proprie esistenze. Finché Lilith non decide di iniziare a ritrovarle.
La scuola l’ha aiutata, con la disciplina della campanella che suona ogni mattina. Lo disse, durante la ricreazione, a Laura, la sua alunna preferita, che aveva perso la madre: la scuola ti salva dal dolore. Non smettere di studiare. Gli occhi vivi delle sue alunne, come quelli di Martina, Michela, Monica e i compagni, Andrea, Jacopo, Tommaso e gli altri e le altre di cui non ricorda il nome, piantati a grappolo attorno alla cattedra, li guarda nella foto sgranata che conserva come immagine in cui lei c’era. Nel retro c’è scritto: prima delle vacanze. Natale 2005. Quegli occhi l’hanno aiutata a costruire uno steccato che le evitasse la caduta nel burrone. L’unica salvezza è nella disciplina. Nonostante il non-senso contro cui devo combattere. Si alzava presto per essere puntuale alla prima ora.
Valentina Petri, Non ti sento (Rizzoli)
Si può anche superare, una faglia. A patto di ricordarsi di cosa è stato, di come era il prima, del modo in cui il dopo si è trasformato. Il nuovo romanzo di Valentina Petri decide di fare esattamente questo: guardare alla faglia, al tempo-luogo che con estrema dedizione ci siamo affrettati a rimuovere.
Dal suo esordio con Portami il diario (sempre Rizzoli) la sua voce, ironica e di precisione fulminea, ha ribadito con sapienza un principio importante: ridere delle abnormità che attraversiamo è qualcosa di molto diverso rispetto al dileggio; la risata, anzi, è forse l’unico possibile grimaldello in grado di forzare la porta che ci ammette a guardare in faccia le nostre distorsioni.
E, quanto a paradossi, l’apprendimento (che, come ogni buon insegnante sa, è fondamentalmente un atto contro natura) è un terreno fertilissimo, ma occorre restare aggrappati alla realtà per non servirsi della comicità come deformazione, finendo per demolire, o svilire il tempo della scuola. Si può essere ferocemente lucidi, insegnava l’esordio di Valentina Petri, per scendere nell’agone dell’insegnamento, senza per questo perdere umanità e rispetto.

Ora, questo nuovo romanzo, Non ti sento, decide di restituire parola a quello che la scuola è stata nel tempo in cui tutto si è fermato: ovvero, il momento in cui, rischiando di essere interrotta nella pandemia, tutte e tutti avremmo dovuto capire quanto valore ha una istituzione che coinvolge ogni singolo nucleo sociale, in molte forme e con molte conseguenze. Per alunne, alunni, insegnanti, vertici, famiglie, lavoratori, servizi, spazi, disponibilità economiche: il tessuto connettore unanime è la scuola. Rimasta in vita in modo avventuroso, sperimentale, diverso, assurdo, incognito grazie al più grande corso di auto-aggiornamento globale che sia mai accaduto dai tempi dell’invenzione della scrittura.
Per attraversare la faglia.
Provò a chiedere se tutto fosse chiaro. Si sentiva un po’ stupido, anzi parecchio stupido a parlare da solo, a casa, che poi non era casa sua, in quel buco di pochi metri quadri, con l’asta dello spazzolone che entrava nell’inquadratura.
Silenzio.
«Ragazzi, però se fate così, io non so se avete capito. Non so nemmeno se ci siete. Ragazzi, avrei bisogno di un segno, non dico tanto, ma una domanda, un intervento…»
Le lucine pulsavano. Dalla strada non proveniva nessun rumore, era tarda mattinata, ma non c’era nemmeno un’auto che accelerava, una moto che sgommava, niente. Le finestre erano aperte e sembrava che perfino gli uccelli avessero smesso di cantare.
«Ragazzi, per favore, aprite i microfoni, giusto per sapere se mi sentite o se sto facendo un monologo da solo. Vi giuro che è allucinante, così, sapete cosa mi ricorda? La camera anecoica. Che sarebbe… vabbè, che ve ne importa, ditemi solo se mi sentite.»
In tutte le classi ci sono elementi ricorrenti. C’è il polemico. C’è lo sbruffone. C’è il timido. C’è il secchione. C’è quello che aiuta tutti, c’è quello che manco ti accorgi se è assente. E poi c’è uno che non ce la fa. Uno che per quanto si impegni, per quanto riprometta a se stesso che non gliene frega niente, per quanto ce la metta tutta a starsene per i fatti suoi immerso in faccende in cui la scuola entra solo di striscio, ecco, nonostante tutte queste cose non ce la fa e alza la mano. Solo che la mano non si può alzare e allora Kevin apre il microfono e dice:
«Aspe’ prof! L’ho vista in una serie quella stanza là. È quella dove c’è silenzio assoluto vero?»
Alessandro Gazzoli, Estranei – Un anno in una scuola per stranieri (Nottetempo)
La scuola è un contagio vitale: cambia ogni esistenza che si trova a condividere il tempo dentro un’aula.
La cambia perché costringe a vedersi, con i propri corpi e nelle proprie idee. La cambia perché provoca un perenne stato di crisi: delle certezze pregresse, delle questioni di principio, della possibilità di incidere o meno (e della responsabilità che questo significa) sul tempo degli altri.
Quello che Alessandro Gazzoli costringe sulla carta in Estranei è il frutto di un quinquennio in un centro EDA, ovvero la scuola degli adulti che nella piccola realtà di Cles, in Trentino, accoglie un mondo di studenti e studentesse stranieri.

L’ex Ctp (Centro territoriale per l’educazione e la formazione in età adulta), il più avventuroso segmento della scuola statale, è una esperienza umana e formativa potente: non è l’ultimo dei luoghi dell’apprendimento, raccontano le pagine di Gazzoli; è, al contrario, un complesso banco di prova professionale, umano, civile: l’inizio di un possibile.
Che, come tutti i mondi estremi, è un avamposto per elaborare una pratica (non solo una idea) di società. La nostra.
In generale, l’osmosi è il processo fisico attraverso il quale si regge la struttura del Centro. Ogni persona, infatti, è affidata a un gruppo in via del tutto transitoria, come una sistemazione momentanea in attesa che vari fattori – lavoro, matrimoni, gravidanze, capacità, ambizioni personali – intervengano a indirizzarne la carriera. L’elasticità della struttura serve appunto a far sì che ognuno possa trovare il proprio equilibrio, acquisendo nel frattempo la consapevolezza di una sempre possibile transizione.
(…) Attorno a ogni studente, infatti, agisce come detto un campo magnetico di ragioni personali, che sfuggono a qualsiasi capacità di controllo o di previsione, e che pregiudicano il concretizzarsi o meno di qualsiasi velleità scolastica: come per tutte le persone adulte, sono il tempo, i soldi, la famiglia e la salute a comandare, a decidere delle loro vite e a trascinarle fuori dal centro.