La vita, la carriera musicale, i rapporti di un grande protagonista della scena musicale newyorkese (e americana). “Nato insieme al rock, lo ha accompagnato verso la sua mezza età e ha continuato a osservarlo mentre il genere assumeva nuove forme” afferma Will Hermes autore di un’avvincente biografia di Lou Reed
Un tuffo nel tempo, un film, un viaggio. Lou Reed, il re di New York (Minimum Fax) è una biografia in “presa diretta”, scritta con maestria dal giornalista e critico musicale Will Hermes. Una full immersion nell’universo complesso, appassionato, lacerante di uno dei più grandi performer (cantautore, poeta, scrittore) della contemporaneità. Ma anche nel mondo che lo circonda e che ha coinvolto poco o tanto tutti noi. Il mondo della musica americana dagli anni sessanta a oggi. I personaggi che contano ci sono tutti (o quasi). Perché tutti (o quasi) hanno interagito con Lou Reed e con la sua chitarra. Da John Cale a David Bowie, da Andy Warhol ad Allen Ginsberg, da Nico a Laurie Anderson, sua moglie e ultima compagna di vita. Impossibile citarli tutti. Comprimaria New York “musa per eccellenza con la sua bellezza selvaggia e cacofonica, le seduzioni, i pericoli” come scrive l’Autore nella prefazione che qui sotto vi presentiamo.
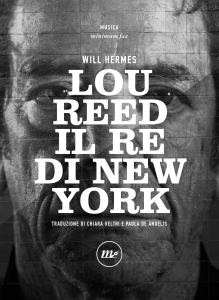
(…) La musa per eccellenza di Lou Reed era New York con la sua bellezza selvaggia e cacofonica, le seduzioni, i pericoli e i milioni di storie. Al concerto che organizzò per i suoi cinquant’anni al Madison Square Garden nel 1997, David Bowie presentò Lou Reed – l’ospite più importante della serata – come il «re di New York». In effetti Lewis Allan Reed era l’incarnazione della scena artistica della New York del secondo dopoguerra. Si in- namorò del rock’n’roll e del doo-wop newyorkese e registrò il primo singolo alla fine degli anni Cinquanta, mentre frequentava ancora le superiori. Al college studiò scrittura con il poeta modernista Delmore Schwartz, che divenne il suo primo mentore artistico e di cui non smise mai di tessere le lodi (nella prefazione a un’antologia di Schwartz del 2012, scriveva: «Oh Delmore, quanto mi manchi. Grazie a te ho iniziato a scrivere. Sei il più grande uomo che io abbia mai conosciuto»). Reed vide il quartetto di Ornette Coleman durante i leggendari concerti al Five Spot Café nel 1959 e ne fu profondamente colpito; nel suo programma alla radio del college, Excursions on a Wobbly Rail (dal titolo di un pezzo di Cecil Taylor), metteva brani del primo free jazz e fondò una rivista letteraria che prendeva il nome da «Lonely Woman» di Coleman, da lui spesso citato come il suo pezzo preferito in assoluto. Quando si trasferì a New York dopo il college, entrò subito in contatto con la comunità artistica d’avanguardia, lavorando insieme o a stretto contatto con i pionieri della musica sperimentale (La Monte Young, Tony Conrad), del cinema ( Jonas Mekas, Barbara Rubin) e del teatro (il La MaMa Experimental Theater Club, dove lavorava Lincoln Swados, suo compagno di stanza al college). Un anno e mezzo dopo essersi laureato, Reed fondò i Velvet Underground e divenne amico di Andy Warhol, il suo secondo e forse più importante mentore, modello e musa.
Dal punto di vista strettamente lavorativo il rapporto di Reed con Warhol, uno tra gli artisti e i pensatori più importanti del ventesimo secolo, fu breve: Warhol fu il manager dei Velvet Underground per circa un anno e mezzo tra il 1966 e il 1968 e produsse, per così dire, il loro album di debutto. Il loro rapporto ebbe diversi alti e bassi, ma i due rimasero amici per tutta la vita e l’influenza di Warhol sulla pratica creativa di Reed proseguì ben oltre la morte dell’artista nel 1987. Warhol fu l’oggetto, implicito o esplicito, di un numero significativo di lavori di Reed, compreso Songs For Drella, il disco del 1990 con John Cale dedicato alla sua memoria. Dal punto di vista estetico, Warhol sicuramente rafforzò e probabilmente amplificò l’idea di Reed di trovare la bellezza nel brutto, nel banale, nel vituperato e nel disprezzato; Warhol condivideva la predilezione di Reed per la ripetizione, il rumore, la distorsione e la frequente aspirazione alla trascendenza. Warhol fu anche un modello (insieme al padre di Lou) dal punto di vista imprenditoriale, soprattutto dopo che Reed rimase scottato diverse volte: la Andy Warhol Enterprises fu sicuramente un punto di riferimento per la sua etichetta Sister Ray Enterprises. L’influenza di Warhol è continuata perfino dopo la morte di Reed: lo sfruttamento e le attività postume che riguardano Warhol (come l’archivio delle Capsule del tempo e il Warhol Museum) trovano un equivalente nell’archivio di Reed presso la New York Public Library e nelle iniziative che lo riguardano. Naturalmente tra i due c’erano spiccate differenze a livello di sensibilità, soprattutto all’inizio: entrambi erano capaci di frapporre una distanza fredda e voyeuristica tra sé e l’arte, ma Reed era un provocatore irascibile, un emotivo che non si autocensurava e che a volte era preda di una furia autodistruttiva.
Come Warhol, Reed attinse ampiamente al talento e alla collaborazione di altri artisti. I suoi colleghi nei Velvet Underground – John Cale, Nico, Sterling Morrison, Moe Tucker e Doug Yule – diedero un contributo fondamentale alle sue canzoni migliori e lo aiutarono a plasmare il suo approccio musicale. Detto con franchezza, prima dei Velvet, Reed era poco più di un autore e cantante folk commerciale piuttosto velleitario, sebbene con dei notevoli spunti lirici. Cale portò in dote la sua educazione musicale formale e una conoscenza del bordone amplificato grazie alla collaborazione con il compositore d’avanguardia La Monte Young. Morrison la sua padronanza della chitarra rock e rhythm’n’blues, insieme a una dote naturale per l’interplay e alla capacità di passare dall’accompagnamento al ruolo solista. Moe Tucker uno stile di batteria veramente unico, basato sia sul rock’n’roll sia sul drumming africano, con cui avrebbe influenzato generazioni di batteristi. Nico diede a Reed, i cui personaggi più memorabili erano generalmente femminili o non binari, una voce femminile per cui scrivere, mentre Doug Yule (e a volte anche Tucker) erano un alter ego vocale con cui confrontarsi. Nei progetti successivi figurano Bowie (Transformer), il chitarrista Robert Quine (The Blue Mask), Anohni (The Raven) e altri artisti che da quelle collaborazioni vennero potenziati in modo alchemico, tanto quanto Reed.
Anni dopo aver studiato con Schwartz e Warhol, Reed continuò a essere influenzato da altri maestri che trovarono in lui un discepolo devoto e umile. Prese lezioni da Doc Pomus, grande compositore del Brill Building, anche lui un ragazzo di Brooklyn e uno spirito affine, autore di molti successi doo-wop e rhythm’n’blues amati da Reed durante l’adolescenza. Studiò anche con i maestri di arti marziali Leung Shum e Ren GuangYi, con cui praticava il tai chi, una disciplina che ebbe un ruolo importante negli ultimi decenni della sua vita, e con il maestro buddista Yongey Mingyur Rinpoche.

I Velvet Underground. Da sinistra: Moe Tucker, Sterling Morrison, Doug Yule, Lou Reed (per gentile concessione della M.C. KostekVUAS)
Fra i suoi grandi maestri c’erano anche i dischi e i libri. Studiò intensamente la musica di Steve Cropper e James Burton, Alban Berg e Hank Ballard, Ray Charles e Moondog, i Mellows e le Chantels, Dion and the Belmonts, The Byrds e The Rolling Stones, Ornette Coleman e Cecil Taylor. Nonostante la rivalità non dichiarata e l’indubbia ansia di subirne l’influenza, Reed prestava grande attenzione a Bob Dylan e in più di un’occasione reinterpretò le sue canzoni. Poi c’erano gli scrittori: Delmore Schwartz e William S. Burroughs, Hubert Selby Jr., John Rechy, Lenny Bruce, Norman Mailer, James Joyce, Leopold von Sacher-Masoch, Virginia Woolf, Alice Bailey, Allen Ginsberg, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, T.S. Eliot, Sylvia Plath, Edgar Allan Poe, Frank Wedekind. Tutti questi, e molti altri ancora, contribuirono a dare forma all’opera di Reed.
Negli ultimi vent’anni, la presenza più importante nel lavoro e nella vita di Reed è stata Laurie Anderson. All’inizio degli anni Novanta, quando divennero una coppia, Anderson era un’artista multimediale la cui opera concettuale possedeva una grandezza warholiana, anche se il suo profilo culturale era inferiore: il genere sessuale, l’identità creativa poliglotta e la tendenza a criticare le strutture di potere oppressive probabilmente rallentarono la sua ascesa nelle sfere più alte del mondo dell’arte.
Negli anni Ottanta divenne una sorta di popstar per caso grazie al singolo «O Superman» che, pubblicato dalla piccola etichetta di un amico, svettò al numero due nel Regno Unito ed entrò nelle classifiche di tutto il mondo, diventando così il suo «Walk on the Wild Side». Pur mantenendo carriere separate, la coppia collaborava nel lavoro e a volte suonava e registrava insieme. Durante gli anni trascorsi con Anderson, un’artista multimediale fin dagli esordi, gli interessi interdisciplinari di Reed sbocciarono. Insieme divennero due ambasciatori culturali, che tutte le sere partecipavano agli eventi artistici quando non erano loro a esibirsi, o non erano separati per esigenze di tour. Erano il re e la regina di uno specifico demi-monde creativo newyorkese che nel corso del tempo sarebbe diventato elitario o quantomeno rispettabile. La commemorazione pubblica di Reed e il successivo evento durato un’intera giornata si sono tenuti al Lincoln Center, il tempio della cultura alta in città. Per un artista che in passato aveva mimato l’atto di iniettarsi eroina sul palco gettando poi l’ago tra il pubblico come il plettro di una chitarra, e che aveva scritto una canzone intitolata «Sex with Your Parents (Motherfucker)», l’evoluzione era notevole.
Così come Reed prendeva dai suoi colleghi, in molti si ispiravano a lui. Brian Eno, musicista visionario e guru della produzione musicale, una volta disse che solo trentamila persone avevano comprato il primo disco dei Velvet Underground, ma poi ognuno di loro aveva fondato un gruppo. Reed è stato un precursore cruciale del punk, soprattutto della scuola newyorkese, e il suo lavoro con i Velvet ha forgiato la sensibilità rock di tutta la città: provocatorio nei testi e nella musica, intellettuale, arrogante, spudoratamente romantico. Patti Smith, in particolare, sembra aver plasmato la sua carriera seguendone l’esempio. Reed era sulla copertina del primo numero della rivista Punk. In Love Goes to Buildings on Fire, il libro che ho scritto sugli ecosistemi musicali della New York anni Settanta – un periodo rivoluzionario che avrebbe influito su una vasta gamma di generi musicali – parlo di Reed come di una figura rappresentativa e (a volte) come di un padre assente. Allo stesso modo di Miles Davis, è stato un punto di riferimento per tutti coloro che sono venuti dopo, un parametro di eccellenza e integrità: «Che farebbe Lou?» è un quesito estetico che qualunque musicista rock degno di questo nome poteva porsi a un certo punto della vita. Proprio come Miles Davis, Reed era irascibile, lottava contro un’attrazione irresistibile per gli stupefacenti e avrebbe seguito un’evoluzione creativa a tratti eccentrica, soprattutto negli ultimi anni, quando per lui la celebrità era diventata sia un handicap sia un vantaggio. Il college rock e la scena alternativa degli anni Ottanta si ispirarono enormemente ai Velvet. Da un punto di vista pratico, i gruppi composti da maschi e femmine emulavano il minimalismo della batteria che Moe Tucker suonava in piedi; le trance prismatiche delle chitarre di Reed e Morrison, i bordoni di viola di Cale, tanto consolatori quanto all’occorrenza aggressivi; e riprendevano la spoken poetry schietta delle migliori liriche di Reed, di volta in volta tenere, taglienti in modo seducente, finto-ingenue, violente, rassegnate, criptiche, in cerca del regno di Dio: «I’m gonna try for the kingdom if I can» è il secondo verso di «Heroin» dei Velvet Underground.
Anche il modo di presentarsi al pubblico e il personaggio in sé sono stati importanti. Nell’era dei gruppi rock che all’inizio erano vestiti con completi tutti uguali e poi si addobbavano come dei cowboy hippie, i Velvet indossavano abiti urban, dapprima in total black da hipster, in seguito da nerd adolescenti, con una breve parentesi in stile barocco anni Sessanta, grazie a Betsey Johnson, la prima moglie di Cale. Da avatar del glam rock, Reed impersonava il butch proto-dark vestito di pelle nera con lo smalto alle unghie, accanto all’affettazione high-femme di Bowie e di altri, secondo la tradizione del rock di fottersene dei generi: una consuetudine inaugurata tra gli altri dall’amatissimo Little Richard, e che così si sarebbe protratta fino al presente e addirittura al futuro, dal momento che gli artisti e le artiste transgender, non binari, gay ed etero continuano a ostentare la gloriosa varietà dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Più in là negli anni, Reed avrebbe creato un ulteriore archetipo con la sua incarnazione malefica, versione New York City, del maschio cis con la perenne sigaretta in bocca alla James Dean.
Ancora più importante del look era il modo in cui Reed gestiva in pubblico la sessualità. Probabilmente l’idea di essere considerato un profeta degli studi di genere lo avrebbe divertito, essendo stato tacciato di posizioni retrograde verso le persone queer e transgender in certe sue canzoni. Eppure Reed ha anche scritto alcuni dei versi più profondi sull’identità fluida in lingua inglese: «Candy Says» parla del sentirsi a disagio nel proprio corpo, un riferimento a Candy Darling, attrice trans e superstar della Factory di Warhol; in «Some Kinds of Love» canta: «No kinds of love are better than others» («Nessun tipo di amore è meglio di un altro»); ci sono la versione originale di «New Age» e l’album Berlin, con i loro triangoli amorosi bisessuali; e poi naturalmente la canzone per eccellenza, «Walk on the Wild Side», una serie di vignette ispirate alla tribù queer della Factory di Andy Warhol e al romanzo di Nelson Algren del 1956, A Walk on the Wild Side (in italiano, Passeggiata selvaggia), l’embrione di un musical poi abortito per il quale Reed avrebbe dovuto scrivere le canzoni, dopo l’uscita dai Velvet. Quell’embrione sarebbe diventato un modello di storytelling di canzone pop per dare visibilità alle persone emarginate di tutto il mondo.
Vale la pena ricordare che la prima traccia del primo demo di Reed (un nastro che aveva registrato, sigillato in una scatola, fatto autenticare e poi spedito a se stesso quando aveva una ventina di anni, una procedura che serviva a tutelare i diritti d’autore grazie al timbro postale) era una canzone folk scritta dal punto di vista di una donna: la ballata di un’orfana «spaventata» dai suoi corteggiatori che definisce «infedeli» e «sgradevoli», come del resto gli uomini in generale. Reed si immedesima nel personaggio come se si infilasse un vestito trovato nella soffitta della nonna: era affascinato dal femminile. Molte delle sue canzoni più belle incarnano una prospettiva femminile o fluida, e non è quindi un caso che molte delle cover migliori di Reed siano state fatte da donne, persone queer e artisti non binari: oltre alle interpretazioni di Nico, con o senza i Velvet, ci sono versioni di «Pale Blue Eyes» (Patti Smith, Marisa Monte, Lucinda Williams, Michael Stipe), «Candy Says» (Anohni, Shirley Manson, Thalia Zadek) e altre. Molte delle cose migliori e più profonde scritte su Reed sono opera di donne.
Reed reclamava il diritto di affermare esplicitamente o meno la propria identità sessuale. In un’epoca di ipercondivisione digitale, con una presenza culturale crescente della comunità lgbtq+ – ora fortunatamente tanto normale quanto radicale – può sembrare strano che un artista così mitizzato per la sua totale libertà espressiva si sia espresso raramente in merito. Reed viveva come gli pareva, senza rendere conto a nessuno. Era cresciuto nel mondo degli anni Cinquanta, che puntualmente, ancor più di oggi, esercitava violenza sui corpi queer, un mondo in cui fare coming out in modo plateale avrebbe messo a rischio la sua incolumità fisica e avrebbe avuto ripercussioni sulla sua carriera in quella sottocultura rock che, con i suoi rituali di machismo e omofobia, lo considerava parte della propria aristocrazia. Senza sminuire l’importanza di modelli queer significativi, l’insistenza di Reed sul diritto ad avere una vita privata si può interpretare come l’atto di emancipazione e di autotutela di una figura pubblica interessata a tenere certe parti di sé al di fuori del baratto commerciale della celebrità, delle transazioni considerate parte del lavoro del musicista pop. A ciò si aggiunga il fatto che, come molti di noi, Reed possedeva una sessualità fluida, impossibile da catalogare con definizioni nette, e che era cambiata nel corso del tempo, influenzata tanto dai partner che da altri fattori. Di sicuro non era un argomento di cui gli interessasse discutere con i giornalisti. Anche in questo caso ha dimostrato una certa preveggenza nell’utilizzare un’altra strategia imparata da Warhol, in apparenza controintuitiva in un’epoca in cui gli imperativi del complesso industriale dei social media vorrebbero convincerci del contrario: a volte la cosa più potente da fare è non dire niente.

Sylvia Reed e Lou Reed (per gentile concessione di Sylvia Reed)
Eppure ci sono state delle volte in cui Reed ha detto molto. Alla metà degli anni Settanta, la sua partner fu Rachel Humphreys – alta, avvenente, decisamente non binaria – che lo accompagnava in tour, agli eventi stampa e, almeno in un’occasione, cantò con lui sul palco (una cover di «Little Queenie» di Chuck Berry). In un’intervista del 1979, nel periodo in cui aveva iniziato una relazione con Sylvia Morales, una donna cis altrettanto bella e forte che sarebbe diventata la sua seconda moglie, un Reed piuttosto sfinito dichiarò: «Provo un grande risentimento a causa di tutti i pregiudizi nei miei confronti perché sono gay […] Come fa un gay a non impazzire?»
Sommata alla sua tendenza a scontrarsi con i giornalisti, la fluidità di Reed generava confusione in molti di loro, sconvolgendo la narrazione rock standard in cui lo avevano posizionato, e a cui si conformava quando ne aveva voglia. L’abbigliamento di pelle comprato a Christopher Street (la Main Street della New York gay) e gli occhiali da pilota erano scambiati per un look etero dalla maggioranza dei media. Gli altri però leggevano un messaggio diverso: «È stato la prima icona queer del ventunesimo secolo, trent’anni prima che iniziasse tutto», ha commentato Michael Stipe, frontman dei R.E.M. «Vedeva oltre e viveva fuori da una società stretta nella morsa della divisione rigidamente binaria e semplicistica tra etero e gay […] Qualsiasi figlio del ventunesimo secolo che rifiuta le convenzioni gli deve un momento di riflessione e un ringraziamento». La poeta Anne Waldman lo definì «il trickster non binario». La musica di Reed è l’esemplificazione di quanto afferma Sasha Geffen (sulla scia di Wayne Kostenbaum) in Glitter Up the Dark: How Pop Music Broke the Binary: «La divisione tra artista e fan scompare nel momento dell’ascolto appassionato, e con essa scompare anche la divisione tra i generi […] Nella musica le persone non sono separate, non possono essere divise in due categorie distinte».
Nel corso del tempo la reputazione artistica di Reed è diventata inseparabile dalle sue provocazioni culturali, e a volte quell’impulso corrosivo ha avuto la meglio su di lui. Era incline a compiacere il pubblico e, per il gusto di scioccare, esagerava alcuni elementi della sua musica adottando al contempo uno stile di vita sfrenatamente performativo. Una volta, con il registratore in funzione, ha dato a un giornalista dei consigli su come preparare pasticche di metanfetamina per potersele iniettare. Ma poi ha ritrovato l’equilibrio interiore, e anche se gli eccessi del passato hanno continuato a proiettare un’ombra su di lui, non hanno offuscato il suo lascito artistico. La caratteristica della produzione migliore di Reed – oltre alla temerarietà, la bellezza, l’intelligenza e quell’umorismo caustico tipicamente newyorkese – è ciò che per me la pone al livello artistico più alto, cioè l’empatia. Reed impersonava altre voci, non tutte piacevoli, alcune appartenenti all’«altra metà/la metà irredimibile» di cui parlava Federico García Lorca, un altro poeta che ammirava molto, in New York (Ufficio e denuncia). Quei nostri simili, a prescindere dal genere, parlavano per bocca di Reed, un ventriloquo compassionevole che sembrava sempre intento a comprendere se stesso e il suo soggetto. Quando si percepiva che Reed stesse scrivendo di se stesso – ad esempio in una canzone come «Waves of Fear», la descrizione più viscerale della tossicodipendenza allo stadio terminale e dell’inferno della sindrome d’astinenza che un musicista abbia mai inciso – sembrava che lo facesse per autocommiserazione e al tempo stesso come un esorcismo.
La scrittura di Reed era anche militante. Di regola, non era un autore esplicitamente politico, ma fin dai primissimi nastri e demo – la cover di «Blowin’ in the Wind» di Bob Dylan, uno dei musicisti che più lo hanno influenzato e in un certo senso un suo rivale; oppure l’evocazione della battaglia per i diritti civili in «Put Your Money on the Table» – ha messo in discussione lo status quo. Persino «Heroin», se la si ascolta con attenzione, è una canzone politica, quanto mai rilevante in un’epoca di interminabile crisi degli oppioidi. E naturalmente c’è New York, il suo disco più coerente e appagante, in cui attacca l’avidità, l’ipocrisia e la corruzione del sistema politico ed economico americano, e il suo influsso sulla vita dei ricchi e dei poveri per le strade della sua città. Reed non aveva paura di dire la verità anche in presenza del potere vero e proprio: quando si esibì alla Casa Bianca durante la presidenza Clinton, grazie all’ospite d’onore dell’evento, il presidente cecoslovacco Václav Havel (amico di Reed e grande fan dei Velvet Underground), cantò la strofa più saliente di «Dirty Blvd» con evidente piacere, nonostante l’amministrazione statunitense avesse cercato di censurare il suo set: «Give me your hungry, your tired, your poor I’ll piss on them. That’s what the Statue of Bigotry says», dicono i versi della canzone: «Datemi i vostri affamati, gli stanchi, i poveri e io gli piscerò addosso. Come dice la Statua dell’Intolleranza», con un gioco di parole tra liberty e bigotry. Decise tuttavia di non cantare «Sick of You», dallo stesso disco del 1989, brano in cui in modo esilarante e presciente criticava Rudolph Giuliani, all’epoca procuratore di New York e aspirante sindaco della città, immaginando una realtà distorta in cui una congrega di vigliacchi ordinava come sacerdoti i Trump.
Di sicuro Reed scriveva per esorcizzare i suoi demoni. Se le sue esplorazioni del femminile riflettevano altrettante esplorazioni dell’Io, lo stesso si può dire dei testi che parlavano di mascolinità, tossicodipendenza e altro ancora. Ha dissezionato le personalità violente e quelle di chi ha subito abusi da entrambi i punti di vista. Anche se sapeva essere straordinariamente gentile, amabile e generoso tanto con gli amici quanto con gli sconosciuti, l’impazienza e la cattiveria spesso hanno caratterizzato il suo personaggio pubblico. Notoriamente perfezionista, quando era contrariato poteva essere incredibilmente sgradevole – che fosse in un locale durante un soundcheck, in albergo o al ristorante – soprattutto negli ultimi anni, quando soffriva di diabete e di altri problemi di salute. Camerieri e addetti alla ristorazione di New York hanno un’infinità di storie da raccontare sulla sua maleducazione, e di sicuro nessuno avrebbe voluto trovarsi al posto della sua assistente personale quando gli scendeva la glicemia. Questo aspetto della sua personalità è entrato nel mito grazie alla sua leggendaria faccia da stronzo, in senso letterale e spirituale.
Ovviamente alcuni dei suoi bersagli se la sono cercata. Reed non era una celebrità alla Nora Desmond, la protagonista di Viale del tramonto di Billy Wilder, e reclamava il suo spazio nella città che amava. Lo si incontrava spesso per strada mentre portava a spasso il cane, oppure andava a un concerto, e intanto assaporava la città, quasi sempre senza guardia del corpo, ma con un’armatura di rabbia che lo proteggeva da generici molestatori e fan che potevano essere molto calorosi, se non addirittura completamente fuori di testa (se passate qualche ora a leggere le lettere dei fan conservate nei suoi archivi ve ne renderete subito conto). Questo atteggiamento sulla difensiva poteva essere dovuto al fatto che era stato un ragazzino basso, forse queer, con una leggera dislessia, che viveva nei quartieri malfamati di New York, mentre l’atteggiamento aggressivo durante le interviste scaturiva da esperienze negative e in parte rifletteva la pretesa non negoziabile di integrità. David Marchese, giornalista americano e grande intervistatore, scrisse un breve profilo di Reed in cui ricordava un loro colloquio non proprio cordiale: «Ho capito che il motivo per cui si è comportato in quel modo era che per lui la musica, le sue idee, la comunicazione erano molto importanti… Mi ha insultato e rimproverato, ma oggi ringrazio Dio che Lou Reed sia esistito».
In quanto suo biografo, questo discorso mi riguarda direttamente. Non ho conosciuto Reed di persona, anche se ci siamo incontrati un paio di volte e mi è capitato di incrociarlo per strada in città. Una volta l’ho intervistato per un pezzo sulla moglie Laurie Anderson pubblicato sul New York Times; ricordo che borbottò le risposte al cellulare mentre portava a spasso il loro cane Lolabelle per Lower Manhattan: «Dovrebbero farle un monumento», disse di Anderson; un’affermazione piuttosto incontestabile. Ho scoperto la musica di Reed quando ero un adolescente tanto secchione quanto delinquente negli anni Settanta e vivevo nella zona più a est del Queens, a circa quindici chilometri da Freeport, Long Island, dove era cresciuto lui. Ascoltavo i suoi pezzi alla radio e fu così che scoprii «Sweet Jane» (la magnifica versione dal vivo in Rock’n’Roll Animal, con quell’introduzione di chitarra esagerata) e ovviamente «Walk on the Wild Side» – canzoni in cui l’identità era presentata come qualcosa di mutevole e di malleabile. Quando al college scoprii i dischi dei Velvet Underground, ritrovai le stesse qualità e altre ancora. Per un giovane che si stava costruendo il proprio Io, sessualità compresa, le parole di Reed erano utili per scrollarsi di dosso le presunte certezze e sostituirle con delle possibilità, un cambio di prospettiva significativo che, come cantava in «Rock And Roll», un’altra delle sue celebri canzoni, poteva letteralmente salvarti la vita. Per me i Velvet Underground sono uno dei migliori gruppi rock, insieme ai Beatles, gli Stones, i musicisti della Chess Records, i Grateful Dead (che, proprio come i Velvet nella serata giusta, potevano fare jam session celestiali), e i testi migliori di Lou Reed sono all’altezza di quelli dei suoi colleghi.
La sua nutrita produzione solista è un’altra delle numerose riscoperte che devo a questo progetto. Da decenni amavo Transformer, plasmato da David Bowie, New York, persino Metal Machine Music, sia per l’atteggiamento sfanculante e spavaldo, sia per quell’assalto oceanico di ambient-noise. Altri dischi li avevo messi da parte a causa della produzione eccessiva o dei testi che sembravano un po’ tirati via. Ma la pratica artistica di Reed è stata incredibilmente coerente dall’inizio alla fine, che decidesse di appropriarsi del synth-rock sfoggiando un mullet nella speranza di entrare in rotazione su mtv, o che facesse teatro musicale d’avanguardia in tedesco insieme a Robert Wilson. Lo scopo era quasi sempre lo stesso: provare a fondere le gioie elementari ed estatiche del rock’n’roll con testi dalle grandi aspirazioni letterarie. Nessuno dei suoi progetti manca di maestria creativa.
Anche se i suoi dischi non sempre ebbero successo, Reed non smise mai di provarci. Comprendeva la riverenza che la gente nutriva nei confronti dei Velvet, ma lui continuava ad andare avanti. A posteriori alcuni dei suoi lavori più bistrattati – Berlin, Metal Machine Music, i progetti con Robert Wilson (compresa una rielaborazione delle opere teatrali di Wedekind con protagonista Lulù mai andata in scena negli Stati Uniti) e l’album con i Metallica che ne scaturì – formano una parte significativa della sua opera, e contribuirono a dare forma a un idioma cantautorale-multimediale in anticipo sui tempi. La carriera di Reed ha abbracciato virtualmente tutto l’arco del rock’n’roll, dalla nascita negli anni Cinquanta ai revival, fino alle fusioni e alle astrazioni del ventunesimo secolo. Era nato insieme a quella musica, ci è cresciuto insieme, hanno raggiunto insieme il loro apice, ha accompagnato il rock verso la sua mezza età e ha continuato a osservarlo mentre il genere assumeva nuove forme, e lui faceva altrettanto.
© Will Hermes, 2023 Published by arrangement with Farrar, Straus and Giroux, New York and The Italian Literary Agency
© minimum fax, 2023
Tutti i diritti riservati
In copertina: Lou Reed, 1968 (per gentile concessione della M.C. KostekVUAS).