Chi non ha il diritto alla propria intelligenza non ha alcun potere sul proprio futuro. Nel nuovo romanzo di Nicoletta Verna, pubblicato da Einaudi, ogni personaggio è chiamato a scegliere se rimanere ostaggio degli eventi, o muoversi nella propria direzione all’interno della Storia.
C’è una bambina cui il padre impone tutto, e un’altra che la madre esercita ad andare. C’è un mondo fermo dentro l’obbedienza del lavoro, e un altro che, recalcitrante, inizia a comprendere che saper imparare serve al domani. C’è una camicia nera come tante ce n’è state, e c’è un paese intero ridotto alla paura. C’è la violenza pubblica, e ci sono le atrocità private. C’è l’ascesa del fascismo, e c’è l’assurda insensata mole di dolore selvaggio che ha armato fratelli contro fratelli contro padri contro parenti contro amici. Per oltre vent’anni.
Coraggioso e senza sconti, un romanzo che si inoltra nel cuore dei meccanismi del male e del bene, e invita a centrarsi sulla possibilità – sempre presente – che, dimenticando il senso della catena di cause ed effetti, i margini della ferita si riaprano ancora sul corpo del nostro Paese. E ancora. E ancora.
Due sono le vite che il destino accomuna, due le infanzie (quella di Redenta, e quella di Iris), due i mondi possibili (la dittatura, la democrazia), due i principi (il maschile, il femminile), due i modi di essere uomini, due i sistemi di fare l’Italia.
Due sono le possibilità: subire, o scegliere di deragliare.
Forse la figura che meglio riassume, in tutta la sua dimensione critica, il cuore del nuovo romanzo di Nicoletta Verna, I giorni di Vetro, pubblicato da Einaudi, è proprio quella del bivio (e, insieme, del concetto suo speculare, l’incrocio).
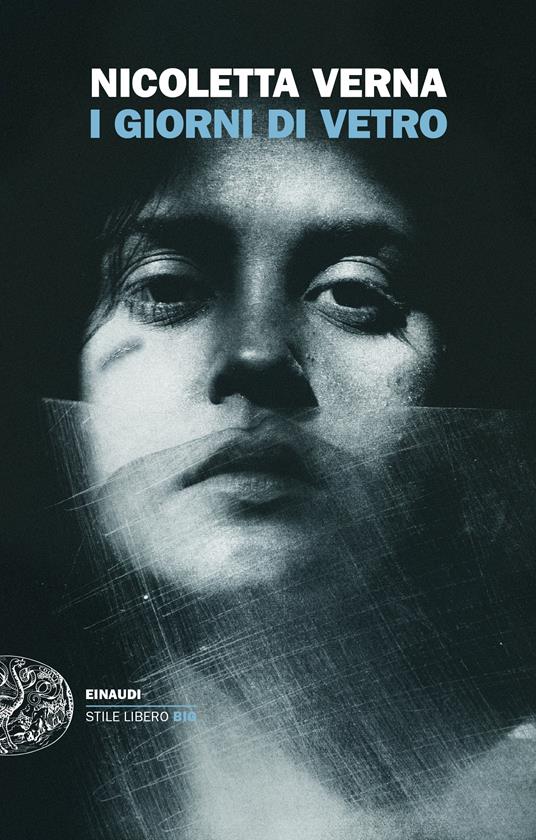
Non sono solo i personaggi di questa storia tesissima, infatti, ad esservi, ognuno a suo modo, costretti; ma è proprio il contesto del tempo in cui la vicenda è ambientata a rivelarsi per struttura (sociale, politica, etica) in tutta la sua conflittualità – una condizione nazionale mai, in fondo, davvero pacificata.
Ambiguità, doppio, e redenzione erano già stati il dispositivo alla base de Il valore affettivo, esordio della scrittrice pubblicato da Einaudi e già menzione speciale al Premio Calvino nel 2020 (un articolo si trova qui); e ambiguità, doppio e redenzione sono temi che tornano anche in questo nuovo romanzo, stavolta inseriti in un contesto storico tra i più neri, urticanti e scomodi della nostra storia italiana.
È il 1924, l’anno dell’omicidio Matteotti, il dopoguerra inquieto e feroce, le lotte operaie e l’ascesa del fascismo, le bande armate delle milizie e la fatica dei campi, la povertà ovunque e sempre. Un mondo fondato da uomini, governato da uomini, disegnato da uomini, forgiato da ideali mascolini e violenti, dove uomini incapaci di trovare risposte alla propria intima insoddisfazione necessitano di guide assolute, sicurezze di facciata, prevaricazioni libere, rituali collettivi con i quali giustificare (e santificare) la violenza privata.
Se scrivere significa anche inoltrarsi lì dove la luce è poca, e tutto si confonde, questo nuovo lavoro di Nicoletta Verna si spinge con coraggio dentro un’epoca di spaccature e vergogne profonde, nei confronti della quale la tentazione della rimozione è sempre grande: per trovare un senso serve un forte rigore, serve andare al primo movimento che ha innescato follia e dramma, tanto più se il vento della distruzione ha divelto una comunità intera.
Dove inizia tutto? dove è iniziato? Se lo chiedono, in più punti, i personaggi con l’angoscia della necessità: capire da dove è partita la lunga catena di cause ed effetti diventa fondamentale per riconoscere il peso delle responsabilità in un presente disumano:
Ora neanche il sangue contava e i padri s’ammazzavano coi figli e non esistevano fratelli, parenti, niente.
Siamo dunque a Castrocaro, nella campagna profonda e aspra, a seguire le vicende di una figlia già sbagliata in partenza: femmina (colpa, questa, non emendabile), quarto parto dopo tre non sopravvissuti, nata senza piangere in un giorno di lutto. Il minimo, è che alla purina (che per di più è bella) si accolli la scarogna, per fare il pari con il suo destino di irregolare.
E si ha un bel dire che i nomi sono la conseguenza delle cose, quando si incontra Redenta, la protagonista de I giorni di Vetro: vediamo la sua decisione bambina di rinunciare a parlare e di riacquistare parola, il suo sguardo obliquo sulla cattiveria quotidiana, il modo in cui sopravvive all’assenza della madre, ai danni con cui la polio le sfregia il corpo, al suo innamoramento segreto e totale per Bruno. E poi la vediamo, cresciuta innocente e delicata, sposata a Vetro, il demone di bella presenza, la camicia nera che se la prende per debito di sangue, poiché ha condiviso, in Africa, i misfatti italiani insieme al padre.
Al lato opposto della storia, su in montagna, a Tavolicci, in una comunità di qualche centinaio di anime dimenticate da tutti, dove la gente lavora e basta, nasce Iris: anche sua madre è una irregolare (sola studiata e per di più incinta) che in quel posto ha deciso di darsi un futuro, e di dare un futuro: impianta una scuola.
Con il suo fare perentorio, riesce a sistemarli sui banchi, uno a uno, le creature che hanno appena iniziato a camminare e i ragazzi di vent’anni. Nessuno di loro sa leggere, quindi il loro posto è quello: ai suoi occhi il mondo si divide fra coloro cui può insegnare qualcosa e chi può lasciare andare. Disegna sulla lavagna le lettere, i numeri, ripete le stesse cose cento volte finché pure i tardivi le hanno capite. È ostinata, caparbia, e sa che l’insistenza è il più nitido dei valori. Se un allievo manca da scuola lei si presenta di persona alla porta di casa, nel caso litiga con i genitori, che gliela dànno vinta, perché anche se una è donnina alta un metro e mezzo incute rispetto. La sera sposta i libri e dorme lì, rannicchiata sui banchi, con una coperta addosso, senza pretese.
Bambine, Redenta e Iris assorbono la disciplina delle parole: Redenta di quelle favolose e curative della nonna, Iris quelle strutturanti della madre. Ma mentre il destino di Redenta viene deciso dal padre, che la fa sposare al suo compagnone d’armi, Iris, dalla madre, viene mandata a Forlì, a lavorare nella città grande, lontana e libera e affidata alla propria intelligenza.
La condizione più infida che esiste non è la tirannia, ma l’illusione della libertà
Ed è così che cominciano, i giorni di Vetro: dentro la guerra che non finisce, e il fascismo che non finisce, e l’Italia spaccata, e le bombe, e le radio clandestine, e l’organizzazione della resistenza, e il veleno omeopatico della delazione e del sospetto che tutto guasta, e gli agguati e le torture e i morti. Più la situazione si fa disperata, maggiore è la stretta del controllo dei gerarchi e dei vari capetti locali.
La paura aveva sfigurato i castrocaresi, rendendoli simili alle bestie, ignari e obbedienti solo all’istinto: la fame, la sete, il sonno. Non erano più padroni di loro stessi e l’unica cosa che speravano era di non essere i prossimi, perché Vetro poteva arrivare da chiunque, con qualunque scusa, senza distinguere se uno era innocente o colpevole.
Sul bene e sul male, sul loro senso profondo di contesto e di causalità, molte volte il libro di Nicoletta Verna invita a ragionare. Non è certo un caso, poiché proprio questo è un altro tema forte del romanzo.
Succede, infatti, che il nostro sguardo di lettori finisca per concentrarsi su Vetro: aguzzino sadico e patologico, che esercita ogni forma di sevizia per capriccio e per volontà di potenza. Vetro ha la sapienza magnetica dei peggiori demoni maschi della letteratura di tutti i luoghi e di tutti i tempi: in coda agli Egidi, agli Esteban Trueba, ai Pedro Paramo, agli incubi alfa alfa di questo e degli altri continenti.
È quello che dall’Africa si porta come souvenir la testa di una donna mummificata, naturalmente uccisa di propria mano, e che la impone come terza presenza fissa nella camera da letto dove sottopone Redenta al peggior sadismo fisico e psicologico immaginabili. La macellazione quotidiana, l’espropriazione della dignità, la schiavitù sono talmente insostenibili e ripugnanti e ingiuste che si arriva perfino ad augurarsi che Redenta vi si sottragga anche, magari, addirittura, morendo.
Invece: resiste, perché così le è stato insegnato. Resiste senza chiedersi: perché.
Ero buona solo a fare questo: il mio dovere, e non mi domandavo niente, se era giusto o sbagliato, buono o cattivo.
Finché, appunto, non arriva il momento di domandarsi del bene e del male – e qui, nella dimensione della prospettiva, e non solo degli eventi, il romanzo rivela tutta la sua urgenza di guardare, una buona volta, fino alle radici del male.
Perché il male esiste per accidenti, come è il caso di Vetro, ma è ben più temibile quando esiste per struttura, e assume le forme di un padre che genera, determina, decide, distrugge. Così è, il padre di Redenta: Primo (sempre i nomi, si diceva, come conseguenza delle cose), l’irriducibile e (lui sì) mai redento; rancoroso, ignobile, egoriferito, brutale a vanvera, grosso coi deboli ma pronto a scappellarsi con quelli più forti di lui, invasato di fascismo e perdutamente innamorato del suo ducetto sbraitante impegnato ad assumere maschie pose monumentali ad uso dei posteri.
Primo che, con tutto ciò che verrà in questa storia perduto, sarà l’unico a rimanere incrollabilmente uguale a sé stesso.
Il romanzo di Nicoletta Verna parla di noi: di ciò che l’Italia è stata, soltanto cento, ottant’anni fa, dentro una dittatura che ha armato fratelli contro fratelli.
E parla, attraverso il passato, di cosa accade quando si permette (per incapacità, per conformismo, per ignavia, per ignoranza, per sconfitta, per grettezza, per impotenza, per adesione) che la crudeltà esibita si faccia sistema. Anche oggi.